Il 1° aprile è uscito un comunicato nazionale sottoscritto da diverse componenti del sindacalismo di base e collettivi di operatrici e operatori sociali sulle condizione di lavoro al tempo dell’emergenza Covid-19 nei servizi pubblici esternalizzati (risultato delle politiche neoliberiste cominciate alla fine dei ruggenti anni Ottanta). Il documento mette in evidenza i principali problemi, sanitari ed economici, del settore e chiede che il lavoro venga rimodulato in maniera sostenibile e utile, sia per gli utenti dei servizi che per operatrici e operatori; un altro punto fondamentale è la richiesta del 100% del salario come previsto dal cosiddetto decreto “Cura Italia” del 17 marzo (art.47-48). Ne abbiamo parlato con Matteo Maserati, educatore e delegato sindacale di Sial Cobas, tra gli animatori della Rete delle Operatrici e degli Operatori Sociali di Milano e della Rete Nazionale Operatori Sociali.
A partire dall’emergenza in corso, emergono diverse questioni più ampie e strutturali: il persistente oscuramento della rilevanza della riproduzione sociale, la contraddizione tra il tempo e la profondità implicati dall’esperienza e dal lavoro della cura e la fredda contabilità burocratica con cui essi vengono misurati attraverso “il minutaggio degli interventi”, la lenta e continua costruzione di una soggettività politica delle lavoratrici e dei lavoratori della cura.
* * * * *
Prima di parlare della situazione di queste ultime settimane, è bene cominciare facendo un passo indietro. Qual era la condizione lavorativa degli operatori sociali nei servizi esternalizzati alla vigilia di questa pandemia?
Direi che il punto di partenza è il sistema delle esternalizzazioni dei servizi su cui si regge da trent’anni la gran parte dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari: il pubblico affida al privato sociale la gestione dei servizi attraverso bandi, accreditamenti e gare d’appalto, secondo logiche di risparmio e delega della gestione.
È un sistema che provoca una grande frammentazione di condizioni, con le sue conseguenze sui lavoratori e sui cittadini utenti dei servizi. Già prima dell’emergenza, c’era una grande diversità di regole e di sensibilità da Comune a Comune e da Regione a Regione. L’esempio più classico è che, per bandi relativi a un medesimo servizio, ci siano comuni, magari confinanti, di cui uno prevede un monte ore retribuito per la programmazione del lavoro, per le riunioni di équipe e per tutto quel pezzo di lavoro fondamentale per la qualità del servizio (le cosiddette “ore indirette”) e un altro no, oppure molto meno. E questo vuol dire, per gli operatori, vedersi o meno retribuiti del lavoro che comunque tu come professionista, in un modo o nell’altro, devi fare.
E su questo devo dire che c’è una crescente consapevolezza che gira nelle stanze dei Comuni stessi: dopo 20-25 anni di questa sperimentazione non solo emergono le contraddizioni ma anche si stanno facendo delle valutazioni a livello di funzionalità e di qualità, da più parti… non è un sistema così efficace e che garantisce tutta questa qualità.
Che cosa garantisce allora il sistema dell’esternalizzazione?
Garantisce risparmio di denaro e allontanamento alle responsabilità politiche in tema di educazione, salute, assistenza, inclusione, per gli enti locali ecco tutto: un risparmio pagato dagli operatori e dagli utenti dei servizi. In questo modo infatti gli enti locali non hanno un carico di gestione, delegano al privato sociale anche il trattamento di migliaia di lavoratori, e qui arriviamo al tema del contratto: con le esternalizzazioni si applicano contratti peggiorativi rispetto al contratto degli Enti Locali: se è vero che i servizi continuano ad essere sostenuti principalmente da fondi pubblici, i contratti sono però quelli del privato sociale. Questi, a loro volta, sono polverizzati: una decina di contratti differenti, tra quelli conosciuti, ma poi ci sono anche contratti ad hoc: l’ente gestore X s’inventa un contratto tutto suo, ulteriormente peggiorativo rispetto a quelli maggiormente diffusi.
Due tra i contratti più diffusamente utilizzati sono stati da poco rinnovati. Com’è andata quella vicenda?
È andata molto male. Si tratta del contratto delle cooperative sociali (rinnovato a giugno 2019) che si applica a 350 mila lavoratori e lavoratrici e del contratto UNEBA (febbraio 2020) che tocca altri 70 mila operatori e operatrici. Entrambi erano scaduti da 7 anni ed il rinnovo è avvenuto con trattative a porte chiuse, tra i firmatari, con i sindacati confederali. E’ avvenuto dopo mobilitazioni, scioperi e presidi e, ancora più importante, dopo l’elaborazione di una piattaforma condivisa da parte di sindacati di base e collettivi: una piattaforma che è stata portata sul tavolo delle centrali cooperative dopo essere stata discussa con migliaia di lavoratori. Le questioni più importanti che ponevamo sono state raccolte strumentalmente nel nuovo contratto, solo per essere poi demandate al secondo livello territoriale e aziendale: cosa che in un settore poco sindacalizzato vuol dire lasciarle alla contrattazione aziendale, di cooperativa in cooperativa o addirittura di servizio in servizio. Stiamo parlando di questioni importanti quali lavoro notturno, part-time ciclici verticali, uso banca ore.
Se questo è il punto di partenza, ricostruiamo ora la situazione che si è creata a partire dallo scoppio dell’epidemia Covid 19.
Dunque, i servizi di educativa scolastica sono stati i primi ad interrompersi alla fine di febbraio, mentre altri servizi, per esempio i centri diurni per i disabili sono arrivati a chiudere, a volte sotto forti pressioni dei lavoratori stessi, perché le istituzioni regionali non intervenivano, più tardi, metà marzo. Possiamo dire che fino al decreto Cura Italia del 17 marzo, non c’è stata tutela della salute nei luoghi di lavoro, con effetti nefasti sulla salute di utenti e operatori; il “caso nazionale” delle R.S.A. di cui si sta molto dibattendo rientra in queste dinamiche di esternalizzazione e intervento insufficiente e disomogeneo degli enti pubblici.
E poi cosa è successo?
Via via che i servizi chiudevano, si è posto il problema di cosa sarebbe successo ai lavoratori che rimanevano a casa: gli enti locali avrebbero continuato a pagare le cooperative? Oppure avrebbero sospeso i pagamenti perché i minuti e le ore di servizio, su cui si basano i pagamenti delle rette, non venivano lavorati?
Come scriviamo nel nostro comunicato, l’articolo 48 del Cura Italia dice che gli enti Locali (enti appaltanti) possono – ma non sono obbligati a – erogare fino al 100% del contributo, a patto che gli enti gestori rimodulino gli interventi e mantengano attive le strutture del servizio, ovvero siano pronte a riaprire appena possibile. Dunque abbiamo una legge quadro nazionale che dà la possibilità di arrivare fino al 100% del finanziamento ai Servizi ma poi sostanzialmente lascia mano libera ai singoli enti locali. Pochi Comuni hanno seguito l’indicazione del 100%, mentre la maggior parte dice: riprogettate e rimodulate l’intervento, a distanza, mi mostrate cosa fate veramente, “quante ore”, con utenti e famiglie, senza tenere conto del grosso lavoro di preparazione di queste “ore erogate” – e poi noi vi paghiamo solo per queste ultime; il resto sarà ammortizzatore sociale al 60-65% per chi è assunto come dipendente.
Quali problemi ne derivano?
Ne deriva un’ulteriore frammentazione delle condizioni, addirittura a livello individuale: tieni conto che ci sono cooperative che lavorano su più territori e magari all’interno dell’orario di un singolo educatore ci sono interventi da svolgere in Comuni diversi che in queste settimane hanno preso decisioni diverse: dunque un pezzo del monte ore salta, un altro pezzo è ridotto, un altro ancora continua normalmente. Così si aggrava quella grande disomogeneità di partenza: la situazione si frammenta in base al servizio e al territorio in questione e questa frammentazione coinvolge sia l’orario di lavoro del singolo operatore, la sua possibilità di organizzarsi la vita e avere un salario decente, sia il diritto di assistenza di utenza fragile che in questa fase potrebbe aver maggiormente bisogno di punti di riferimento.
Per questo quello che noi rivendichiamo in tutte le tipologie di servizio è l’erogazione del massimo di riconoscimento economico a fronte di tutte le modalità lavorative possibili in questo momento, che vorrebbe anche dire riconoscere che il nostro lavoro è fortemente fatto di un lavoro indiretto di programmazione degli interventi.
Puoi fare un esempio di come avviene la rimodulazione degli interventi? Partiamo dai servizi socio-sanitari…
I servizi socio-sanitari dipendono sia dai Comuni che dalle ATS (ex ASL, dipendente dalla Regione). Prendiamo per esempio i centri diurni per persone disabili. Qui normalmente si lavora e si viene pagati sulla base di interventi stabiliti attraverso le schede S.i.DI (Scheda Individuale Disabile) con minutaggio degli interventi. Vuol dire che, sulla base di una serie di parametri, la scheda di ciascuna persona che frequenta il servizio definisce il numero di minuti di assistenza per cui la Regione e i Comuni pagano l’ente gestore che eroga il servizio: a questa scheda e alla sua compilazione e aggiornamento è quindi connesso il pagamento delle rette da parte di Regione e Comuni. Questa misurazione dei minuti è la “normalità”.
Come cambia questo sistema con pandemia in corso?
Ora abbiamo dovuto riprogettare gli interventi, con una riduzione massiccia del tempo di relazione diretta con gli utenti, che è quello che le convenzioni e le schede tecniche in gran parte si limitano a misurare. Ci chiedono di fare “progetti di emergenza” che poi vengono analizzati in modo minuzioso: con quali obiettivi, quali modalità, quali strumenti, quanti minuti. Nel caso dei disabili tieni conto che con alcuni puoi proporre di fare delle attività anche interattive e di lavoro in streaming, sia di respiro creativo che di stimolazione cognitiva o motoria; con altri si tratta di inventare tutta una serie di materiale specifico di stimolazione sensoriale: vista, tatto, udito. Poi c’è la questione del rapporto di co-progettazione con le famiglie, su cui c’è stato nel tempo molto parlare, anche a livello di formazione e questo sarebbe il momento in cui lavorarci davvero perché molto sta nelle mani dei famigliari: gli educatori potrebbero aiutare nella costruzione di una routine quotidiana e di una metodologia di lavoro e di gestione delle attività specifiche.
Si tratta dunque di inventarsi un nuovo lavoro, di formarsi – insomma anche di spenderci molto tempo.
Esatto. Quel pezzo di lavoro che riesci a fare con le persone è una cosa nuova che non hai mai fatto: te lo devi inventare, e dunque ti richiede un tempo di preparazione molto elevato, a volte più lungo di quello della sua realizzazione: si tratta di quelle ore indirette di cui parlavo prima e che in molti nostri contratti non sono riconosciute o sono riconosciute in modo insufficiente: ora è proprio quel tipo di lavoro che aumenta, mentre le schede che ci chiedono di compilare per “misurare” il nostro lavoro non riconoscono questo sforzo: tagliano le ore retribuite e aumentano quelle che vengono coperte dagli ammortizzatori sociali, che coprono solo una percentuale ridotta del salario, a fronte delle nostre basse paghe orarie.
E nell’educativa scolastica?
Nell’educativa scolastica la riprogettazione avviene tra Comune, ente gestore e scuola. Quello che sta succedendo è che a molti operatori viene ridotto di molto il monte ore, con l’effetto di negare agli utenti disabili lo stesso diritto di continuità didattica riconosciuto al resto degli studenti. Per noi l’importanza del lavoro educativo, dovrebbe tradursi molto di più nell’utilizzo di un monte ore per la programmazione, la formazione e il coordinamento con altre figure professionali. Dovremmo avere ore sia per partecipare ai momenti in cui gruppo classe è riunito, sia per interventi individuali. Bisognerebbe prevedere un lavoro a distanza progettazione-programmazione tra docenti, educatori e famiglie.
Dunque, con la rimodulazione, un educatore può rendicontare, e dunque vedersi retribuite, meno ore, mentre vede aumentare il carico di lavoro non retribuito (programmazione, ecc.). Cosa succede per la quota di salario legata alle ore non rendicontate?
Sulla quota di ore previste nel contratto ma non rendicontate, intervengono gli ammortizzatori sociali. Ma anche qui ci sono dei problemi. Da un lato il decreto Cura Italia ha ampliato a categorie che possono accedere agli ammortizzatori sociali (FIS o cassa integrazione); dall’altro la versione ufficiale di imprese e sindacati confederali secondo cui gli ammortizzatori sociali dovrebbero coprire l’80% della quota di ore non lavorate non è corretta. Studiando il sistema di calcolo dell’ammortizzatore sociale, infatti, si scopre che questo dipende dalla paga oraria effettiva e per noi, essere pagati con l’ammortizzatore sociale, vuol dire prendere il 60-65% del salario per la quota di “non lavoro”. Crediamo che la nostra rivendicazione del 100% del salario sia giusta e crediamo anche che questa richiesta agli enti di erogare i fondi che già avevano stanziato necessita di un’azione sostenuta e coordinata attraverso l’organizzazione sindacale dei lavoratori lavoratrici.
Un altro insieme di questioni riguarda gli operatori che continuano a lavorare e quelli che vengono ora richiamati al lavoro per i servizi che riaprono o per quelli nuovi legati alla “fase 2” della gestione della pandemia. Ricordiamo quello che è successo nelle strutture residenziali e sanitarie in generale, con più di 100 morti tra il personale sanitario e socio-sanitario tra medici di base, ospedalieri, operatori socio-sanitari.
Per noi la rivendicazione è molto chiara: ovvero il massimo della tutela della salute. “100% salute, salario, dignità. Ancora oggi, 16 aprile, i protocolli sanitari spesso non ci sono o sono inadeguati alla situazione.
I DVR (documento valutazione rischi) aziendali devono essere riaggiornati alla luce di questa situazione – senza contare il problema fondamentale che non c’è disponibilità di DPI.
C’è poi l’obbligo per le aziende di formare il proprio personale rispetto alle strategie per svolgere in sicurezza il lavoro in queste condizioni.
Infine chiediamo che sia gli operatori che chi riceve assistenza e intervento sia sottoposto a tamponi, altrimenti i servizi continueranno ad essere un luogo di contagio e di diffusione del virus. E questo riguarda sia le strutture residenziali che i servizi domiciliari.
Il vostro documento è il punto d’arrivo di un percorso intersindacale lungo e coinvolge anche comitati auto-organizzati. Che situazione vedi in una categoria come quella degli operatori sociali che è molto poco sindacalizzata e nella quale spesso lo spirito di dedizione e l’impegno nelle relazioni di cura viene usato strumentalmente per giustificare condizioni di lavoro iper-precarie?
In questa fase, nonostante la distanza fisica tra lavoratori e lavoratrici così come tra lavoratori e utenti, ci sono cose importanti che si stanno muovendo: si stanno costruendo assemblee aziendali, regionali e nazionali in cui si stanno incontrando operatori e operatrici che non si erano incontrati finora. Stanno lavorando insieme pezzi di diversi sindacati. Qui, in maniera condivisa si stanno costruendo forme e tipologie nuove di denuncia, rivendicazione e proposta. Sono usciti comunicati condivisi, come quello di cui abbiamo parlato, ma anche campagne online, video e tutorial, mailbombing verso gli enti locali che si sottraggono alla responsabilità di garantire condizioni di lavoro dignitose e giuste. Invitiamo perciò tutte e tutti sia a coordinarsi con le realtà organizzate esistenti sia a costruire rappresentanze sindacali dei lavoratori nei propri posti di lavoro!







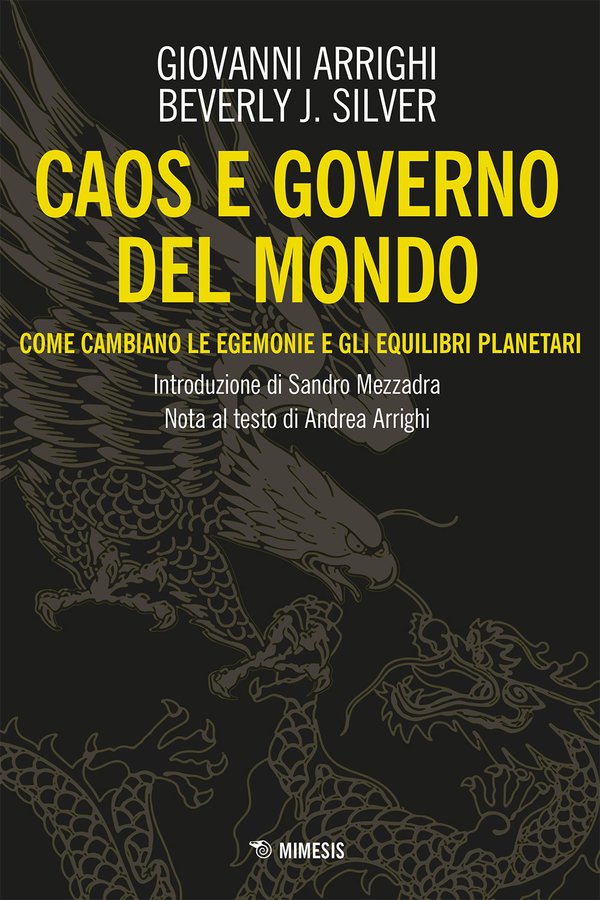
[…] 1 https://altralamezia.org/2020/05/27/lavoro-o-non-lavoro-in-tempo-di-covid-19-la-testimonianza-di-medico/. 2 – 3 http://www.anaao.it/public/aaa_8532909_to_albanese_anaao.pdf. 4 – 5 http://effimera.org/operatrici-e-operatori-sociali-nella-crisi-nuove-precarizzazioni-e-nuove-lotte-i…/. […]