La Cina ha dichiarato una crescita del 5,3 per cento anno su anno nel primo trimestre del 2024, le previsioni dei cosiddetti analisti internazionali dicevano 4,9, quindi apparentemente va tutto più che bene. Tuttavia, il problema è che per l’ennesima volta la crescita è trainata da investimenti (infrastrutture e settore manifatturiero soprattutto) ed export, mentre restano al palo i consumi, con le vendite al dettaglio che hanno continuato a rallentare.
Sostanzialmente, mentre c’è un consenso tra la maggior parte degli economisti sul fatto che una crescita sostenibile del Pil in Cina richiederebbe un ruolo più forte dei consumi nel guidare la crescita rispetto a investimenti e surplus commerciale, negli ultimi tre mesi è accaduto esattamente il contrario, in linea con il recente passato.
C’è da scommetterci: dato che si tratta di una profezia che si autoavvera, la Cina riuscirà a raggiungere il suo obiettivo di crescita del Pil per il 2024 di “circa il 5 per cento”, stabilito alla recente doppia sessione dei parlamenti cinesi e analogo a quello dello scorso anno; ma solo facendo affidamento sulle cose che da almeno un decennio Pechino dice di voler smettere di fare. E naturalmente – essendo l’export una delle voci principali della crescita cinese – una delle conseguenze sarà un ulteriore deterioramento delle relazioni commerciali globali, con un ritorno a forme anche abbastanza esplicite di protezionismo da parte della Ue, oltre che degli Usa.
Il grattacapo cinese che si trasforma in grattacapo globale non consiste quindi nella fandonia tutta politica che dispensano i tutori dell’ordine liberalcapitalista, per cui Pechino vorrebbe esportare “il proprio modello antidemocratico”; bensì nel fatto che l’incapacità di sciogliere i propri nodi economici strutturali si traduce in un’altra esportazione: quella della propria sovrapproduzione, il che dà luogo (insieme ad altri fattori più politici) alle guerre commerciali.
Il 16 aprile, parlando con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita a Pechino, il leader cinese Xi Jinping ha ribadito che gli occidentali ostili all’aumento delle esportazioni cinesi non tengono conto del ruolo che tali esportazioni stanno svolgendo nel combattere sia l’inflazione (cosa che succede da almeno 30 anni) sia l’emergenza climatica: rivendicazione nuova, questa, dovuta al fatto che la Cina esporta oggi sempre meno carabattole e sempre più tecnologie, tra cui quelle verdi: veicoli elettrici, batterie al litio, pannelli fotovoltaici, etc.
Tra parecchi osservatori stranieri si insiste da anni sul fatto che la Cina dovrebbe risolvere il problema trasferendo sempre più quote di ricchezza dalle grandi imprese di Stato alle famiglie, riducendo così la loro propensione al risparmio e aumentando i consumi, in direzione di quell’enorme mercato interno che renderebbe meno essenziale il ricorso a export, infrastrutture e immobiliare, per garantire la crescita. Il caso forse più esemplare è quello di Michael Pettis, che insegna all’Università di Pechino e che ne scrive un giorno sì e l’altro pure su “X”, dedicando al problema anche un libro: Le guerre commerciali sono guerre di classe (Einaudi, 2021). Ma anche Paul Krugman ne ha parlato sul New York Times.
Il fatto nuovo è però che ormai sempre più cinesi sposano la teoria della crescita “drogata” e della necessità di spostare il baricentro della ricchezza verso i consumi delle famiglie, anche per raggiungere quella “prosperità condivisa” (gongtong fuyu) che è uno dei cavalli di battaglia di Xi Jinping e che nelle intenzioni dovrebbe essere realizzata entro il 2035, dopo che nel 2020 si è raggiunto l’obiettivo della “società del benessere moderato” (xiaokang shehui), almeno nelle dichiarazioni ufficiali. È d’altra parte ormai dottrina di Stato la “doppia circolazione” (guonei guoji shuang xunhuan, alla lettera “doppia circolazione nazionale ed internazionale”), cioè il fatto che si debba dare priorità ai consumi interni pur rimanendo forti nel commercio internazionale.
A marzo, Zhang Jun, preside del dipartimento di economia dell’università Fudan di Shanghai (una delle più prestigiose), è uscito pubblicamente proponendo un “Piano di raddoppio del reddito familiare” (jiating shouru beizeng jìhua) che ricalca analoghe misure degli anni Sessanta in Giappone.
In sostanza, Zhang propone di:
- aumentare i redditi reali delle famiglie attraverso politiche fiscali adeguate. “Questo approccio dovrebbe includere un aumento significativo dei trasferimenti alle famiglie, che comprenda l’assistenza all’infanzia, l’istruzione di base e i servizi sanitari sostenuti dal governo, insieme all’assistenza medica gratuita o sovvenzionata per bambini e anziani”, scrive Zhang Jun. Se non è un welfare state, poco ci manca.
- Fare degli “swap” tra governi locali e centrali per quanto riguarda il debito. I governi locali cinesi sono cronicamente indebitati perché la maggior parte del gettito fiscale va al governo centrale, mentre la maggior parte delle spese tocca a loro, quindi cercano di finanziarsi attraverso la concessione di terreni ai palazzinari (non vendita, in Cina la terra resta pubblica), ma la bolla immobiliare crea nuovo debito.
- Spingere sulla crescita dei salari nominali, affinché siano almeno pari alla crescita del Pil.
- Attuare una liberalizzazione del mercato, affinché ci sia una migliore riallocazione delle risorse verso le imprese “virtuose”. Insomma, si tratta di un messaggio abbastanza esplicito per dire che non bisogna più sussidiare certi baracconi di stato per ragioni puramente politiche.
Ancora più significativo è che di recente si è espresso sulla necessità di trasferire reddito anche Lou Jiwei, ex ministro delle Finanze e attualmente consigliere del governo centrale, il quale punta esplicitamente il dito contro la “struttura economica duale urbano-rurale” (chengxiang eryuan jingji jiegou) della Cina: dato che sia il sistema di gestione del territorio (per esempio la proprietà delle terre) sia quello del welfare (pensioni, istruzione e sanità, soprattutto) sono diversi a secondo che un luogo sia classificato come urbano o rurale, esistono di fatto “due Cine” parallele e un gap sempre crescente tra città e campagna in termini di redditi e consumi.
Si consideri che l’attuale reddito medio disponibile è di circa 51.800 Rmb (6.700 Euro) nelle aree urbane e di circa 21.700 Rmb (2.800 Euro) nelle aree rurali (rispetto ai circa 20mila Euro nell’Unione Europea, 27mila in Italia).
Il simbolo e dispositivo cardine di questa Cina duale è il sistema dello hukou, il certificato di residenza che lega le famiglie (non è individuale, è familiare) ai propri luoghi d’origine e da cui dipendono diritti e servizi, come la scuola per i figli, l’accesso alle cure mediche e le pensioni. Considerando che ormai il 64 per cento della popolazione cinese vive in città, ma che solo il 45 per cento ha l’hukou urbano, ne risulta che parecchi dei circa 292 milioni di lavoratori migranti cinesi non hanno accesso agli stessi servizi pubblici – che vanno dall’assistenza medica all’istruzione – a cui hanno accesso i residenti delle città. Un tempo il sistema era funzionale a creare l’enorme esercito industriale di riserva a basso costo che rendeva competitive le merci cinesi sui mercati internazionali. Oggi, nell’epoca in cui si punta invece sul mercato interno, non più.
Tuttavia, secondo Lou, il miglior modo per mettere definitivamente fine al gap urbano-rurale è introdurre una tassa sulla proprietà immobiliare, seppur con estrema cautela, visto che il mercato del mattone è già in crisi di suo.
Il dibattito su come rilanciare l’economia senza creare bolle speculative e debito, riducendo al tempo stesso la diseguaglianza sociale e spostando risorse verso le famiglie, non fuoriesce in genere dalle soluzioni compatibili con il mercato e ha quasi sempre un fastidioso retrogusto paternalista che ben si adatta a tenere insieme ragioni del capitale e tradizione cinese: non si mettono in discussione le gerarchie, ma la diseguaglianza si giustifica solo se è finalizzata al bene di tutti, con l’imperatore che è garante di questa “armonia tra cielo e terra”.
L’imperatore in questione – cioè Xi Jinping – ha finora percorso la via del paternalismo autoritario, “suggerendo” per esempio alle grandi imprese tecnologiche che si sono smodatamente arricchite senza controlli negli ultimi dieci anni, di costituire fondazioni e organizzazioni caritatevoli come spin-off della propria attività.
Il punto è che nello stato sviluppista cinese[1], il welfare (ipotetico) è inteso soprattutto in chiave utilitarista: da un lato, come strumento per ridurre le tensioni sociali e ogni rischio di destabilizzazione; dall’altro, come abbiamo detto, in quanto possibile dispositivo per ampliare la domanda interna.
In questo contesto, c’è margine per un (sempre ipotetico) reddito di cittadinanza (UBI) con caratteristiche cinesi?
Apparentemente no, anche se qualcuno sostiene che la Cina potrebbe sorprenderci. Esperimenti di UBI si sono verificati a cavallo tra il 2008 e il 2011 nei territori ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macao, mai in Cina continentale, e soprattutto sono sempre stati intesi come misure anti povertà sempre reversibili in base al budget delle autorità locali.
In una discussione, mi sono sentito dire: “Non riesco a pensare a qualcosa di meno asiatico-orientale del reddito universale di base”. In questa rigida rappresentazione di un presunto volksgeist d’Oriente, c’è comunque l’idea diffusa che il reddito base sia una cosa da “fannulloni” del tutto contraria all’ancestrale materialismo delle culture confuciane che induce all’operosità (con relativa meritocrazia annessa). Anche parecchi intellettuali “di sinistra” cinesi sostengono esplicitamente che lo “spirito rivoluzionario” suscitato dal Partito comunista – che si traduce in mobilitazione di massa – si sia trasferito dalla Cina maoista a quella di Deng Xiaoping sotto forma di energia delle forze produttive da sguinzagliare nell’economia di mercato.
Dal canto suo, Xi Jinping ha riconfermato più volte la sua avversità ai cosiddetti “sdraiatisti” (tangping), cioè i giovani che rifiutano uno stile di vita orientato alla frenetica competizione, e sinceramente anche io ho seri dubbi quando si pretende di estendere l’idea di “grandi dimissioni” alla Cina. Gli “sdraiatisti” sono al momento un fenomeno di nicchia, prettamente urbano, è presto per identificarlo come una tendenza di lungo periodo.
Anche lo United Nations Development Program si è espresso sull’insostenibilità di un UBI in Cina, calcolando che se si desse a ogni cinese un reddito base mensile di 267 Renminbi (circa 35 euro, che nelle grandi città cinesi è pressoché nulla), il costo complessivo sarebbe di circa 4,5 trilioni di Rmb, cioè un quarto del gettito fiscale. Nella consueta lettura culturalista, si sostiene inoltre che i soldi dell’UBI non rientrerebbero nell’economia sotto forma di consumi, perché “sulla scorta della cultura tradizionale cinese, le persone continuerebbero a lavorare, accumulando in forma di risparmio l’indennità del reddito di base”. Il consiglio che ne discende è quindi quello di rafforzare gli esistenti programmi di assistenza sociale.
In definitiva, quello che appare dallo stato presente delle cose è che nella sua rincorsa lunga più di un secolo per raggiungere livelli si sviluppo e benessere assimilabili a quelli dei “barbari” che arrivano da Occidente, la Cina stia ancora una volta puntando più sul lato dell’offerta che su quello della domanda; più sul “salto tecnologico” – cioè scalare la catena del valore con prodotti ad alto contenuto innovativo – che sulla redistribuzione della ricchezza. Tuttavia, il dibattito sullo sviluppo del mercato interno è ormai pane quotidiano e difficilmente potrà restare per sempre una mera questione di paternalismo imprenditoriale “suggerito” dallo Stato.
NOTE
[1] Nel tracciare la storia economica della Cina contemporanea, il collettivo Chuang analizza il passaggio da “regime sviluppista socialista” a “sviluppismo capitalista” in due articoli: https://chuangcn.org/journal/one/sorghum-and-steel/;


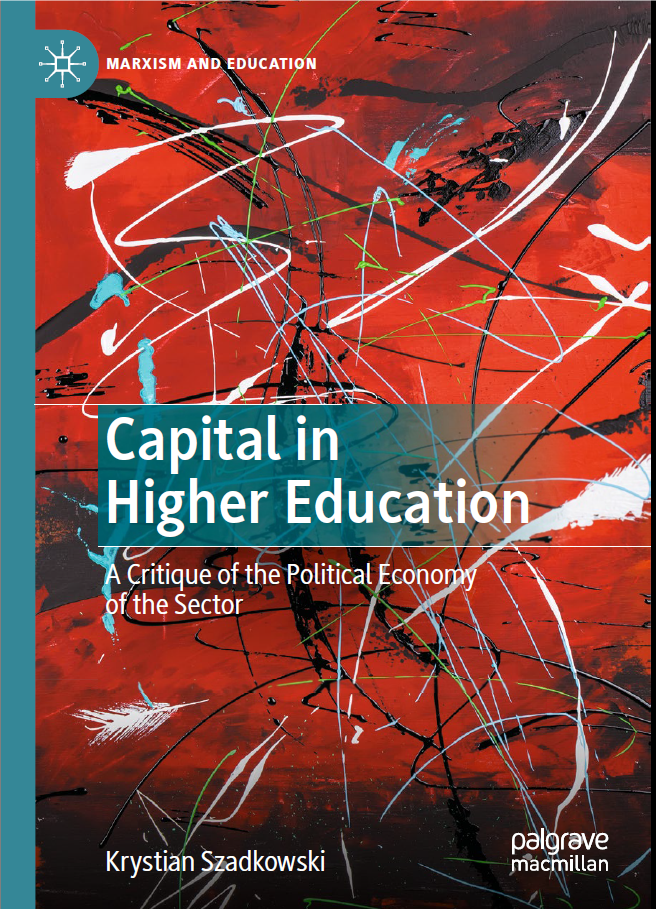





veramente molto interessante. da quello che ho studiato sembra che i salari stiano crescendo. Sul reddito di cittadinanza credo che in Cina abbiano dei problemi di struttura da risolvere prima. Romans