Nella notte tra il 19 e il 20 novembre lo Stato turco ha dato il via a una serie di pesanti bombardamenti che hanno coinvolto l’intera zona del Rojava (Kurdistan occidentale, o nord-est della Siria) e una parte del Başur (Kurdistan del sud o iracheno). Gli attacchi, svoltisi su un fronte totale di 700 km, si sono concentrati su obiettivi civili come scuole, ospedali e silos di grano, e hanno coinvolto numerose città, tra cui Kobane (in particolare il villaggio di Belûniyê a Shahba, popolato da sfollati curdi di Afrin), Derik e il vicino villaggio di Teqil Beqil, l’intera regione di Dahir al-Arab vicino a Zirgan e le aree dei monti Asos e dei monti Qendil.
L’ondata di attacchi è stata giustificata dal Sultano Erdogan come una risposta all’attentato del 13 novembre a Taksim, Istanbul; attentato che, con una orchestrazione da “strategia della tensione”, sembra essere stato ordito proprio dallo stesso regime turco, invece senza prove, infondatamente (oltre che ingiustamente), viene addebitato a PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), YPG (Unità di protezione del popolo) e YPJ (Unità di protezione delle donne). Erdogan ha così inaugurato la sua campagna elettorale in vista del voto che si terrà la prossima primavera. In una Turchia in piena crisi economica, infatti, e con degli exit poll che danno la coalizione AKP-MHP di regime in calo, il Sultano ha deciso di rivangare una tecnica già vista nel 2015, per cui il popolo curdo del vicino Rojava e la resistenza del PKK sulle montagne irachene vengono sfruttati come spauracchio, falsamente accusati di terrorismo e coinvolti in una guerra impari e brutale. In questo modo, Erdogan spera di spostare l’attenzione dell’opinione pubblica turca verso l’esterno del paese, nel tentativo di guadagnare consenso politico soddisfacendo le mire imperialiste neo-ottomane. Oltretutto, i bombardamenti sulle montagne di Qendil (cuore della resistenza del PKK) servono al regime per coprire i crimini di guerra commessi contro la guerriglia, anche mediante l’uso di armi chimiche vietate dalle convenzioni internazionali (uso di cui è stata resa e diffusa ampia documentazione). Sono state rilasciate testimonianze anche dello scempio compiuto dall’esercito turco contro i suoi stessi soldati, i cui cadaveri sono stati impietosamente bruciati sul campo di battaglia, sempre allo scopo di cancellare le tracce delle armi chimiche illegali.
Nel momento in cui scriviamo il bilancio è di 30 civili uccisi (tra cui un giornalista), decine di feriti, vari combattenti della coalizione SDF (Syrian Democratic Forces), due guardie uccise mentre proteggevano alcuni silos contenenti grano a Dahir Al-Arab, 15 soldati siriani uccisi e altri tre civili gravemente feriti a Kobane. I numeri aumentano di ora in ora.
L’innalzamento dei toni è iniziato già un mese fa. Lo scorso 4 ottobre la giornalista, accademica e ricercatrice curda, Nagihan Akarsel è stata assassinata davanti alla sua casa nella città di Sulemania, nella regione del Kurdistan iracheno, con colpi di arma da fuoco sparati in pieno giorno. Akarsel faceva parte dell’Accademia di Jineoloji. Si tratta di un centro di ricerca, con varie sedi tra Kurdistan ed Europa, il cui obiettivo è quello di ridefinire la sociologia tenendo conto dei saperi femminili, al fine di produrre un nuovo approccio etico alla scienza e fornire alla società strumenti di cui è stata privata da millenni di oppressione patriarcale.
La responsabilità dell’assassinio è stata apertamente rivendicata dallo Stato turco. Domenica 9 ottobre si è, infatti, svolta una cerimonia di apertura di un ufficio per il rilascio dei visti nella città di Erbil, nel Kurdistan iracheno, cui ha partecipato l’ambasciatore turco Ali Riza Guney. Alle domande dei giornalisti sul possibile coinvolgimento dello Stato Turco nell’assassinio di Akarsel, su cui da giorni si nutrivano sospetti, Guney ha confermato, affermando quanto segue: “Il nostro obiettivo è di mantenere le nostre relazioni bilaterali con l’Iraq tra stati sovrani liberi da organizzazioni terroristiche. Da qui, la nostra sensibilità e i nostri sforzi nella lotta al terrorismo. Persone affiliate o vicine al PKK sono bersagli al centro della nostra attenzione”.
Nessuna dichiarazione ufficiale è stata invece rilasciata da Mesrur Barzani, presidente della regione del Kurdistan iracheno, a dimostrazione della connivenza del clan Barzani con lo Stato turco.
Quella di Nagihan Akarsel, tra l’altro, è stata solo l’ultima di una lunga serie di esecuzioni mirate, che i servizi segreti turchi attuano abitualmente nei confronti di donne, spesso curde, politicamente attive, in opposizione al regime dell’AKP (partito del presidente/dittatore Recep Tayyip Erdoğan): tanto in Turchia, quanto in altri stati. Basti pensare al triplice assassinio di Sakine Cansız, Fidan Doğan e Leyla Şaylemez, uccise da un sicario a Parigi il 9 gennaio 2013, o a Deniz Poyraz, politica del’HDP, similmente assassinata il 17 giugno 2021 nella sede del partito a Izmir.
L’assassinio di Nagihan Akarsel è avvenuto a due settimane di distanza dall’ormai ben nota vicenda di Jîna* Amini, ventiduenne curda assassinata il 16 settembre scorso in seguito a un pestaggio della polizia morale iraniana, per via del velo indossato dalla donna in modo non conforme alle regole teocratiche.
Le proteste esplose in seguito alla morte di Amini, che vedono a tutt’oggi migliaia di manifestanti affrontare in piazza la durissima repressione del regime di Khamenei, sono state animate sin dall’inizio dallo slogan jin jiyan azadî, donna, vita, libertà. Questo slogan leggendario, che riecheggia oggi da una parte all’altra del mondo, in solidarietà con le rivolte iraniane, nasce in Turchia nel 2006, per iniziativa del movimento delle donne curde. Sembra un’incredibile coincidenza, ma a coniare lo slogan è proprio Akarsel, riprendendo il concetto dagli scritti del leader del movimento curdo Abdullah Ocalan. Jin jiyan azadî raccoglie in sé tutto il senso della rivoluzione delle donne.
In curdo, la parola jiyan (vita) viene da jin (donna). La connessione tra la donna e la vita è profonda e inscindibile, e viene intesa non solo nel senso strettamente biologico di dare alla luce una nuova vita, ma nel senso più ampio: le donne devono avere un ruolo centrale e vitalizzante per l’intera società. È per questo che la questione della libertà, azadî, nell’ideologia del movimento curdo è intrinsecamente legata alla riduzione in schiavitù delle donne, con l’imposizione del sistema patriarcale. Ritroviamo il tema in opere come Sociologia della libertà (Liberare la vita – la rivoluzione delle donne) di Öcalan.
In altre parole, la liberazione dell’intera società passa necessariamente attraverso la liberazione della donna. Questa nuova formulazione, proposta da Abdullah Öcalan negli anni Novanta e adottata dal PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), rappresenta per il movimento curdo un radicale cambio di paradigma rispetto alla maggior parte dei movimenti di sinistra di stampo comunista, che alla questione della donna hanno sempre anteposto quella dei lavoratori e dei mezzi di produzione, sostenendo che una volta attuata la rivoluzione proletaria altri problemi sociali (incluso quello di genere) si sarebbero risolti di conseguenza. Inutile dire che così non è stato, e l’analisi di Öcalan fornisce una spiegazione chiara al riguardo.
In occasione dell’8 marzo 1998, indirizzandosi alle donne del movimento, Öcalan scrive: “Il ventunesimo secolo sarà il secolo della liberazione delle donne”. Dunque, il senso dello slogan jin jiyan azadî risiede nella considerazione di come la questione del patriarcato sia legata alla struttura stessa del potere e della sua gerarchia, e insiste sul fatto che la liberazione della donna rappresenti un fattore fondamentale per laliberazione dell’intera società, non solo in Kurdistan, ma in tutto il pianeta. Ecco perché donna vita libertà viene intonato in tutto il mondo: perché universalizza il senso della lotta delle donne e della necessità collettiva di una rivoluzione femminista globale.
Sottolineata dunque la centralità della resistenza femminile nel Medio Oriente per il movimento curdo, perché delle donne curde non si parla più su nessun media europeo? Chiaramente a causa dell’alleanza occidentale con il regime turco di Erdogan. Assistiamo dunque a un incredibile paradosso, per cui la NATO, in ottica anti-Russia e anti-Cina, sceglie di sostenere il regime turco nel suo espansionismo neo-ottomano contro il popolo curdo, pur avendo temporaneamente sostenuto militarmente le forze curde contro ISIS, che al contempo è sovvenzionato e armato dallo stesso regime turco. Una posizione, quella occidentale, che pur nella sua assurda ambiguità non stupisce più di tanto. Il movimento curdo è fonte di forza e di ispirazione per movimenti di liberazione in tutto il mondo, e la prospettiva di democrazia radicale che propone è una minaccia per le potenze capitaliste. Non è certo la prima volta che le superpotenze e le loro organizzazioni, come la NATO, agiscono in modo apparentemente contraddittorio su questioni di politica internazionale. Ma la contraddizione è insita nell’ottica opportunista e calcolatrice degli stati nazione. Finché il movimento curdo e i popoli della Siria del nord e dell’est sono stati utili nella lotta a ISIS, gli Stati Uniti hanno offerto loro un’alleanza, solo tattica, e i mass media occidentali si sono prodigati a dedicare titoli di apertura e prime pagine, lodi e addirittura film e documentari. Sconfitto ISIS, per gli Stati Uniti di Trump le donne curde sono diventate merce di scambio con il regime turco, membro NATO, troppo necessario strategicamente per essere contrastato. Lo stesso Mario Draghi, ex presidente del consiglio italiano, ha definito Erdogan “un utile dittatore”; l’Amministrazione Autonoma in Rojava è stata abbandonata al massacro posto in essere dal Sultano e dai suoi mercenari jihadisti (riciclati, tra l’altro, proprio dalle file di ISIS). È l’ennesimo pasticcio occidentale, coronato da questo ultimo, prevedibile, tradimento; un assurdo via libera a questa nuova serie di attacchi concesso dalla “Global Coalition to Defeat ISIS”, guidata dagli Stati Uniti.
Jin, jiyan, azadi: la seconda conferenza delle donne
Vogliamo aggiungere, infine, che lo scorso 5 e 6 novembre a Berlino si è tenuta la seconda Conferenza Internazionale delle Donne, organizzata dal network Women Weaving the Future*. Con oltre 800 partecipanti, che provenivano da 41 paesi diversi, la conferenza ha segnato l’inizio del lavoro di analisi, costruzione e implementazione di confederalismo mondiale delle donne, proposta emersa nella prima conferenza del 2018 come soluzione per unire le lotte delle donne di tutto il mondo.
In momenti di crisi e di recessione, sono sempre le donne ad essere colpite per prime, in modo trasversale e con decisione; i recenti attacchi all’aborto sono un esempio clamoroso. Il divieto di accesso all’aborto, in particolare, da sempre viene utilizzato dagli stati per regolare la riproduzione, la libertà delle donne, la loro partecipazione al lavoro, la possibilità di creare un paradigma di vita alternativo a quello standard di casa e famiglia.
In questo senso, la Conferenza è stata un momento chiave di condivisione di esperienze e strumenti di resistenza in tutto il mondo, fondamentale per analizzare i problemi che ci accomunano e trovare soluzioni. La grande forza che è emersa dal riunirsi e riunirci ha riconfermato la necessità di organizzarci internazionalmente e avere spazi di autonomia. L’occhio della donna e il suo intervento sono indispensabili in ogni ambito di lotta; per questo motivo sono stati organizzati, oltre ai panel generali, anche otto workshop su molti temi: migrazione, la liberazione della donna come lotta strategica, salute, economia, ecologia, difesa della cultura e del linguaggio, costruzione di un fronte antifascista ed educazione.
.
Le riflessioni scaturite dalle discussioni sono la prova che unite siamo in grado di costruire sistemi più liberi e di costruire relazioni su basi diverse da quelle della competitività e dell’individualismo; relazioni che fonderanno una nuova società. La libertà deve nascere necessariamente dalla lotta delle donne, dal nostro modo di modellare la vita e di intendere la politica come cura della comunità.
Noi donne non abbiamo un ruolo nella rivoluzione: noi donne siamo la rivoluzione.
NOTE
* Molte testate si riferiscono a Jîna Amini come Mahsa, utilizzando il nome iraniano della donna, legalmente riconosciuto dalle autorità. Come molti altri, però, scegliamo di utilizzare il nome curdoAmini, Jîna. La repressione della popolazione curda in Rojhilat (Kurdistan iraniano) avviene anche attraverso il divieto di dare ai propri figli nomi curdi, motivo per cui anche in questo caso il nome riportato sui documenti e il nome usato realmente da Amini non coincidono.
* https://womenweavingfuture.org/
Immagine di apertura: Conferenza Internazionale delle Donne, organizzata dal network Women Weaving the Future, 5-6 novembre 2022, Berlino





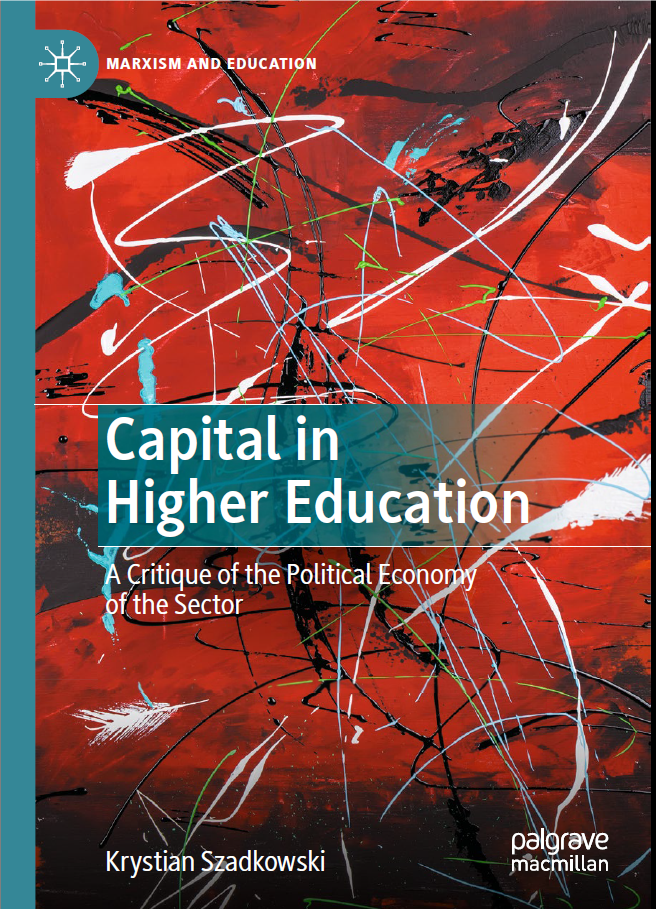





L’esplosione accesa da Gina Amini, con il suo prevedibile sacrificio di solidarietà gineologica, è probabilmente il gran focolare necessario per iniziare a livello globale, tra tutti i popoli – sono, siamo migliaia, piccoli e grandi ma colonizzati da solo un paio di centinaia di stati Onu – l’indispensabile processo di transizione umana opposto all’attuale dominio transumanoide. Per recuperare una civiltà umana fondata sull’Essere e non più sull’Avere.
Direi che il suo impatto ginergico ha già cominciato a manifestarsi proprio nell’inferno teocratico o monoteista iraniano, aprendo ogni giorno sempre più speranze per tutti, cominciando dalla critica radicale al patriarcato.