Il cielo, già lugubre di questi tempi, si rabbuia un altro po’, svelando una sorta di tragico disegno. Dopo il decreto Rave, dopo il decreto Cutro, dopo la repressione degli eco-attivisti, condannati a Padova, dopo le decisioni delle prefetture (su mandato del Ministro degli Interni Piantedosi) di annullare l’anagrafe delle famiglie omogenitoriali, arriva lo stop della Commissione Garanzia e la precettazione limitativa dello sciopero generale, indetto per il 17 novembre da Cgil e Uil, contro la manovra finanziaria del governo Meloni. Mentre il governo taglia servizi essenziali, aumentando le diseguaglianze sociali, mentre Meloni posta video in cui propaganda riforme istituzionali imbarazzanti, Salvini indossa volentieri la giacca del gendarme dell’ordine del capitale neoliberista contro i lavoratori e le lavoratrici, contro le famiglie impoverite e precarie. Alla faccia della “destra sociale” e di risibili promesse elettorali, alla faccia di ogni retorica populista, sapevamo da sempre che ci saremmo trovati davanti il regime più prono ai dispositivi autoritari del sistema socio-economico che domina quest’Europa della finanza. L’economia di guerra non fa sconti e le bombe sociali piovono all’interno mentre poco più in là si contano i morti per gli ordigni che mirano gli ospedali e i fronti si rinsaldano, granitici e terribili.
Un vecchio slogan ci torna in mente. Diceva: “Il proletariato non ha nazione”. In queste settimane ci sembra davvero più attuale che mai.
Pillole di storia di un diritto e del tentativo di sotterrarlo
Vale dunque la pena soffermarci sul diritto di sciopero, che ha una lunga storia[1]. La ripercorriamo rapidamente per capire come il passato, oscurantista e drammatico, prema per rifarsi presente.
Dopo l’unificazione d’Italia, sotto la vigenza del Codice penale sardo del 1859, esteso a forza a tutto il territorio nazionale, lo sciopero era un vero e proprio reato e, come tale, soggetto a pene detentive e pecuniarie. In seguito all’entrata in vigore del codice Zanardelli nel 1889, tale concezione criminosa dello sciopero viene alleggerita e assistiamo all’affermarsi di un atteggiamento meno repressivo dello Stato nei confronti delle astensioni collettive dei lavoratori, con l’unica eccezione dello “sciopero violento”. Chissà se i cannoneggiati da Bava Beccaris nel 1898 rientravano in questa eccezione. Il primo sciopero generale in Italia fu proclamato dalla Camera del Lavoro di Milano, subito dopo l’eccidio nella miniera sarda di Buggerru, nel settembre del 1904: furono uccisi a fucilate quattro lavoratori che chiedevano la riduzione dell’orario di lavoro. Lo sciopero generale cambiò radicalmente il panorama politico, il governo fu costretto a nuove elezioni.
Solo l’entrata in vigore della Carta costituzionale nel secondo Dopoguerra fu sancito espressamente il riconoscimento dello sciopero come diritto, andando oltre la concezione del periodo precedente che continuava, comunque, a considerarlo un illecito civile. Durante il fascismo, cui si è a lungo ispirato l’attuale Presidente del Senato (quello che nomina i garanti) veniva represso come un delitto contro l’economia nazionale, e la concezione la ritroviamo, sostanzialmente identica, nell’architrave del provvedimento limitativo della Commissione di Garanzia. La Costituzione e l’art. 40 ne sanciscono il diritto e l’ambito: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Negli anni Sessanta e Settanta, lo sciopero, come diritto individuale prima ancora che sindacale, diventa l’icona della protesta e dell’emancipazione della classe operaia.
Ma, a partire dagli anni Ottanta, sconfitti i movimenti operai del decennio precedente, cominciano a registrarsi i primi tentativi di regolamentazione e limitazione del diritto di sciopero, grazie al Protocollo Scotti del 1983 (quello che ha introdotto la prima figura atipica nel giuslavorismo italiano, il contratto di formazione e lavoro, antesignano della creazione delle successive figure precarie), con le cosiddette “clausole di tregua sindacale” che vietano ai sindacati di mettere in discussione i contratti prima della loro scadenza.
Nel percorso che procede verso il contenimento e poi il progressivo svuotamento del diritto di sciopero abbiamo anche il Protocollo del 23 giugno 1993 nel quale, oltre a una più chiara ripartizione di competenze tra i diversi livelli contrattuali, viene espressamente stabilito che durante il cosiddetto periodo di “raffreddamento” – compreso tra i tre mesi antecedenti la scadenza del contratto e il mese successivo – le parti non avrebbero potuto ricorrere a iniziative dirette, ossia scioperi, pena l’anticipazione o lo slittamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Occorre notare che tali disposizioni hanno favorito l’abitudine di reiterare al massimo tempo futuro i rinnovi contrattuali, pratica oggi del tutto abituale nella contrattazione collettiva nazionale.
Ma tornando ai limiti introdotti per gradi al diritto di sciopero e con ciò alle libertà dei lavoratori e delle lavoratrici, eccoci all’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 e poi all’Accordo quadro interconfederale attuativo del 15 aprile 2009.
Con questi testi, da un lato è stato prolungato il periodo di raffreddamento (leggi, divieto di sciopero) previsto per la contrattazione nazionale (ora coincidente con il periodo decorrente dai sei mesi antecedenti la scadenza del contratto al mese successivo a tale termine, o comunque pari a un periodo di sette mesi calcolato a partire dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo); dall’altro, è stato introdotto un ulteriore periodo di raffreddamento per la contrattazione decentrata, decorrente dai due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo fino al mese successivo alla scadenza dell’accordo o, comunque, pari a un periodo complessivo di tre mesi.
Inoltre, è stata eliminata la previsione della sanzione dello slittamento dell’indennità di vacanza contrattuale in caso di violazione di questi obblighi, prevedendo in tal caso esclusivamente la possibilità di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione unilaterale messa in atto.
È evidente come la crisi della contrattazione collettiva vada di pari passo con l’ampliamento dei casi in cui il diritto di sciopero viene messo a repentaglio. Un aspetto, quest’ultimo, che varrebbe la pena di riconsiderare alla luce dell’attuale situazione di dumping salariale.
Tali operazioni non hanno cancellato il diritto di sciopero, ne hanno tuttavia limitato l’attuazione in alcuni momenti temporali (quelli decisivi) della contrattazione.
Diverso, invece, è stato l’intervento nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, fra i quali viene inserito l’intero settore del trasporto, e, di conseguenza, quello vitale della logistica. L’intervento legislativo del 1990 con la legge n. 146 disciplina le nuove normative in materia di sciopero, e assesta un colpo micidiale al potere contrattuale dei lavoratori, sottraendo loro libertà d’iniziativa, nella durata almeno, nella movimentazione di merci e persone. Perfino le Autostrade (dunque il pagamento del percorso in favore del concessionario privato) vengono ricondotte dentro l’area di limitazione del diritto. Questo provvedimento, originariamente finalizzato a regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi esclusivamente nell’area del lavoro subordinato, venne modificato con la l. 83/2000 che ne estende l’ambito di applicazione anche alle astensioni collettive dal lavoro dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori la cui attività fosse comunque connessa all’erogazione di servizi pubblici essenziali (es. avvocati).
Ulteriori limitazioni trovarono ingresso con il decreto legge 20.9.2015 n. 146, convertito con legge 182/2015. Tuttavia nel 1990 il quadro normativo che conduceva alla nomina dei cinque membri della Commissione di Garanzia era nella sostanza, se non nella forma, radicalmente diverso da quello di oggi. Nel 1990, per prassi fino ad allora mai derogata a partire dal 1968, la maggioranza eleggeva il Presidente del Senato e l’opposizione il Presidente della Camera (Pertini, Ingrao, Iotti). Trattandosi di nomina congiunta, poi ratificata dalla Presidenza della Repubblica, la Commissione era il frutto di un compromesso fra le forze in campo, i componenti erano soggettivamente autorevoli per forza di cose. Nel 1994 l’ingresso di Berlusconi muta il quadro: Camera e Senato diventano entrambi della maggioranza. Dunque la procedura di nomina della Commissione di Garanzia viene snaturata rispetto all’origine, in senso autoritario: l’esecutivo diventa il padrone dell’intera Commissione, che perde di fatto il ruolo arbitrale per diventare il caporale del potere. Ma la legge non cambia, la scelta istituzionale è quella di un dominio arrogante. Viene meno la credibilità della Commissione, e inizia, contestualmente, una caduta di livello tecnico che prosegue, incrementata, fino ad oggi.
Ed è sulla base di queste disposizioni in materia di rispetto dei tempi, degli annunci e delle formalità di dichiarazione dello sciopero che oggi, in questo triste paese, si riduce la legittimità di un diritto fondamentale come è quello di scioperare.
L’“imparzialità” della Commissione di Garanzia
Oggi, di fronte alle performance di Salvini che, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha avviato la precettazione per i principali sindacati italiani, possiamo proprio aggiungere che questa fase della storia non ci sta risparmiando niente.
Ci interessa far notare, tra l’altro, che a decidere se uno sciopero si può fare, e in quali modalità, è ancora oggi la Commissione di Garanzia, un organo formato da cinque membri scelti tra esperti del settore, come abbiamo chiarito sopra, su indicazione dei presidenti della Camera e del Senato (Legge 12 giugno 1990 n. 146), ma con l’intervenuta modifica della prassi, dunque espressione esclusiva della maggioranza parlamentare, poi ratificati con nomina a mezzo di decreto del presidente della Repubblica.
Ebbene, l’attuale Commissione di garanzia è composta da Peppino Mariano, avvocato che fu consulente sulle materie del lavoro per Giorgia Meloni quando era ministra della Gioventù tra il 2008 e il 2011, da Luca Tozzi, avvocato ed ex consulente giuridico dell’attuale presidente della Camera Lorenzo Fontana quando era ministro della Famiglia, tra il 2018 e il 2019. L’attuale presidente della Commissione è Paola Bellocchi, docente di Diritto del lavoro (che non ha mai nascosto le sue simpatie per la destra). Gli altri membri sono il docente universitario Federico Ghera (avvocato e consulente di parte datoriale) e l’economista Paolo Reboan, che è stato direttore generale del ministero del Lavoro e prima ancora fu consulente per ministri del Lavoro come Roberto Maroni e Maurizio Sacconi. Non è difficile notare il chiaro schieramento politico dei componenti di tale organismo, un vulnus per una sedicente Commissione di Garanzia che dovrebbe avere un’impostazione “super partes”. La decisione di non riconoscere lo sciopero del 17 novembre appare qui viziata all’origine da un possibile pregiudizio ideologico in difesa dell’operato del Governo. Siamo, insomma, in buone mani.
Con una manovra a tenaglia (poco importa quale sia arrivata prima: erano palesemente concordate) il Ministro del Trasporto Salvini ha avviato la precettazione, dunque sanzioni fino a centomila euro per i sindacati promotori e sanzioni sia disciplinari sia pecuniarie a carico del singolo lavoratore, mentre la Commissione ha ridotto d’imperio da 8 a 4 ore lo sciopero del trasporto (indebolendo così lo sciopero generale). Per arrivare a questa conclusione la Commissione ha dovuto ricorrere a una forzatura logica e politica: ha affermato che lo sciopero, essendo nazionale ma articolato, non poteva essere qualificato generale ma riqualificato come plurisettoriale. Non poteva intervenire, neppure nel trasporto, se fosse generale, cioè per come proclamato; ma ritiene di poter intervenire settorialmente grazie a questo escamotage. Non era mai avvenuto prima. La legge non contiene alcuna definizione limitativa dello sciopero generale; la Commissione ci arriva per vie che definisce interpretative e che sono invece costitutive. Un altro passo sulla strada della delegificazione autoritaria: un organo amministrativo di garanzia vara norme nuove in un tema di rilevanza costituzionale. Lo fa invocando, per aggiunta, un inesistente orientamento consolidato della Commissione che sarebbe comunque irrilevante, ma che non esiste.
A che cosa serve uno sciopero?
Da ultimo, vogliamo far notare le dichiarazioni del Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che invoca e giustifica la precettazione, perché “non è accettabile bloccare l’intero Paese per 24 ore”. E ha aggiunto che il suo compito “è garantire la mobilità di 60 milioni di italiani e che è pagato per farlo”.
È diventata, oramai, luogo comune l’idea che uno sciopero, ovvero la sospensione dell’attività lavorativa, non debba creare eccessive disfunzioni e danni all’attività quotidiana dei cittadini/e. Ed è riferendosi a questo principio che la Commissione Garanzia ritiene non ammissibile lo sciopero generale di 24h in alcuni comparti (come quello dei trasporti e dei servizi pubblici in generale) poiché ritenuto lesivo di diritti di altri.
Vorremmo ricordare i fondamentali, ovvero che lo sciopero nasce nel conflitto capitale-lavoro come arma per boicottare la produzione. Il lavoro, astenendosi dal produrre, va a colpire nella carne viva, il profitto del produttore. Lo sciopero ha sempre un costo e la tradizione mutualistica delle forme sindacali scaturisce e si sviluppa proprio per alleviare i problemi che derivano al lavoro dai tagli al salario che lo sciopero comporta, al fine di centrare lo scopo di danneggiare gli interessi del padrone.
Oggi, certo, in una realtà produttiva e di sfruttamento che ha tracimato i confini della fabbrica ed è diventata pervasiva, provando a infilarsi in ogni recesso della vita umana, lo strumento dello sciopero deve essere ripensato e adeguato alle nuove sfide che dobbiamo affrontare, Salvini è una conferma. Dovremmo aggiungere che vogliamo lo sciopero generale e anche qualcosa di più. Che lo sciopero generale non si tocca, che va difeso e che bisogna aderire ma che forse non basta. È necessario uno sciopero sociale, uno sciopero precario, uno sciopero biopolitico, ovvero uno sciopero più ampio che tenga conto del tessuto che innerva la riproduzione sociale, oggi resa esplicitamente produttiva anch’essa.
Insomma, noi ci schieriamo per questo sciopero, non solo per difendere la storia operaia e di tutti “i non aventi parte” di cui, come generazioni precarie, facciamo parte, non solo perché questo è un tempo gramo che rende necessario fare fronte, convergere, davanti agli attacchi alle libertà e ai diritti di base garantiti dalla Costituzione ma perché vorremmo intenderlo come l’inizio di qualcosa di più ampio, di mobilitazioni che continuano, che non si fermano, capaci di parlare a fasce di popolazione che non hanno rappresentanza, di animare processi moltitudinari, meticci, femministi, di farci ritrovare passione comune per l’azione sindacale e politica in difesa delle nostre esistenze. Dentro e fuori dal lavoro. Pensiamo, nell’affermare questo, alle grandi lotte composite che ci ha regalato la Francia, in questi anni.
Temi fondamentali sono sul terreno contro la politica marcatamente antisociale di Meloni e Salvini, dal salario minimo al reddito, alla difesa del Welfare State. Contro il divieto di sciopero, bisogna stare dalla parte giusta.
NOTE
[1] Alcune notizie seguenti sono tratte da: https://www.wikilabour.it/dizionario/sciopero/regolamentazione-del-diritto-di-sciopero/


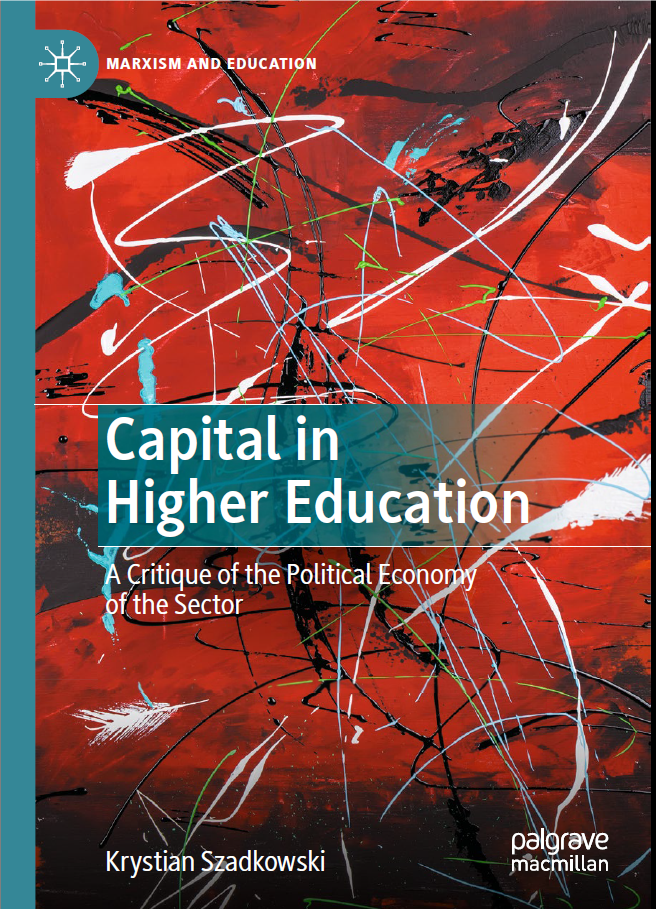





Non una parola su come è nata la legge per regolamentare gli scioperi: anni 90, concertazione governo sindacati confederali (accordi 92/93 che misero fine alla scala mobile), concordanza sul creare problemi ai sindacati autonomi, ma sempre senza regolare la rappresentanza sindacale per legge (ancora oggi non c’è una legge sulla rappresentanza sindacale). Intanto si è creata una autorità per la regolamentazione di parte governativa (si pensava: tanto le autorità starà sempre dalla “nostra” parte) e così adesso la triplice diventata duplice si ritrova afare marcia indietro sullo sciopero. Rimasero muiti quando la FISI dichiarò sciopero generale contro il green pass vaccinale per lavorare, infamia del potere sindacale e governativo che nessuno riuscirà a cancellare. Il commento è ommissivo e reticente: occorre rimembrare tutto per capire come gli eventi si sono sviluppati, altrimenti è aria fritta a difesa dell’esistente.
Se ci si informasse prima di rispondere, sarebbe meglio. La denuncia delle politiche di concertazione del sindacato tradizionale è un leit motiv di questo sito, come si può evincere da numerosi contributi anche in tema della crisi della rappresentanza sindacale. In secondo luogo, è evidente che la descrizione dei vari passaggi che hanno portato alla limitazione del diritto di sciopero implica una forte giudizio negativo. Eviterei di parlare del sindacato FISI colluso con i peggiori fascisti. La distanza ranoi e i rossobruni è stellare.
Andrea Fumagalli