I fatti sono noti (e, se non lo fossero, sono stati riassunti qui e qui, per esempio), ma forse solo parzialmente: la narrazione più diffusa tende a limitarsi alle «violenze» del 9 febbraio – e invece, come sempre, c’è un prima e un dopo. In breve: dopo l’annuncio di installare dei sistemi per il controllo delle persone in entrata (i «tornelli») nella BDU-Biblioteca Discipline Umanistiche dell’Università di Bologna (risalente all’estate 2016 e da attuarsi nei primi mesi del 2017), attiviste/i e studenti accedono comunque alla biblioteca da porte laterali (dal 23.01); raccolgono più di 600 firme su carta (543, secondo il Resto del Carlino) in 48 ore, in opposizione alla decisione (02.02); consegnano le firme alla Prorettore-agli-studenti Elena Trombini (che dice: «prendiamo atto delle vostre richieste»); di fronte al silenzio da parte dell’Università e alla militarizzazione dell’area di via Zamboni e piazza Verdi (i primi scontri tra studenti e Polizia sono del 03.02), studenti e attiviste/i indicono un’assemblea pubblica (06.02, ripetuta l’08.02), cui segue un incontro con la Prorettore Trombini e il Presidente del sistema bibliotecario di Ateneo Guglielmo Pescatore (07.02) che si conclude in un nulla di fatto. Attiviste/i e studenti smontano quindi le porte a vetri e le consegnano simbolicamente in Rettorato (08.02) mentre il Rettore Ubertini decide la chiusura della BDU; il giorno successivo (09.02), studenti e attiviste/i reagiscono alla chiusura della biblioteca occupandola, quindi aprendola a chi vi vuole studiare; alle 17.30, su richiesta d’aiuto da parte dell’Università, il questore Ignazio Coccia invia la celere in tenuta antisommossa in Biblioteca, dove gli occupanti studiano. Ne nascono scontri, dentro e fuori dal «36». Nel citatissimo commento pubblicato su Contropiano dell’ex docente dell’Alma Mater Alberto Tarozzi (uno dei pochissimi a pronunciarsi sull’intervento della Polizia in sede universitaria, in un generale silenzio acquiescente), si legge «in quei 40 anni la polizia mai è intervenuta all’interno dei locali dell’Università militarmente, nemmeno mentre qualcuno occupava, nemmeno quando nei dintorni c’erano episodi di lotta armata». Nei giorni successivi, seguono un’assemblea spontanea (10.02), quattro Assemblee studentesche generali (14.02, 17.02, 22.02, 28.02) nella sede di Filosofia («il 38»), due cortei in città (14.02 e 16.02), un flashmob davanti al «36» (20.02) e due sit-in in Rettorato («al 33») con allestimento di un’aula studio provvisoria (16.02, 21.02). A parteciparvi, centinaia di studenti e cittadine/i, nonché membri di vari collettivi (su tutti, Lubo-Libera Università di Bologna, gemmazione del Tpo-Làbas, e il Cua-Collettivo universitario autonomo). La giornata del 09.02 costa ad attiviste/i e studenti venti denunce; dal 10.02 due attivisti sono agli arresti domiciliari. «Il tappo è saltato», chiosa subito Alessandro Canella sul sito di Radiocittà Fujiko.
Questi i fatti. Tuttavia, scrive Lubo il 14.02, «la questione
Questo il contesto: il progetto dell’apertura prolungata di alcune biblioteche dell’Ateneo e di «riqualificazione della cittadella universitaria» è stato lanciato dal Rettore Ubertini (ingegnere eletto contro ogni pronostico nell’estate 2015) nella scorsa estate, a inizio delle attività di Zambè (rassegna estiva finanziata anche dalla Fondazione del Monte, in un’ottica di «valorizzazione» di via Zamboni), e già sul Corriere di Bologna si accennava a «tornelli, controllo degli accessi, guardiania centralizzata e […] un sistema di segnalazione in tempo reale dei posti disponibili, per il quale si sta studiando anche una app per smartphone», mentre Ubertini parlava di «misura strutturale». Il piano coinvolge anche Biblioteca Giuridica Antonio Cicu e la sala studio di Palazzo Paleotti (entrambe in via Zamboni e ad accesso limitato) ed è finanziato con 250 mila euro all’anno dalla stessa Fondazione del Monte, presieduta da Giusella Dolores Finocchiaro, avvocata, sindaca di Cassa depositi e prestiti, nonché ordinaria di Diritto privato e già allieva dell’ex-Rettore Fabio Roversi Monaco (ex Rettore 1985-2000, ex presidente di Imi, di Fondazione Carisbo e del cda di Bologna Fiere). Secondo Lubo, la Prorettore Trombini, nell’incontro con le/gli studenti del 7 febbraio, giustifica la limitazione degli ingressi dapprima con il problema dell’«insicurezza di lavoratori e studentesse» e poi con il rinnovamento del sistema di prestito dei libri. Più in generale, pare, la «riqualificazione della cittadella» di via Zamboni fa da contrappeso, nella logica strategica del Rettorato, alla scelta di «rinunciare» a un’altra cittadella: quella del cosiddetto progetto Staveco, da realizzarsi nell’ex area militare di proprietà demaniale (ex-Staveco), ceduta nel 2013 dal Comune di Bologna all’Università dell’allora Rettore Dionigi per essere riconvertita in un campus all’americana, a fronte della vendita di nove palazzi storici di proprietà dell’Ateneo, alcuni dei quali in via Zamboni (Patrizia Gabellini, assessora all’Urbanistica, commentava: «l’alleggerimento della presenza dell’Università in via Zamboni, che si tenta dagli anni ’70, può avere una chance seria» anche nell’ottica di risolvere «l’annosa situazione “piazza Verdi”». Contro il progetto – per i costi e la retorica da grande opera, le implicazioni sul patrimonio storico-artistico e immobiliare dell’Ateneo e il modello di università gated, con conseguente marginalizzazione del dissenso, che comportava – si erano espresse/i, a suo tempo, collettivi e studenti.
C’è un prima e un dopo, e c’è un «intorno» che riguarda l’amministrazione della città tutta, oggi. A Bologna, il piano di progressiva centrifugazione del dissenso e del disagio oltre le mura (che muoveva il «progetto Staveco») si riflette nella gentrificazione della Bolognina (quartiere popolare e migrante a ridosso della nuova stazione AV); nella lunghissima serie di sgomberi degli spazi pubblici autogestiti (Atlantide nel 2015, e quelli annunciati di XM24 e Làbas, l’ultimo per realizzare «un albergo, una trentina di alloggi, attività sociali e ristorative») e delle occupazioni abitative (via Solferino, via Fioravanti, via de Maria, via Mura di Porta Galliera) tra l’autunno 2015 e quello successivo; nella gestione antidemocratica della costruzione del Passante di Mezzo; nel contestato progetto della Fabbrica Italiana Contadina di Oscar Farinetti/Eataly. Ma di tutto questo, ha già scritto Anna Giulia Della Puppa.
Parlare dell’«intorno» implicherebbe poi accennare all’interazione tra amministrazione cittadina e Università (due giganti che gestiscono 800 milioni l’uno l’anno) e sulla sua evoluzione nell’era post-Dionigi, tra amministrazione e Questura, e tra Università e Questura, a questo punto. Le tre si trovano pericolosamente a condividere una certa pretestuosità nell’agire, spesso in modo approssimativo o improvvisato, la scelta di una risposta securitaria, la repressione del dissenso come problema di ordine pubblico e la sproporzione della reazione («la misura politica sbagliata», dice il consigliere del quartiere Santo Stefano Detjon Begaj). E, a meno che si accetti di pensare alla repressione e alla gentrificazione della «città della pace sociale» come un progetto politico condiviso dall’Amministrazione tutta e all’Università come luogo funzionale solo alla produzione e riproduzione di capitale, c’è da aggiungere che amministrazione cittadina e universitaria condividono anche un’incapacità di pronoia, di intelligenza politica e di visione d’insieme.
A mancare di una visione d’insieme è stata tuttavia anche una gran parte – all’inizio rumorosissima – del corpo studente. Nate/i dalla crisi delle grandi narrazioni sistematizzanti e produttrici di senso, in pieno riflusso del riflusso, formate/i in un’università post-Gelmini, molte/i studenti del febbraio bolognese sono parse/i difettare di strumenti per significare la realtà e riprodurre una retorica dal vocabolario benpensante («il degrado», «il merito»), rivendicandosi quello che Mark Fisher chiamava il «volontarismo magico» (che impianta nei/lle precari/e a venire il senso di colpa) e una propensione per quella sinistra liberal che si concentra sui diritti civili e scorda quelli sociali. In questi giorni, soprattutto sui gruppi facebook delle facoltà umanistiche, si sono letti tantissimi commenti su questo tono; su change.org – piattaforma dove un singolo può firmare più volte – una petizione lanciata da un gruppo di studenti chiama alla dissociazione dall’operato dei collettivi, raccogliendo 8000 firme virtuali. Se Piero Gobetti, nel celebre Elogio della ghigliottina, scriveva che «il fascismo in Italia è un’indicazione di infanzia perché segna il trionfo della facilità, della fiducia, dell’entusiasmo», si legge paradossalmente nei commenti di molte/i studenti quella stessa tensione ottimistica che stava dietro alla «nazione che crede alla collaborazione delle classi, che rinuncia per pigrizia alla lotta politica».
Tuttavia, il rischio di cadere nella falsa coscienza dell’indignazione online è altissimo: per quanto i commenti perbenisti siano sembrati, in questa occasione e soprattutto online, più numerosi e gridati del solito, gli studenti conformisti hanno una tradizione che retrodata a ben prima di questo febbraio. In ogni caso, analizzare le radici diffuse della narrazione della quale quelle/gli studenti si sono fatte/i portatori, mi sembra di qualche urgenza.
La prima mossa retorica messa in atto da questa narrazione generalista è la separazione tra studenti «vere/i» e collettivi, che mira a delegittimare i secondi, imbellettando i primi: e, globalmente, come in ogni tentativo di divide et impera, tende a depotenziare tutti. Lanciata in qualche modo da una parte del corpo studentesco, questa retorica «dei cattivi contro i buoni» viene subito adottata sia dalle testate locali (Repubblica Bologna e Il Resto del Carlino) sia dalle/i rappresentanti del Comune e dell’Università, attecchisce sulle impalcature del dibattito e ne appesta l’aria. Il sindaco Merola, in un commento pubblicato sull’edizione locale di Repubblica, dice: «non mi sembra che le azioni di protesta [del] Cua siano state apprezzate dagli studenti. Appare piuttosto evidente il contrario» e «esprimo tutta la mia solidarietà alle migliaia e migliaia di studenti che ogni giorno studiano, frequentano le lezioni, sostengono esami, e che nulla hanno a che fare con azioni velleitarie e violente che invocano quasi la repressione per dare un senso alla loro esistenza»; il Prorettore vicario Mirko degli Esposti aggiunge, in riferimento alle/i manifestanti, «non sono studenti e non lo sono mai stati». La vicenda, che inaspettatamente ha un’eco molto ampia, si rifrange in questi termini sui media nazionali. Gli studenti sedicenti «veri» indicono un’assemblea a sé stante, che però non viene svolta, a seguito della grandissima partecipazione alla prima parte dell’Assemblea studentesca generale organizzata da collettivi e studenti. La narrazione tossica – che molte/i studenti sembrano alimentare inconsapevolmente – racchiude una dicotomia («o studio o occupo») e un’implicazione logica fallace («se sono davvero studente non ho tempo di occupare»): l’identificazione della/o studente con l’esecutrice/ore del triathlon corso-studio-esame, propagandata da anni di riforme della scuola al ribasso, metastatizza così nel corpo delle/gli studenti, che – privati di ogni luogo del pensiero critico – ne diventano i primi riproduttori. Questa narrazione, oltre a essere nociva, è fuorviante: le centinaia di studenti in assemblea e in corteo non possono essere ridotte né ai (pochi) membri dei collettivi e, d’altro canto, la loro concezione dell’«essere studente» non si riduce a «studia[re], frequenta[re] le lezioni, sosten[ere] esami».
Accanto alla retorica degli studenti più o meno legittimati a dirsi tali, se ne produce un’altra, altrettanto pericolosa. Quella del «sì nel merito, no nel metodo». Per quanto potenzialmente valida, questa retorica è spesso accompagnata da indignazione a buon mercato o, altrimenti, si ammanta di un pacifismo semplificatorio, che rivendica l’eredità della nonviolenza distorcendola in una forma di accidia dell’esistenza. Se Aldo Capitini, padre italiano del movimento nonviolento, giustifica «l’assalto al funzionamento di un servizio […] con danno o distruzione, e quindi oltre il limite della legalità quando non vi è alcun rischio per l’esistenza degli esseri viventi», una parte delle/gli studenti bolognesi sembra non solo condannare in toto l’atto di sabotaggio (posizione comunque ammissibile), ma addirittura sentire un’urgenza di distanziarsi dai collettivi (i «violenti» della narrazione delle testate giornalistiche locali) e di dirsi diversi, tanto intensa da annebbiare l’imprescindibilità della condanna della presenza della Polizia in una biblioteca, in un confuso «condannare ogni forma di violenza» che non distingue più la difesa dall’offesa, non assume che la violenza possa avere significato politico diverso a seconda dell’autore e non è in grado di leggere gli eventi in base al loro ordine di grandezza. Addirittura, si sono lette – tra i commenti delle/gli studenti – giustificazioni della violenza di Stato come inevitabile in quel contesto e parole a difesa dei «poliziotti perché i poliziotti sono figli dei poveri», in una generale associazione tra perbenismo e retorica legalitaria e tra questa e una forma di egemonia politica che ha sacrificato la giustizia (sociale, in primis) preferendovi la ben più placida legalità. In questo clima, la giunta Merola, eletta a seguito di una campagna elettorale costruita sulla paura dell’eventualità di una guida leghista, il 20.02 ha approvato un odg («anticostituzionale», secondo Coalizione civica) di Lucia Borgonzoni (Lega Nord), che «premesso che ogni libera manifestazione pacifica è un valore per la discussione democratica […] condanna[va] le azioni violente perpetrate da degli esponenti del Cua e prende[va] le distanze da tutti i rappresentanti delle forze politiche cittadine che manifestano al fianco del collettivo stesso legittimandone, di fatto, i metodi».
Questo atteggiamento di parte del corpo studente ha permesso la diffusione di una retorica depoliticizzante: secondo il Rettore, i «tornelli» sono uno strumento tecnico e non politico («si tratta di una biblioteca, non è il problema di uno spazio collettivo per il dibattito politico», ha detto Ubertini). L’assenza di allenamento, nelle/gli studenti, a vedere il politico nel quotidiano si riflette nell’accettazione della logica securitaria e esclusiva dell’Amministrazione cittadina come soluzione all’abbandono nel quale giace piazza Verdi. Quella stessa assenza di allenamento si riflette in una confusione (un’equazione, meglio) tra ciò che è legittimo è ciò che è legale, mentre quella coscienza storica fragilissima, che impedisce di rivedere nella presenza della Polizia in via Zamboni l’ombra di altri momenti storici, permette, di rimando, al sindaco Merola di rivendicare quasi l’eredità dell’«ala creativa e libertaria» del movimento del ’77 e scrivere: «non vedo oggi, come accadde invece 40 anni fa, un movimento che, seppur tra errori e scelte estreme, cercava di affermare una alternativa all’esistente». (A margine, il corteo delle/gli studenti del 10.02 è passato da via Mascarella, dove venne ucciso Francesco Lorusso, l’11 marzo 1977.)
Su tutti, l’inserimento della vicenda in una prospettiva storica viene proposto da Leonardo Tancredi, di Piazza Grande, che su Napoli monitor ricorda come «il rapporto del movimento studentesco con quello spazio di studio […] nasce [quando] i collettivi che escono vivi dalle mobilitazioni della Pantera del ‘90 a Bologna pongono il loro quartier generale proprio al 36, facendone una sala studio autogestita» – una tradizione poi persa «soprattutto a causa di una dura controffensiva verso le esperienze di autogestione che il comune di Bologna muove nell’estate del 1996, quando, oltre al 36, cadono le occupazioni storiche di via del Pratello». Moltissime/i studenti sembrano non sapere (prima che non volere) rievocare quella storia, né le vicende dei decenni precedenti, e nemmeno quella recente dell’Onda del 2008 (che si materializzò a Bologna in Bartleby in via Capo di Lucca, sgomberato a inizio 2013), o quella recentissima della green guerrilla dell’albero in piazza Verdi (piantato a maggio 2013, in solidarietà con Gezi park). La questione non è tanto la scelta (più che legittima) di non appartenere al movimento (qui studentesco) e quindi di non rivendicarne la tradizione o l’eredità, quanto il rifiuto di fare vedersi politici in quanto studenti e riconoscersi (anche parzialmente) nella storia di chi, nell’università, si era vista/o politica/o.
Questa stessa scarsa coscienza politica delle/gli studenti ha permesso ad amministrazione comunale, Rettorato e Questura di ergersi a protettori di altre due categorie, oltre a quella delle/gli studenti «vere/i»: le donne e i lavoratori. Un episodio di molestia sessuale è stato sfruttato dalla narrativa della necessità di «mettere in sicurezza» l’area di via Zamboni e piazza Verdi, dove convivono pacificamente da anni episodi di microcriminalità (furti e rivendita di biciclette e spaccio di droghe leggere) e forze dell’ordine. La narrativa machista che si nasconde dietro la volontà di «tutela di lavoratrici e studentesse» è stata individuata e condannata dal blog Abbatto i muri («il corpo della donna […] viene strumentalizzato da una logica emergenzialistica e securitaria […] come giustificazione della repressione poliziesca, della caccia all’“immigrato” o al “tossico”») e dalle stesse studenti in corteo che hanno rivendicato la mobilitazione come «prima di tutto femminista e antisessista» specificando che «la zona universitaria è un luogo sicuro se viene attraversata da corpi che condividono e non da tornelli che dividono». Un documento sulla questione di genere è stato presentato anche all’Assemblea del giorno successivo, e alla strumentalizzazione della «faccenda dei tornelli» si allude nella presentazione del corteo bolognese del #lottomarzo.
Allo stesso modo, si è tentata la strada dell’opposizione tra lavoratrici/ori e studenti, soprattutto dopo la pubblicazione di una lettera aperta della Direttrice della BDU, Mirella Mazzucchi, che – legittimamente – lamenta «noi siamo bibliotecarie e veniamo esposte a tutto questo, noi che non c’entriamo nulla». La lettera è stata ripresa da tantissime/i studenti, come sostegno alla condanna dell’atteggiamento dei collettivi e rilanciata, con approvazione, dal sito neofascista Il primato nazionale. La distanza tra studenti e lavoratrici/ori, comunque, sussiste e, nel documento della seconda Assemblea (17.02), le/gli studenti riconoscono «la necessità di rafforzare il contatto con i lavoratori per rompere la cappa di soffocamento imposta dai vertici universitari», come quando, nella primavera 2014, i lavoratori e le lavoratrici di Unibo-Coopservice avevano scioperato in via Zamboni contro i contratti a 4 mesi e il salario a 2.80 euro netti all’ora, ricevendo la solidarietà di studenti, docenti e collettivi. Quanto all’opposizione tra studenti e docenti (magari precari/e) come pratica del divide et impera non è stato nemmeno necessario tentarla. Per ora, i docenti tacciono. L’Assemblea del 17.02 ha proposto di «scrivere un appello pubblico per far schierare il mondo accademico sull’ingresso della celere in Università» definendo assordante «il silenzio di professori, ricercatori e mondo della cultura».
Il gruppo delle/gli studenti che hanno riprodotto o fatto riprodurre, in questi giorni, queste retoriche generaliste è insieme enorme (e variegato, ovviamente, per quanto apparentemente compatto) e silenziosissimo: fino a ora si era sentito poco. Tuttavia, se un numero ampio di studenti non si riconosce nei collettivi, per quanto concordi potenzialmente o saltuariamente con le loro istanze o azioni, quello che si pone è un problema di rappresentanza. La questione, mi pare, trascende sia la crisi della rappresentanza come segno del tempo (peraltro, nelle ultime elezioni studentesche, ha votato il 12% delle/gli aventi diritto) sia l’impossibilità di identificazione con l’avanguardia del movimento studentesco: è un problema politico e di vita apolitica, del quale sono in parte responsabili l’autoreferenzialità dei collettivi (non solo quelli autonomi), l’arroganza poco accorta con la quale capita che agiscano e la distorsione mediatica che subiscono e provocano.
Tuttavia, secondo Radiocittà Fujiko, nel febbraio bolognese, «il tappo è saltato», tracimando anche la storica incompatibilità tra collettivi e le/gli altri studenti e la trista atarassia cui i media condannano i Millenials. Dall’Assemblea studentesca generale del 17.02, esce un comunicato che, con un’eco che non si sentiva da anni, si chiede: «come smontiamo la retorica securitaria sul degrado della zona universitaria, come iniziamo a parlare del processo di gentrificazione della zona universitaria e della desertificazione sociale di piazza Verdi, come facciamo a immaginarci un modello diverso di Università in netta contrapposizione a quello aziendalistico, asettico e privatistico imposto negli ultimi anni, come affrontiamo i problemi della nostra generazione senza futuro, precaria e condannata a voucher, come facciamo a opporci alla speculazione politica sul corpo delle donne».
Per gli anni nell’università ci abbiano insegnato il pessimismo della ragione e della volontà, di queste cose si sta parlando oggi a Bologna, è innegabile, dopo tantissimo tempo.







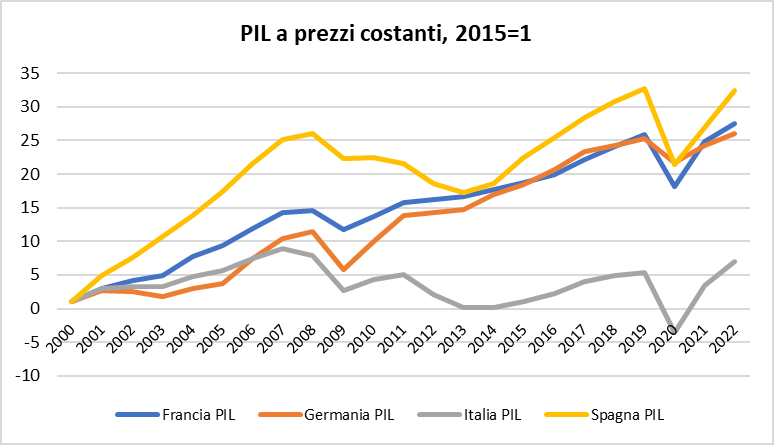
[…] e scegliesse di dedicarsi alla «riqualificazione della cittadella universitaria», cioè al controllo degli accessi agli spazi pubblici di via Zamboni, che cittadella non lo è mai stata ed è sempre stata […]