Alle radici del contrasto
C’è un solo aggressore, la Russia, ed un solo aggredito, l’Ucraina; quest’ultima è la vittima, l’altra è il carnefice. Di più non è consentito dire, pena l’iscrizione tra i seguaci di Putin con tutte le dannazioni conseguenti che in questi mesi sono state utilizzate dalla stragrande maggioranza degli organi di informazione, i quali hanno fornito un’informazione monotonica sullo svolgimento del conflitto con descrizioni raccapriccianti della barbarie russa.
Sono talmente tanti ed estremi i giudizi nei confronti della Russia, che si è superato un punto di non ritorno per cui viene da chiedersi se sarà mai possibile, un domani, ripristinare una qualche relazione con questo paese; se, insomma, non sia questo dell’Occidente, un atteggiamento risolutivo volto a precludere una qualsivoglia soluzione del conflitto che non sia la capitolazione della Russia e/o la sua disgregazione.
Lo scontro di civiltà
Il secolo scorso, improvvidamente definito “breve” da Hobsbwan, non sembra avere una fine. L’ultimo suo lascito, quello del 1989, grava ancora sul presente nonostante i numerosi tentativi di esorcizzarlo. Ci provò Francis Fukuyama nel 1992 col suo famoso libro dove, nel plaudire alla vittoria delle democrazie occidentali sul totalitarismo sovietico, scopriva implicitamente il lato oscuro di quella che lui definiva “fine della storia”, cioè che l’Occidente non sa vivere senza un nemico da combattere, altrimenti rischierebbe di rendere palese la contraddizione insanabile che c’è nei suoi principi fondanti: liberalismo economico e diritti fondamentali della persona.
A correggere Fukuyama ci provò Samuel Huntington con un saggio del 1993 (Lo scontro di civiltà) in cui sosteneva che la storia, in quanto espressione di conflitti, non era affatto finita essendo già evidente l’esistenza di altri nemici dell’Occidente che avrebbero portato a nuove guerre, non più combattute all’insegna della ideologia o dell’economia, ma della religione e della cultura1. In effetti si trattava di una esposizione grossolana (Edward Said la definì “Lo scontro di ignoranza”) di concetti preesistenti che aveva il solo scopo di riproporre l’immagine dell’Occidente contro tutti, con evidente ricorso alla retorica yankee che vede l’America circondata da odiatori, senza mai interrogarsi, peraltro, sul perché di tanto odio. Nella identificazione dei nuovi nemici, tuttavia, si delineava per la prima volta un asse tutto “orientale” incardinato, da un lato, sul fondamentalismo islamico e, dall’altro, sulla crescita impetuosa della Cina2.
L’Oriente, dunque, come fonte di nuove minacce in cui si riproponevano, attraverso lo scontro di civiltà, antiche diffidenze verso i popoli “levantini” (furbi, scaltri e imbroglioni) come gli arabi, assai diffuse fra le borghesie d’Europa dei secoli scorsi3, con l’aggiunta degli infidi cinesi che stavano dimostrando di apprendere in fretta (troppo in fretta!) le regole della concorrenza e del mercato. Non c’era però l’Est, cioè la Russia (all’epoca ritenuta fuori gioco) per quella inveterata discriminazione concettuale che l’Occidente esercita nei confronti di chi vive oltre certe latitudini: non a caso, quando ci si riferisce agli arabi o agli asiatici si parla di paesi del Medio o dell’Estremo Oriente, mentre per coloro che vivono oltre la sponda destra dei fiumi Oder-Neisse, vale ancora la definizione di paesi dell’Est, sottinteso europei, ma di rango inferiore.
A dare corpo ad una tesi, tutto sommato inconsistente, ci pensarono i neocon4 che nella seconda metà degli anni ‘90 dettero vita al PNAC ( Project for New American Century) e al NED (National Endowment for democracy) organizzazioni no-profit che praticavano la strategia delle “rivoluzioni a bassa intensità” per rovesciare governi in carica dei paesi dell’Est europeo mediante la creazione di apposite organizzazioni “non violente”. A partire dal 1998 l’attivismo di Otpor! (che vuol dire resistenza) portò alla cacciata di Milosevic e alla destabilizzazione della Serbia; Zubr operò in Bielorussia nel gennaio 2001; Kmara in Georgia nell’ Aprile 2003 e Pora in Ukraina nel giugno 2004, ognuna con il compito di mobilitare la società civile contro i regimi al potere.
Fu un successo per i neocon, che già dal 2001, dopo l’attacco alle torri gemelle, avevano preconizzato l’avvento della IV guerra mondiale (la terza era stata la guerra fredda vinta da Reagan nel 1989). A conclusione di un saggio dal titolo “La IV guerra mondiale: come è cominciata, cosa significa e perché dobbiamo vincerla”, scritto nel settembre del 2004, Norman Podhoretz, considerato un teorico dei neocon, scriveva: “La storia chiama l’America a combattere la battaglia della libertà per dare una vita migliore a milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ed è così dal 1947. Abbiamo trasformato (dopo la II guerra mondiale) in democrazie capitaliste l’impero giapponese e la Germania nazista in soli dieci anni, e dopo la fine della III guerra mondiale un processo analogo è in corso nell’Europa orientale. Perché non dovremmo riuscirci con il mondo arabo?”
Implicita, in questo apologetico richiamo alla guerra, la missione “civilizzatrice” dell’America, chiamata dal destino e dalla storia a scontrarsi con altre civiltà, rappresentate, a questo punto, non solo dalla Cina e dai paesi islamici come indicato da Huntington, ma anche dalla Russia nella quale residuavano, secondo i neocon di matrice trotskista,5 i germi del male.
La quarta teoria politica
S’è visto cosa ha prodotto questa civilization di marca statunitense: la destabilizzazione dei Balcani e la frantumazione della Jugoslavia; l’invasione dell’Afghanistan, ignominiosamente conclusasi dopo 20 anni con la fuga degli eserciti occidentali e il ritorno dei Talebani; la destabilizzazione del medio oriente con l’invasione dell’Irak di Saddam Hussein, motivata da false prove circa l’esistenza di armi di distruzione di massa; la regressione della Libia alla condizione di quando regnava Re Idris, con l’aggravante che le odierne fazioni in lotta per il potere, combattono una guerra ben più sanguinosa di quelle che si svolgevano fra le tribù del Fezzan e i Tebu o i Tuareg, fino a tutti gli anni ‘60 del secolo scorso.
Quanto poi a misurare in termini di libertà le ricadute di questa battaglia condotta dall’America, il bilancio è ancora più negativo se solo si pensa alla condizione delle donne, generalmente regredita ai livelli peggiori in tutti questi paesi, in conseguenza della reislamizzazione voluta da tutti i gruppi fondamentalisti (foraggiati e armati dagli Usa) contro le permissività di un Islam ritenuto troppo tollerante, come era quello esistente in Libia, Irak, Siria e nello stesso Afghanistan dell’era sovietica.
Con pochissime eccezioni, per lo più di impronta culturale o riferibili a minoranze politiche, nessuno in Occidente (tanto meno in Europa) si è posto il problema di quali nefaste conseguenze emergevano da questa nuova weltanschauung (visione del mondo) che postulava un mondo unipolare eterodiretto dagli Usa, con l’Europa acquiescente, ma tuttavia insofferente di veder “usurpato” il ruolo di paladino dell’Occidente da lei svolto per secoli, al punto da mettere in scena la macabra fine di Gheddafi per poi toccare l’apice della tracotanza con le vignette di Charlie Hebdo e i romanzi di Michel Houellebecq.
Tutto ciò non passa inosservato, tanto meno è gradito, da tutti quegli stati collocati al di fuori dei confini geopolitici dell’Occidente. Non piace all’America latina, da sempre vittima della dottrina Monroe; infastidisce il Sud est asiatico che sta tessendo nuovi rapporti con la Cina, ma soprattutto non piace ai Brics (Brasile,Russia,India,Cina e Sud Africa) che rivendicano un posto nella gerarchia internazionale in un mondo che si è fatto multipolare.
L’auto-candidatura dei Brics tuttavia, si basava soprattutto sulla loro capacità di incidere nell’economia internazionale e sul fatto di rappresentare il 40% della popolazione mondiale con una presenza diffusa in tutti i continenti, ma difettava di prospettiva globale, di una visione del mondo che sapesse competere con quella dell’Occidente. Visione che, con l’eccezione della Russia, non poteva venire dagli altri membri dei Brics, tradizionalmente estranei, per diversi motivi, a sviluppare una loro weltanschauung, al contrario della Russia che nel secolo scorso ebbe l’arditezza di metterla in pratica sovvertendo l’ordine costituito.
E’ in Russia infatti che nasce la “Quarta teoria politica” ad opera di Alexander Dugin, anche se in realtà, più che una teoria, essa rappresenta un punto di arrivo di una serie di considerazioni ricavate “per difetto” di teorie politiche precedenti. Come scrive lo stesso Dugin “La Quarta Teoria Politica è concepita come alternativa al post-liberalismo, ma non come una disposizione ideologica in relazione a un’altra. Essa, invece, è come un’idea incorporea opposta alla materia corporea; come possibilità che entra in conflitto con l’attualità, come ciò che deve ancora nascere attaccando ciò che già esiste.” E ciò che già esiste, ciò che costituisce l’attualità del mondo è il post-liberalismo, variamente coniugato, che poi è ciò che resta del XX secolo, quando si consumarono le altre due grandi ideologie: il comunismo e il fascismo. Di qui la “necessità” della Quarta teoria politica.
Premesso che un esame critico esauriente di questa teoria abbisognerebbe di più ampie considerazioni, non c’è dubbio che essa faccia presa sulle incertezze e le angosce che pervadono le società moderne, anche perché Dugin è molto abile nel dipanare il suo ragionamento, cioè dimostrare la fallacia delle teorie precedenti, e per di più non teme accostamenti spregiudicati.
Il fulcro da cui Dugin prende le mosse sta nel rifiuto della post-modernità e della globalizzazione che si presentano, nonostante la vittoria della prima teoria politica (il liberalismo) sulle altre due, come paradossi della modernità: in sostanza se il liberalismo si è servito ideologicamente della modernità per sconfiggere comunismo e fascismo (dimostratisi non all’altezza delle sfide poste dal liberalismo), oggi questo guscio ideologico non serve più e dunque la forma-mondo attualmente dominante (il post-liberalismo), unitamente alla globalizzazione, se ne disfa, lasciando l’essere umano indifeso, disorientato da una realtà dove alla dittatura delle idee, si è sostituita la dittatura delle cose.
In questo passaggio lo sviluppo tecnologico ha sostituito l’Essere ed ha aperto la strada al nulla della società postmoderna che Dugin, recuperando Heidegger, colloca nel “nichilismo occidentale” che a sua volta marca la modernità portatrice di anti-valori, come il “pensiero calcolatore”, o di vere e proprie apnee esistenziali, come l’alienazione, invano sorretti dalla permissività che si veniva offrendo all’individuo attraverso l’uso apparentemente illimitato di cose messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico.
Sembrerebbe qui che Dugin recuperi in qualche modo “la contraddizione” marxiana esistente fra lo sviluppo delle forze produttive e i rapporti sociali da queste determinati, ma non è così. Nell’illustrare la quarta teoria politica egli si tiene alla larga da Marx, evita di incrociarne l’innovazione analitica sia dal punto di vista filosofico che politico, preferendo criticare il marxismo per aver contribuito alla perdita delle radici esistenziali e spirituali dell’uomo (ontologiche e teologiche), piuttosto che riferirsi alla sua condizione materiale nella società liberista (che è anche e soprattutto capitalista), analisi che il marxismo ha condotto in modo ineguagliabile, come lo stesso Dugin riconosce. Ciò lo conduce a cercare moventi per la sua teoria estremamente “fattuali”, legati all’attualità o, quando serve, al recupero della tradizione in funzione anti-moderna, e quindi ad aggirare il confronto sul piano strettamente filosofico e a privilegiare quello metafisico. Come lui stesso scrive: “Dobbiamo fare riferimento ai fondamenti filosofici della storia e compiere uno sforzo metafisico per risolvere i problemi attuali: la crisi economica globale, il contrasto al mondo unipolare, nonché la conservazione e il rafforzamento della sovranità, e così via.”
Non si creda, tuttavia, che il suo sia un “racconto” ideologico nel senso deteriore del termine. Tutt’altro: la sua prosa è raffinata, estremamente dotta e, sopratutto, abile nel cogliere ciò che di “valido” c’era nel comunismo e nel fascismo al fine di contrastare la post-modernità: “La seconda e la terza teoria politica devono essere riconsiderate, selezionando in esse ciò che deve essere scartato e ciò che ha valore in sé.” Dunque un uso della storia e della teoria decisamente strumentale per i fini della Quarta teoria politica, al limite della decenza concettuale quando condanna, senza distinguerli, l’antifascismo e l’anticomunismo; anche se -precisa Dugin – i nuovi principi e le nuove strategie su cui questa teoria si fonda devono essere ancora sviluppati, né si può pensare che la sfida alla post-modernità possa essere assunta da un solo paese (il modello sovietico ci ha provato ed è crollato) onde per cui l’affermazione del concetto di multipolarità è il primo obiettivo da conseguire. Attenzione però a ritenere, come fanno anche i più accorti osservatori occidentali (vedi Limes), che multipolarità alluda tout court alla proposizione di un euroasianismo da contrapporre all’occidentalismo dominante, in ciò traducendo, banalmente, le relazioni privilegiate che intercorrono oggi tra Russia e Cina. L’euroasianismo per Dugin non è altro che un episteme, ovvero un insieme di conoscenze che non ha fondamenti filosofici o politici comuni e non potrebbe essere altrimenti, non solo perché storicamente Russia e Cina si sono più scontrate che incontrate, ma perché la Quarta teoria politica è inequivocabilmente ancorata alla cultura europea, ma distante e avversa all’Occidente moderno che Dugin descrive così in una intervista rilasciata appena dopo l’inizio della guerra in Ucraina:” L’Occidente moderno, dove trionfano i Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates e Zuckerberg, è la cosa più disgustosa della storia del mondo. Non è più l’Occidente della cultura mediterranea greco-romana, né il Medioevo cristiano, e nemmeno il ventesimo secolo violento e contraddittorio. È un cimitero di rifiuti tossici della civiltà, è anti-civilizzazione.”
Da questo punto di vista la Quarta teoria politica non manca di fornire strumenti per distinguere ciò che è cultura da ciò che si intende per civiltà, ma come per il concetto di universalismo (la cui critica, come vedremo, non è all’altezza di quella sviluppata da Samir Amin), trattasi di usum Delphini di temi di grande rilevanza politica, oltre che storica, in quanto introdotti per corroborare la tesi della battaglia contro la post-modernità che i russi e la Russia stanno combattendo da tempo.
Qui c’è una allusione forte al ruolo e ai rapporti problematici che la Russia ha sempre avuto con l’Occidente: “Le menti russe più brillanti hanno visto chiaramente che l’Occidente si stava muovendo verso l’abisso. Ora, guardando a dove l’economia neoliberista e la cultura postmoderna hanno condotto il mondo, possiamo essere certi che questa intuizione, che ha spinto generazioni di russi a cercare alternative, fosse completamente giustificata” e nell’intervista sopra citata, Dugin rafforza questa sottolineatura “russa”, arrivando a dire:” La Russia sta creando un campo di resistenza globale. La sua vittoria sarebbe una vittoria per tutte le forze alternative, sia di destra che di sinistra, e per tutti i popoli. Stiamo, come sempre, iniziando i processi più difficili e pericolosi.”
Quest’ultima frase in particolare – Stiamo, come sempre, iniziando i processi più difficili e pericolosi – deve essere suonata come una terribile minaccia alle orecchie delle borghesie occidentali, massimamente a quelle europee, perché, oltre all’evidente richiamo all’ottobre rosso, evoca tutta la dirompente forza politica e culturale di cui è stata portatrice l’eterodossia russa.
La bestia nera dell’Occidente
E’ difficile immaginare qualcosa di più ingiurioso e sprezzante dei giudizi e degli epiteti che sono stati indirizzati dall’inizio della guerra in Ucraina a Vladimir Putin e, attraverso di lui, all’intera Russia; neanche quando i carri armati sovietici invasero le strade di Budapest e Praga si giunse a tanta scompostezza di giudizi e di atteggiamenti anti russi.
Quando negli ambienti della cultura e dello sport, per esempio, si arriva ad annullare i concerti di Tchaikovsky o Rachmaninov, ad impedire le esibizioni di concertisti perché russi e a professori italiani di tenere lezioni su Dostoevskij; quando si espellono gli atleti russi dalle competizioni e si toglie la bandiera russa ad una damista6 mentre gioca la sua partita con una avversaria polacca, vuol dire che si è andati oltre le manifestazioni di “sdegno” che possono accadere in simili circostanze. C’è un tratto, in questi comportamenti, di profonda ostilità verso tutto ciò che è russo; c’è del livore, tanto più inaspettato, in quanto proviene da istituzioni che si vorrebbero (e che si dichiarano) scevre da pregiudizi, quasi che gli odierni russi, oltre che della guerra all’Ucraina, fossero chiamati a rispondere di precedenti colpe; una nemesi storica insomma, per tutto ciò che di imperdonabile avrebbe commesso la Russia agli occhi del moderno Occidente.
La rivoluzione del 1917 è senza dubbio la madre di tutte le colpe che si addebitano alla Russia e nonostante il suo leader attuale, l’esecrato Putin, abbia fatto di tutto per relegarla nell’oblio, essa pesa ancora nell’immaginario collettivo delle borghesie europee: eppure non fu la prima, né la più efferata che si svolse entro i confini del vecchio continente.
Quando Shakespeare fa dire al prode Harry Percy (Hotspur) “Se noi viviamo, viviamo per calpestare i re”,7 non sa quale potente argomento consegna alla storia delle rivoluzioni, tanto meno immagina che cento anni dopo la prima testa di re ad essere mozzata sarebbe stata quella di Carlo I sovrano d’Inghilterra. Cromwell, tuttavia, non fu così feroce verso la nobiltà inglese (lo fu molto di più verso i seguaci della monarchia irlandesi e scozzesi) quanto lo furono Robespierre e i giacobini nei confronti di quella francese, che di morti eccellenti ne conta forse di più di quelli della rivoluzione russa. Non è dunque lo spargimento di sangue o l’imposizione della violenza che fa la differenza con l’ottobre rosso, quanto il fatto che le rivoluzioni precedenti avevano fatto salvo il principio della inaccessibilità al potere per le classi subalterne, predisponendo, nel contempo, quel ricambio fondamentale tra aristocrazia e borghesia assolutamente indispensabile alle magnifiche sorti del capitalismo in divenire. Questo andamento, che i comunardi avevano tentato di deviare nel 1871 risultandone sterminati senza alcuna pietà, si arresta irrimediabilmente nel 1917 quando i “cafoni”, quelli che Ignazio Silone diceva venir molto dopo i cani delle guardie del principe8 riescono a riscattare la propria dignità di esseri umani con un atto senza precedenti, tanto che Lenin, conversando con Gorkj, potè esprimersi con queste parole: “Ci siamo assunti il compito gigantesco di far alzare in piedi il popolo, di dire al mondo tutta la verità sulla vita; proprio noi indichiamo ai popoli l’unica strada che può condurli verso una vita umana, emancipandoli dalla schiavitù, dalla miseria, dall’umiliazione.”9 E negli anni a venire del secolo scorso non furono pochi i popoli, a cominciare dai cinesi, che intrapresero questo cammino: ma il peccato originale è rimasto comunque intestato ai russi e per quanto lontano e dimenticato, non c’è battesimo che possa, ancora oggi, cancellarlo agli occhi delle borghesie europee, nonostante gli sforzi di Putin, che nel 2008 ha persino riabilitato i Romanov riconoscendo loro di essere stati vittime della repressione politica del comunismo.
Tuttavia ci dev’essere dell’altro che, implicitamente, si addebita alla Russia se oggi le elites europee le si scagliano contro con una veemenza che non risparmia nulla di ciò che storicamente e culturalmente ha rappresentato questo paese.
La frase di Herzen10 secondo cui la storia della Russia inizia nel 1812 è quanto mai utile al fine di comprendere i controversi rapporti che si svilupparono tra l’Occidente europeo e la Russia. Nei secoli precedenti infatti essa era stata attraversata da contrasti di ogni genere (etnici, religiosi) e da guerre sia interne che esterne (Svezia e Polonia) che ne avevano fatto una sterminata “terra di confine” tra Oriente ed Occidente dove l’idea di “progresso” era recepita, di volta in volta, o come dannazione o come viatico per l’emancipazione. Se con il regno di Pietro il grande la modernizzazione della Russia sembra coincidere con la sua occidentalizzazione (peraltro segnata da guerre e repressioni sanguinose) essa, agli occhi del mondo, non è ancora una nazione, ma una immensa espressione geografica in cui i “russi” stentano ancora ad identificarsi (e ad essere riconosciuti) come tali: lo stesso Voltaire, parlando della biografia che stava scrivendo su Pietro il grande ebbe a dire “Niente di più noioso per un parigino di certi dettagli sulla Russia”.11
Eppure i costumi e le idee occidentali, segnatamente quelle derivanti dall’illuminismo, erano molto diffuse in Russia e particolarmente apprezzate dalla nascente borghesia russa di fine ‘700, ma dopo la rivoluzione francese l’”illuminata” Caterina proibì la vendita dell’Encyclopedie e ruppe le relazioni diplomatiche con la Francia.
In questo contesto storico si delinea quella interpretazione della storia russa (il cui eco risuona, non di rado, ancora oggi) che vede contrapporsi occidentalisti e slavisti sulla effettiva natura della Russia (europea o slava?) come se ciò fosse la causa e non l’effetto di una incompleta formazione delle classi che vedeva la borghesia, “occidentalista e progressista”, profittare senza ritegno dello spregevole retaggio della servitù della gleba, come fa il Consigliere Cicikov, protagonista delle Anime morte di Gogol. Di converso non è lo “slavismo” a far decidere l’imperatrice Caterina (tutt’ora dipinta sui libri di storia come un despota illuminato) di rompere le relazioni con la Francia giacobina, ma l’imperativo del potere costituito che le viene, oltre che per investitura, dalla sua appartenenza di classe.
Lo scarto tra la Russia e l’Occidente non sta nella presunta forza dello slavismo ma in ciò che, alle soglie dell’800, ancora le difettava, certamente in termini di formazioni delle classi, ma prima ancora di una identità nazionale e di una cultura e letteratura popolare (nel senso attribuitogli da Belinskij)12 che non si presentasse come derivazione di quella occidentale, pur in presenza di una intelligencija russa che in quella fase riteneva assolutamente necessario diffondere i valori dell’Occidente.
Col 1812, invasione napoleonica, si compie il primo passaggio epocale per la Russia che nella resistenza popolare alla Grande Armata trova i presupposti della sua identità nazionale e dell’inizio di una nuova storia dove la letteratura (e i letterati) avranno un ruolo preminente ed eterodosso rispetto alla cultura occidentale.
E’ in questo secolo che si consuma, non senza contrasti, lo stacco culturale – prima ancora che politico- con i valori fondanti del moderno Occidente (il senso della cristianità, il razionalismo della modernità, l’etica hegeliana) secondo una via di fuga che ne anticipa le tendenze e ne contesta, talvolta, l’essenza stessa
E’ dei russi l’introduzione del realismo in letteratura, il tratteggio non idealistico dei personaggi, di cui invece si predilige descrivere la verità di esseri umani, soggetti alle debolezze ed incoscienti del significato della loro esistenza: così si presentano l’ Oneghin di Puskin, annoiato esponente dell’alta società, e lo “spregiuducato” Peciorin di Lermontov. Un eroe negativo, quest’ultimo, e non un antieroe che fatalmente sarebbe stato ricompreso nell’antiretorica della modernità. No, Peciorin anticipa di un secolo le controtendenze delle avanguardie novecentesche in termini di amoralità ed indifferenza verso i canoni dominanti dell’espressione letteraria. Come scrive Belinskij “Ciò non poteva accadere che attraverso l’esclusivo rivolgimento dell’arte alla realtà, al di fuori di ogni ideale”, impresa che Belinskij riconosce massimamente a Gogol (ucraino di nascita, ma inscindibile dalla storia letteraria della Russia) anche se poi, prima della morte dello scrittore, capovolse il suo giudizio.
Come fu accolta in Occidente questa Novelle vague ante litteram? Con diffidenza e fastidio, spesso manifestamente legate all’opinione che le elites culturali avevano dei russi: Victor Hugo disprezzava in blocco gli scrittori russi, particolarmente Tolstoj; per Schiller l’animale che più raffigurava il popolo russo era il maiale; Heine, che pure era un intellettuale contro corrente, data la sua appartenenza alla superiore scuola tedesca, non li riteneva degni di nota. Nessuno insomma che desse credito al ribollire della società russa, dalla letteratura alle tensioni di carattere politico (si pensi al movimento decabrista che anticipa nei tempi – non nelle forme – i moti rivoluzionari del 1848): del resto lo stesso Marx non avrebbe scommesso un copecko sulla possibilità di una rivoluzione proletaria in Russia!
Più tardi (e dopo Dostojevskij) ci furono gli apprezzamenti di Proust e di Freud; ma il primo nel manifestarli attraverso le parole dell’io narrante de “La prigioniera”, non riesce a nascondere l’edonistica curiosità del suo ceto per il tema ricorrente della morte che perseguita i personaggi di Dostojevskij, come a dire: perchè farli morire quando potrebbero tranquillamente vivere altrimenti i loro drammi? Quanto a Freud la sua è una ammirazione piena dell’opera dello scrittore, anche se poi definirà Dostojevskij un “istero-epilettico”. 13
Fu Joseph Conrad tuttavia, con un vero e proprio romanzo (Con gli occhi dell’occidente), ad esprimere il maggior grado di ostilità verso tutto ciò che rappresentava la Russia. Qui non c’è scampo alcuno per i protagonisti russi, descritti, ora come esaltati assassini, ora come abietti individui pronti al tradimento e all’inganno. Anche mettendo in conto le sue origini polacche e il suo conservatorismo, l’odio di Conrad per i russi (compresi Tolstoj e Dostoevskij) diviene in questo libro, emblematicamente, l’odio dell’Occidente che giudica tutto ciò che è russo con gli occhi della sua presunta superiorità morale, spirituale e culturale che, nel mentre perdona “l’orrore” delle aberrazioni del colonialismo occidentale attribuendole all’imperfezione umana di Kurz, protagonista di Cuore di tenebra, condanna senza appello le idee e gli uomini che avevano dato vita alla rivoluzione del 1905 in Russia.
La critica ignorata del Grande Inquisitore
Della “parabola” del Grande Inquisitore14 si è sempre celebrata la grandezza del Cristo che, dopo aver ascoltato in silenzio tutte le colpe addebitategli, sorride al suo accusatore e nell’atto di congedarsi da lui lo bacia sulla bocca. Un atto di grandissimo amore come solo il Cristo, tornato sulla Terra 1500 anni dopo la sua morte per conoscere quale fosse lo stato della condizione umana, può fare senza doversi né giustificare né ripetere: il verbo suo diffuso tra i mortali e tutte le sue opere terrene fino all’estremo sacrificio della morte, sono una testimonianza eterna che non ha bisogno di repliche. Per questo Cristo tace di fronte al suo inquisitore, così come 1500 anni prima aveva taciuto di fronte alle domande incalzanti di Pilato che gli chiedeva: che cos’è la Verità?
Questa è, senza dubbio, l’interpretazione più bella ( e più diffusa) dell’artificio letterario concepito da Dostoevskij per celebrare la grandezza di Cristo, ma è anche una interpretazione di comodo perché col riferirsi alla ben nota religiosità dell’autore, si evitano gli interrogativi filosofici che emergono dalle accuse che il protagonista (il Grande Inquisitore) rivolge al Cristo redivivo.
Non tragga in inganno il fatto che l’incontro tra Cristo e l’Inquisitore avvenga a Siviglia e non in un luogo immaginario: la scelta della Spagna, patria della più feroce inquisizione, serve esclusivamente ad imprimere maggiore drammaticità all’incontro e non a indicare una particolare sottolineatura delle aberrazioni della Chiesa spagnola. Ne è prova il fatto che mai, nel suo lungo monologo, l’Inquisitore vi faccia riferimento, nemmeno per giustificarsi; anzi, nel formulare le sue accuse egli parla a nome di tutta la chiesa romana rivendicandone l’operato millenario in difesa dell’umanità, cosa che Cristo, questa è l’accusa fondamentale, aveva rifiutato di fare preferendo dare agli uomini la libertà di sbagliare con la promessa del pane celeste, invece di assicuragli il pane su questa terra. Siamo stati noi (la Chiesa), dice l’Inquisitore rivolgendosi a Cristo, a rimediare al tuo errore che avrebbe salvato solo i forti di spirito i quali, per quanto numerosi tu li abbia immaginati, sono assai meno della sterminata massa di deboli che non sanno come affrontare le necessità della vita terrena. Chi se ne sarebbe curato? Noi abbiamo pensato a loro, ci siamo presi sulle spalle il fardello della loro libertà e del loro governo che seguiteremo ad esercitare in tuo nome, ingannandoli ancora per tutto il tempo che sarà necessario.
Gli uomini, osserva l’Inquisitore, sono dominati da coloro che dominano le loro coscienze e nelle cui mani si trova il pane che a loro necessita e noi li convinceremo che diventeranno liberi solo quando rinunceranno alla loro libertà per noi. Se non avessimo rettificato il tuo credo fondendolo con quelli del mistero, del miracolo e dell’autorità, gli uomini non avrebbero trovato pace ai loro tormenti. Noi ci siamo fatti Cesari per portare a termine la nostra opera che è quella di unificare il genere umano nella pace e nella prosperità, cosa che tu hai rifiutato a suo tempo: perché dunque torni a disturbarci?
Dostoevskij mette in bocca queste parole al Grande inquisitore perché ciò gli è richiesto dalla costruzione letteraria del racconto, ma a parlare non è più lui, bensì l’essenza del potere che si è spogliato di qualsiasi veste e si esprime come potrebbe fare un capo di governo, un banchiere o un capitano d’industria, vale a dire oltre la dimensione temporale del potere della Chiesa che, una volta venuta a patti coi Cesari dell’antichità, condivideva, già nell’800, la gestione dell’umanità col figlio prediletto della modernità – l’illuminismo – secondo una logica di totale assoggettamento ad un unico pensiero dominante, come si coglie inequivocabilmente nella parte finale del discorso dell’Inquisitore: “Si, noi li costringeremo a lavorare, ma nelle ore di riposo organizzeremo la loro vita come un gioco di bimbi con canzoncine, cori, danze innocenti. Oh, noi permetteremo persino che essi commettano peccato – sono creature così deboli e fragili – e loro ci ameranno come dei bambini per il fatto che noi permetteremo loro di peccare. Noi diremo loro che qualsiasi peccato sarà espiato a patto che venga compiuto con il nostro permesso; e noi permetteremo loro di peccare perché li amiamo e ci accolleremo la punizione per questi loro peccati. Ci accolleremo la punizione e loro ci adoreranno come i benefattori che hanno assunto su di sé il peso dei loro peccati davanti a Dio. E non avranno nessun segreto per noi. Noi permetteremo – o vieteremo – loro di vivere con mogli e amanti, di avere o non avere figli – tutto secondo la loro docilità – e loro ubbidiranno con gioia e allegria. Anche i segreti più tormentosi della loro coscienza, tutto, tutto essi ci riferiranno e noi troveremo una soluzione per tutto e loro confideranno nella nostra soluzione con gioia, poiché essa libererà loro dal grande assillo e dalle tremende pene che adesso patiscono per giungere ad una decisione libera, personale.”
E’ un fatto che i libri di Dostoevskij non furono ben accolti subito in Russia, tanto meno in Occidente, ma se infine se ne riconobbe l’importanza, tra cui quella di aver introdotto in letteratura il “romanzo filosofico”, riguardo ai contenuti dei Fratelli Karamazov” si è sempre preferito sottolineare aspetti come la pulsione al parricidio, l’espiazione o i controversi rapporti tra fratelli, tutti ambiti che possono ancora risultare “coerenti” con i canoni della cultura occidentale: ma non c’è stata critica che abbia mai avuto il coraggio di sottolineare il significato del monologo del Grande Inquisitore, che è e resta una critica senza precedenti alla struttura stessa dell’Occidente, ai suoi valori, alle sue glorie, al suo apparire come un inesauribile inganno per l’uomo. E questo l’Occidente non lo ha mai perdonato.
Pressappoco un secolo dopo, a rinnovare lo “sgarbo” verso i valori dell’Occidente, ci pensò Yuri Gagarin “Cosmonauta sovietico, figlio del proletariato, figlio della scienza, che assaltò il cielo e volò tra le stelle”15 che per il solo fatto di essere russo e di essere stato il primo uomo nello spazio (seguito a due anni di distanza da Valentina Tereskova, anch’essa russa e prima donna nello spazio) aveva incrinato l’immagine di superiorità dell’Occidente. Ma Gagarin mentre era in volo, nel suo genuino realismo di russo – non l’artefatto realismo socialista – ebbe l’indelicatezza di dire “Da quassù la terra è bellissima, senza frontiere, nè confini” che già di per sé metteva in discussione i concetti di nazione e nazionalità tanto cari all’Occidente, ma poi, una volta a terra, aggiunse: ”Sono stato lassù e non ho trovato nulla. Nulla: non c’è dio nel cielo, ne angeli, ne marziani. Noi siamo soli.”16 Una imperdonabile sfrontatezza che dopo l’inizio della guerra in Ucraina ha provocato più di un attacco alla sua memoria.
Sì, l’Occidente europeo e poi anche americano, non tollera che si metta in discussione il suo primato in nessun campo. La sua civiltà si “è fatta da sola” ed è la migliore al mondo per cui tutti gli altri popoli le sono debitori e se mai è successo o succederà che altre culture la sopravanzino in qualcosa, sarà sempre discrezione dell’Occidente riconoscerne il valore, con tutti, meno che verso la Russia, la Bête Noire, a cui persino nella comunicazione corrente o nella cultura pop è riservato solo spregio, diffidenza e oblio.
Per i media europei quelli che da noi sono chiamati rispettosamente imprenditori o manager, in Russia sono, spregiativamente, oligarchi, mentre gli uomini politici, che da noi si omaggiano del titolo di onorevoli, in Russia diventano ineluttabilmente degli autocrati.
Quanto alla cultura pop gli esempi non mancano. Basta pensare che il titolo di “concerto del secolo” è universalmente riconosciuto a quello tenuto il 13 luglio 1985 in contemporanea tra il Wembley stadium di Londra e il John F. Kennedy Stadium di Philadelphia (Live Aid) da una schiera di rockstar a beneficio dell’Etiopia, colpita da una tremenda carestia.
Esattamente 43 anni prima, il 9 agosto del 1942, nella città di Leningrado, si teneva un concerto dove fu suonata la VII sinfonia di Dmitry Shostakovich, nota anche come sinfonia di Leningrado. Shostakovich cominciò a comporla nel 1941 mentre prestava servizio a Leningrado come pompiere. La sua esecuzione nella città assediata e bombardata dalle truppe naziste da oltre 500 giorni, dove i morti fra i civili furono centinaia di migliaia, fu considerato un atto unico nella storia della musica e dette un impulso enorme alla resistenza di tutto il popolo russo, tanto da far dire a David Ojstrach (tra i più famosi violisti del ‘900) che “La musica di Shostakovich suonava come un’affermazione profetica sul fascismo, come una generalizzazione poetica dei sentimenti patriottici del popolo, la loro fede nel trionfo dell’umanesimo.” Ma di questo concerto non c’è più memoria nei media occidentali, nel mentre che si celebrano come “impegnate” in senso pacifista, canzoni come Russians, di Sting, del 1985 – recentemente riproposta dall’autore in appoggio “ai coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia”- dove il ritornello dice: “Spero che anche i russi amino i loro bambini” come a dire che la cosa non è così scontata come per noi occidentali. Appena un anno prima, 1984, un cantautore come Lucio Dalla cantava “Se io fossi un angelo” dove c’è una strofa che recita così: “ E’ chiaro che volerei – Zingaro libero- Tutto il mondo Girerei- Andrei in Afghanistan- E più giù in Sud Africa- A parlare con L’America- E se non mi abbattono- Anche coi russi parlerei” dove emergono due aspetti: uno è la condiscendenza dell’autore che si dichiara disposto persino a parlare con i russi; l’altra è che si dà per scontato che i russi, a differenza di tutti gli altri popoli menzionati, ti sparano senza nemmeno farti aprire bocca.
Sono ancora e soltanto gli occhi dell’Occidente di cui scriveva Conrad a giudicare tutto ciò che è russo.
NOTE
[i]https://www.labottegadelbarbieri.org/comparazioni-tra-due-guerre-lannullamento-della-dialettica-e/
1“La mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell’umanità e la fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura. Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro” – The clash of civilization – Samuel P. Huntington, 1993
2“Quei paesi che per ragioni di cultura e di potere non vogliono o non possono entrare a far parte dell’Occidente competono con l’Occidente sviluppando il proprio potere economico, militare e politico. Lo fanno promuovendo il loro sviluppo interno e collaborando con altri paesi non occidentali. La forma più importante di questa cooperazione è la connessione confuciano-islamica che è emersa per sfidare gli interessi, i valori e il potere occidentali.” – The clash of civilization – Samuel P. Huntington, 1993
3 “Il levantino non è inferiore perché levantino, e perché ha il muso somaticamente fatto così e così. Ma perché ha
l’anima degenere, la quale si raffigura ed esteriorizza anche in un volto e in uno sguardo degeneri». Dalla rivista
“La Difesa della razza” 1938-1943
4Con questo termine si identifica la componente repubblicana che più ha dato impulso alla politica di G.W. Bush. A periodi alterni vi hanno aderito personalità di spicco della politica statunitense come: Elliott Abrams; Richard Armitage: John David Ashcroft; Zbigniew Brzezinski;Douglas Jay Feith; Francis Fukuyama ;Newt Gingrich; Robert Kagan; Henry Kissinger; Richard N. Perle; Norman Podhoretz ;Karl Rove; Donald H. Rumsfeld.
5 Secondo Michael Lind (figura di spicco dell’establishment Democratico), l’origine dei neocon americani va ricercata anche a sinistra. “Essi sono il prodotto dell’influenza della componente ebreo-americana sul movimento trotskista tra il 1930-1940, metamorfizzatosi in movimento liberista e anti comunista tra gli anni ’50 e ’70 e, più recentemente, in una sorta di dottrina militaristica e imperiale che non ha precedenti nella storia politica e culturale dell’America”. Quanto ad una loro caratterizzazione strutturale, così li definisce l’autorevole Foreign Police in Focus: “Disillusi prima dal socialismo e comunismo e poi dai Neo Democratici (come Mc Govern) che dominavano il Partito Democratico negli anni ’70, i neocon hanno avuto un ruolo fondamentale nel portare la Nuova Destra alla ribalta negli anni ’80. Per la maggio parte i neocon, che sono indifferentemente cattolici od ebrei, non sono dei politici in senso stretto, ma analisti, attivisti ideologici ed esperti in varie discipline che hanno molto contribuito alla creazione di think-thank di destra, gruppi di pressione e fondazioni. Essi hanno un credo profondo nella superiorità morale dell’America e ciò facilita le alleanze con la destra cristiana e altri gruppi conservatori.
6Qui il video: https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/05/05/news/la-damista-senza-bandiera-2325578/
7William Shakespeare -Enrico IV, parte prima, atto V, scena II – traduzione di G. Baldini, Rizzoli Milano, 1963
8Fontamara, Ignazio Silone 1949. Michele, uno dei protagonisti del romanzo, richiesto da un forestiero su quale fosse l’idea di gerarchia sociale che aveva la gente del luogo, così risponde: “In capo a tutti c’è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi, nulla. Poi, ancora nulla. Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può dire che è finito.”
9Citazione ripresa da “I senzapatria” di Dario Paccino
10Alexander Herzen, scrittore e filosofo russo
11Citazione ripresa da “Storia della Russia moderna” di Lionel Kochan – Einaudi 1968
12Vissarion Grigor’evič Belinskij, il più grande critico letterario russo autore, tra l’altro, di “Uno sguardo alla letteratura russa nell’anno 1847”
13Vedi nota 11
14I fratelli Karamazov di Fjodor Dostoevskij
15Da un manifesto apparso sui muri di Roma nel cinquantenario del volo di Gagarin
16 Citazione dal libro Exotropia di Fabio Marchesi Edizioni Tecniche nuove- 2006


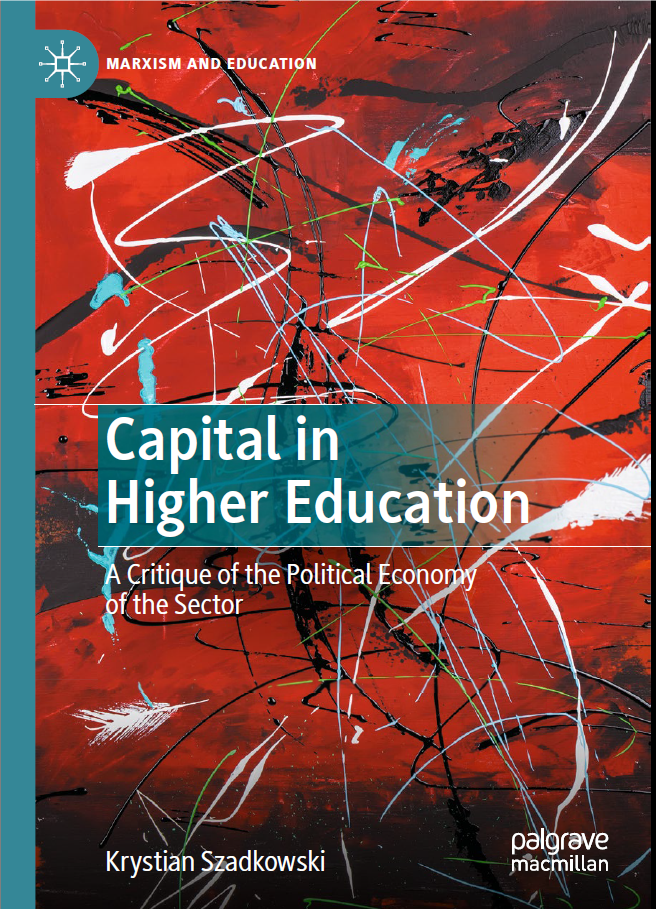





Scrivi un commento