Il dispotismo politico-economico.
Il primo paradosso, di natura economico-politica, è che il dispotismo politico, oggi rappresentato dal governo Draghi, non è più semplicemente una conseguenza del dispotismo economico ma ne è regia. Se ai tempi di Renzi l’approvazione del Jobs Act rientrava nella logica di accondiscendenza della politica ai poteri forti economici, oggi assistiamo, paradossalmente, a un ritorno della “politica” ma intesa, sia chiaro, come dirigismo e accentramento del potere, indipendente da altre componenti, in teoria fondamentali, della società cosiddetta “democratica”. Ciò avviene in contemporanea (e grazie) al completo svilimento delle prerogative parlamentari come organi legislativi e deliberativi. Dopo trent’anni, arriva così a compimento un processo che rende reale l’esistenza di un autoritarismo elitario, che vede nei “governi tecnici” il perfetto strumento di attuazione del dispotismo; nel decreto legge la sua pratica legislativa; nella figura del premier l’incarnazione (quasi mistica) della governance politico-economica. Il parlamento, ridotto di numero per volere degli italiani e già da anni semplice organo di ratifica, perde così anche i suoi ultimi ruoli formali.
Tale transizione ha avuto il suo battesimo nella presentazione del PNRR nello scorso luglio. Reso noto tre giorni prima della scadenza per l’invio a Bruxelles, Camera e Senato lo approvano senza la men che minima discussione. Ma non basta. La versione finale e ufficiale inviata in Europa incorpora delle modifiche rispetto al testo presentato al parlamento. E non si tratta solo di modifiche formali, dal momento che in quest’ultima versione scompare ogni riferimento, precedentemente presente (seppur in modo vago), alla necessità di introdurre un salario minimo orario in Italia, sul modello tedesco. Il parlamento non ha dunque neanche ratificato il testo finale, in un silenzio quasi totale.
Sempre in prossimità dell’estate, il Ministro del lavoro, Andrea Orlando, dichiara che a settembre sarà pronta la bozza della riforma (in senso universalistico, si dice) degli ammortizzatori sociali. Sulla base di tale promesse, nel decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021si dichiara la fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 31 ottobre seguente (con alcune deroghe), in tempo per l’entrata in vigore della riforma che avrebbe dovuto attutire gli eventuali scompensi occupazionali. A fine 2021, i licenziamenti sono partiti alla grande, ma della riforma degli ammortizzatori non si hanno più notizie. Tutto ciò senza che mai si sia verificato un dibattito parlamentare.
Ma veniamo all’oggi. Della firma del trattato tra Italia e Francia e del suo contenuto ancora oggi non formalizzato ha parlato su queste pagine Gianni Giovannelli. Tale accordo, nonostante il dettame costituzionale lo preveda, non solo non è stato discusso in Parlamento ma neanche ratificato con un voto formale. Inoltre, è stato firmato esclusivamente dallo stesso presidente del consiglio e non dal Presidente della Repubblica: secondo l’art. 80 e 87, comma 8, della carta costituzionale, infatti, è necessaria una legge con la quale il parlamento autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il testo e fino ad allora le clausole sono prive di efficacia.
La “non-riforma” fiscale
Veniamo, ora, alla legge finanziaria e al decreto fiscale, frutto di un accordo tra i partiti di governo, esito di una decisione extraparlamentare, che ha prodotto in questi giorni l’ennesimo decreto legge di questo governo. I punti di tale riforma dovrebbero essere noti. Per quanto riguarda la tassazione sui redditi (Irpef), le aliquote scendono ulteriormente da 5 a 4. Quando nel lontano 1974 entrò in vigore la riforma Visentini, con la nascita dell’Irpef e dell’Irpeg come tassa sui redditi delle persone fisiche e giuridiche a prescindere dalla condizione professionale, le aliquote erano improntate ad una forte progressività (ben 27, dal 10% al 72%). Dopo più di 100 anni dalla nascita dello Stato italiano, veniva così sancito il principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle tasse! Principio, che, in realtà, ha avuto un’applicazione imperfetta, dal momento che il sistema fiscale italiano non si è mai adeguato ai mutamenti dei processi di creazione della ricchezza ed è di fatto rimasto ancorato ad una visione fordista della società. Di fatto, l’imposizione fiscale faceva (e fa) perno sulla tassazione del lavoro dipendente e della proprietà dei mezzi di produzione. Se il primo cespite ha subito nel corso degli anni un forte calo nella progressività delle aliquote con un aumento delle aliquote intorno al 35% nella fascia tra i 25.000 euro e i 55.000 euro (dove di fatto vige una sorta di flat tax), la tassazione dei profitti (Irpeg, ora Ires) ha subito una costante riduzione dal 37% del 2002 al 24% di oggi. I fattori produttivi oggi al centro della creazione di ricchezza, in primo luogo le diverse proprietà (rendita), da quella intellettuale, a quella finanziaria, sino a quella immobiliare, sono sottoposte, se lo sono, ad un regime differenziato e assai limitato. Inoltre, il lavoro autonomo subisce forme di tassazione differenziate, secondo la logica fordista che il lavoro indipendente è assimilabile a quello imprenditoriale e quindi all’impresa, anche se eterodiretto e subordinato alla filiera di subfornitura.
La proposta del governo prevede la destinazione di circa 7 miliardi di euro alla riduzione dell’Irpef e 1 miliardo a quella dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive, a carico delle imprese, anche ditte individuale o semplici lavoratori autonomi con e senza partita Iva). Per quanto riguarda l’Irpef, per la fascia di reddito fino a 15mila l’aliquota resta al 23%, per quella tra 15-28mila scende dal 27% al 25%, quella 28-50mila cala dal 38% al 35%, mentre oltre i 50mila si passa direttamente a una tassazione del 43% che invece attualmente è riservata ai redditi sopra i 75mila euro. Se la critica sindacale (che ha portato allo sciopero di oggi 16 dicembre, proclamato solo da Cgil e Uil) ha fondamento, dal momento che la riduzione fiscale non ha alcun effetto sulle fasce di reddito inferiori ai 15.000 euro e sugli incapienti (redditi al di sotto degli 8.600 euro), l’alternativa proposta dagli stessi sindacati appare tuttavia parziale e non del tutto condivisibile. Essi vorrebbero che il beneficio fiscale andasse solo ai pensionati e ai lavoratori dipendenti (non a caso, le categorie che più rappresentano gli iscritti agli stessi sindacati), tramite opportuni interventi anche sul cuneo fiscale. Se ciò si dovesse verificare, la maggior parte dei precari e dei lavoratori autonomi, eterodiretti e a partita Iva, ne sarebbe comunque esclusi e sarebbe la stragrande maggioranza dei giovani a essere maggiormente penalizzata. Paradossalmente, lo stanziamento di un miliardo per la riduzione dell’Irap sarebbe più favorevole ai precari, se tale riduzione è finalizzata ai redditi più bassi, poiché molti di loro la pagano, in quanto non considerati lavoratori dipendenti. Ad esempio, i precari cognitivi che operano nei settori della ricerca e della consulenza (di solito con redditi molto bassi) vedrebbero una riduzione del loro carico fiscale.
Tuttavia, occorre considerare che il gettito dell’Irap è oggi utilizzato per finanziare circa il 90% del fondo sanitario destinati alle regioni per garantire il servizio sanitario nazionale. Il rischio è che una diminuzione di tale imposta possa portare indirettamente (senza grandi clamori mediatici) a una riduzione dei fondi per la sanità pubblica e quindi a vantaggio della sanità privata: un obiettivo che è al centro dei piani di investimento decisi dal PNRR, all’interno della tradizionale logica della New Public Management.
Alle corrette critiche sindacali, Draghi risponde che verranno stanziati circa 4 miliardi di euro nel 2022 e altrettanti l’anno successivo a favore delle famiglie meno abbienti per calmierare il caro-bollette. La proposta, tuttavia, sembra più uno specchietto per allodole, dal momento che, ammesso ma non concesso, che effettivamente tali soldi vadano alle famiglie più povere, essi serviranno per compensare l’aumento di nuove spese e non per ridurre quelle attuali, con l’effetto che nel migliore dei casi il potere d’acquisto rimane invariato.
Inflazione da profitti
L’aumento dei prezzi energetici è stato in questi mesi oggetto di mediatica attenzione. Sembra che sia ritornato lo spauracchio dell’inflazione, come negli anni Settanta e primi Ottanta del secolo scorso. Ma occorre subito chiarire che tale analogia è del tutto fuorviante. A prescindere dal fatto che si tratti di un fenomeno congiunturale o strutturale (su questo punto torneremo), l’aumento dei prezzi di oggi presenta aspetti di novità, che necessitano di essere analizzati. L’unico elemento comune con gli anni Settanta è infatti rappresentato dalla concatenazione che lega l’aumento dei prezzi dei beni finali all’aumento dei prezzi delle materie prime. Che il prezzo del petrolio e del gas metano aumentasse era dato per scontato dopo il forte ribasso a seguiti degli effetti recessivi dovuta alla sindemia da Covid-19. Di fronte alla forte ripresa della domanda globale (soprattutto in Cina e negli Usa), la crescita della conseguente domanda di materie prime ha trainato l’aumento dei prezzi, anche per effetto di due fattori concomitanti: lo sviluppo di tensione speculativa sui prodotti future energetici (in particolare petrolio), con l’esito di anticipare all’oggi attese future sull’aumento dei prezzi, e le difficoltà di approvvigionamento dei beni intermedi in seguito alle strozzature della catena internazionale di subfornitura, che ha penalizzato e rallentato l’offerta dei beni finali ma ne ha aumentato il costo di produzione.
L’aumento dei prezzi è infatti avvenuto in assenza di aumento dei salari e del costo del lavoro. Quindi qual è l’origine dell’aumento dei prezzi? Per rispondere, facciamo un banale esempio. Quando aumenta il prezzo del petrolio, immediatamente si registra un aumento del presso della benzina. Un mese fa, il prezzo del petrolio ha superato la soglia degli 85 dollari al barile (quotazione Brent) e immediatamente il prezzo della benzina si è adeguato, sino a raggiungere i valori di 1,750 euro al litro. Poi si è registrata una caduta del prezzo del greggio, sino a toccare poco più di 65$ al barile (- 23%). Ora si colloca sui 73$. Ma il prezzo della benzina al consumatore è rimasto invariato.
Medesima dinamica si è verificata anche per i prezzi di altre merci e servizi, il cui aumento non è causato da incrementi di costi di produzione ma esclusivamente dall’aumento del margine di guadagno (mark-up). Siamo cioè in presenza di un’inflazione da profitto.
Inoltre, a differenza dell’inflazione degli anni Settanta, oggi l’aumento dei prezzi è ancor più penalizzante per i redditi più bassi. Il cosiddetto indice dei beni che compongono il carrello della spesa (beni alimentari e a più alta frequenza di consumo) ha visto su base annua un aumento del + 3,2% (dati Istat), in linea, se non superiore, con il dato complessivo, a riprova che l’inflazione colpisce in misura maggiore il consumo più “povero” In secondo luogo, oggi non esiste più un meccanismo di protezione del potere d’acquisto dei redditi da lavoro come era all’epoca la scala mobile e, vista l’inesistenza di un salario minimo e la stagnazione delle remunerazione, è facile attendersi un ulteriore riduzione del potere d’acquisto del lavoro. Si tratta di una dinamica particolarmente preoccupante, dal momento che le statistiche Ocse (https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm) evidenziano che tra il 1990 e il 2020, l’Italia è l’unico paese dove si è registrato un calo del salario medio annuale pari al 2,9%, contro un aumento di quasi il 30% in Grecia, di poco meno del 40% in Francia e quasi del 50% in Germania.
Di fatto l’inflazione da profitti si trasforma in una tassa da inflazione per i redditi più bassi, proprio quelli che meno beneficiano della non-riforma fiscale che il governo Draghi vuole imporre.
Quali prospettive?
Il dispotismo politico, che oggi tende paradossalmente a sussumere quello economico, non ammette discussioni e dibattiti. Obiettivi e governance sono predefiniti. Non vi è spazio per un processo riformista. Ma oggi siamo in una condizione politica che vede i movimenti anti-sistemici arrancare faticosamente per sopravvivere ai colpi dell’emergenza sociale e della recessione economica. Le marginali turbolenze dei gruppi No Vax e No green pass più che una soluzione rischiano di rappresentare un peggioramento della situazione come armi di distrazione di massa che impediscono di cogliere e comprendere i veri nodi problematici che concorrono al montare del disagio sociale.
L’indizione dello sciopero generale da parte della Cgil e della Uil può rappresentare un aiuto, un turning point per ricominciare a discutere della questione sociale. Vi è il rischio, tuttavia, che sia tardi: la scarsa adesione allo sciopero generale della scuola del 10 dicembre scorso è un forte campanello di allarme sulle capacità di reazione di questo paese. Anche l’adesione alla mobilitazione odierna pare essere inferiore alle attese. D’altra parte, non può essere omesso che la credibilità del sindacato, che oggi parla di lotta alla precarietà, risulti provata da anni di politiche concertative che hanno favorito la generalizzazione della condizione precaria stessa: una situazione che penalizza la capacità di mobilitazione e di conflitto, di fronte a ricatti occupazionali, e quindi reddituali, sempre più elevati.
Crediamo necessario riconoscere che oggi il terreno del Welfare è il principale campo di un potenziale conflitto, a partire dalle tematiche della riproduzione sociale, come evidenziato dai due incontri organizzati da Effimera “Prendiamo corpo”. Sul piano economico, ciò significa rifondare il Welfare State sulla base di un nuovo universalismo non selettivo e non dipendente dalla condizione lavorativa e professionale.
Perché non chiedere, ad esempio, una riforma degli ammortizzatori sociali che converga verso un’unica misura di reddito minimo di base, incondizionato, che vada progressivamente a sostituire la pletora degli attuali strumenti di sicurezza sociale, spesso distorti e iniqui, magari con l’introduzione di un salario minimo orario?
Perché non chiedere, ad esempio, che, nel campo dell’imposizione fiscale, valga il principio che tutti i cespiti di reddito siano sottoposti ad un unico sistema di aliquote fortemente progressivo a prescindere dalla fonte di provenienza (inserendo anche i redditi derivanti da rendite proprietarie)?
Perché questi due punti non sono stati esplicitamente inseriti all’interno della piattaforma rivendicativa dello sciopero generale del 16 dicembre?
Immagine in apertura: Roma, sciopero generale Cgil-Uil del 16 dicembre 2021


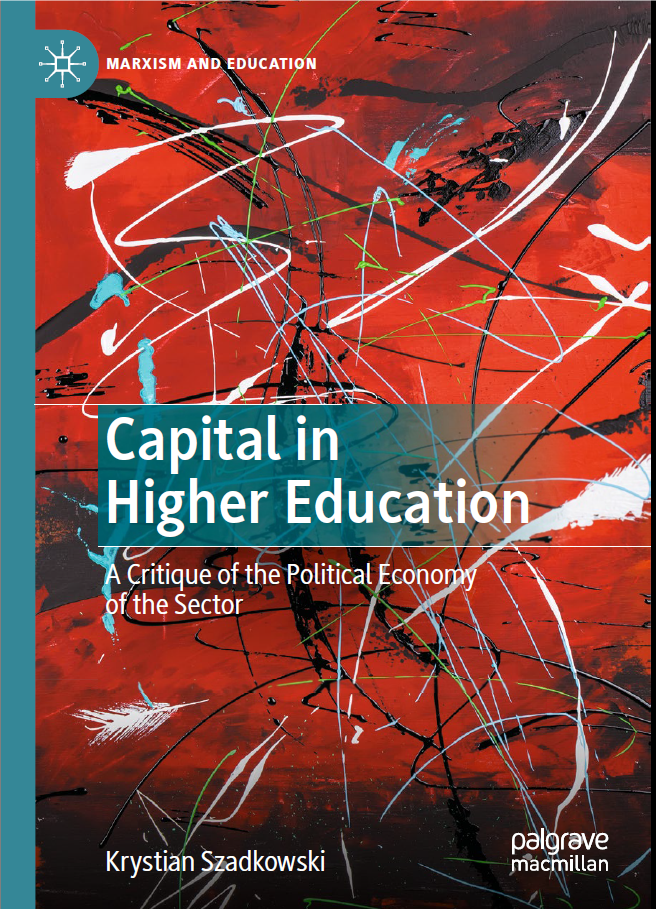





Dato che i no-vax e non green pass sono forze marginali, quasi “terroristi”che impediscono la ripresa che ci propone il governo dei migliori presieduto da non eletto Draghi(grazie a Mattarella). Prenderò come oro colato le proposte di intellettuali , sindacati, partiti politici che da 50 anni difendono i nostri diritti……
Uno sciopero che fossi ancora al lavoro non avrei fatto. Sciopero proclamato da sindacati che definire concertativi è assolverli dalle loro politiche sindacali. Se in trent’anni i salri hanno perso, solo in Italia il 3% non è stato per disposizione divina, ma è il risultato delle politiche sindacali e governative volte alla competitività internazionale, quella competitività italiana che un giorno si e l’altro pure ci decantano omettendo che si regge su salari da fame e su precariato. Uno sciopero proclamato per potersi sedere al desco padronale-governativo, come se sinora avessero fatto diversamente. La disaffezione agli scioperi dipendono da 40 anni di politica sindacale contro i lavoratori e a favore del padronato. A questo si può aggiungere che il sindacato è richiedente obbligo vaccinale e tace sul GreenPass: può un lavoratore sospeso perché non vaccinato scioperare? Puo aderire un altro lavoratore costretto al tampone a sue spese ogni due giorni aderire allo sciopero? In altri tempi questi sindacati sarebbero stati definiti pompieri: tali erano e tali rimangono.