Nemzetek halnak s ujra kilkelnek
Szent a bator, ki, mint magam,
Vallja mindig: ve rés arany
Endre Ady
(Muoiono le nazioni, altre ne nascono
ed è santo chi osa come me
dire e ridire: sangue e oro)
Traduzione di Paolo Santarcangeli
Il recentissimo voto del parlamento europeo impone attenta riflessione. È certamente vero che ben difficilmente sarà possibile ottenere il pieno assenso dei governi nazionali, e che tale assenso si rende necessario per l’apertura di un procedimento di infrazione contro l’Ungheria. Ma sarebbe un errore sottovalutare il significato politico del dibattito e della decisione, le conseguenze sulle alleanze e sugli schieramenti non sono prevedibili. Ogni piccolo conflitto, in questa situazione generale davvero incerta e confusa, rischia di degenerare e di condurre allo scontro aperto, di sfuggire al controllo. Viktor Orban ha partecipato alla discussione, è intervenuto con foga. Poi ha incassato il colpo e ora si accinge al contrasto istituzionale, con il ricorso alle Corti di Giustizia, contestando la validità formale del voto. Non par proprio, dunque, che si tratti di un incidente di percorso, senza reale importanza; al contrario potrebbe rivelarsi l’innesco di una esplosione incontrollabile a catena.
Il lungo dettagliato rapporto che ha determinato il voto porta la firma di Judith Sargentini, parlamentare olandese, eletta fra i GroenLinks, all’opposizione nel loro paese: lo si veda in europarl.europa.eu, oppure in 2017/2131 (INL). Le conclusioni dell’indagine affermano che in Ungheria è in corso, mediante una legislazione antidemocratica, la violazione dei diritti in danno dei cittadini e dei migranti, limitando in forme inaccettabili la libertà. La procedura non fu dunque iniziativa delle due forze oggi maggioritarie nel parlamento europeo (socialisti e popolari), rimasti silenti e assenti; forzando le tappe ha avuto invece successo l’intraprendenza di un’esponente della sinistra ecologista, che è riuscita quasi da sola a spaccare trasversalmente governi nazionali e partiti.
La destra italiana si è schierata al completo in favore di Viktor Orban, ricompattandosi sulle posizioni autoritarie di Salvini e Meloni; il gruppo pentastellato ha invece appoggiato la mozione e si pone ora, con questa divisione, il problema di quale sarà il voto del governo Conte nel prosieguo del procedimento di infrazione. La medesima frattura ha investito peraltro anche il governo austriaco di destra nero-blù: i popolari del primo ministro Kurz contro Orban mentre FPO del ministro Strache lo ha appoggiato. Anche in questo caso lo scenario si presenta tempestoso. Non deve stupire la scelta democratica di un rigido conservatore come Kurz; la politica aggressiva dell’attuale governo ungherese incide nella regione austriaca del Burgenland, caratterizzata da una robusta minoranza ungherese, e pone serie questioni che toccano la confinante Ucraina.
Il Partito Popolare è senza dubbio, ad oggi e nonostante il manifestarsi di importanti conflitti interni, il raggruppamento europeo che riscuote il maggior numero di consensi elettorali. Per evitare la resa dei conti ha lasciato libertà di coscienza ai propri parlamentari, che in gran parte hanno colto l’occasione per marcare la differenza di prospettive e di progetto rispetto alle intemperanze del piccolo caudillo magiaro. Ed ora la questione del procedimento di infrazione viene a caratterizzare, senza possibilità di risolverla prima, una difficile campagna elettorale per il rinnovo del parlamento europeo. Non ci saranno gli elettori del Regno Unito. Sono elezioni incerte, per nulla scontate quanto all’esito, tenuto conto delle particolarità nazionali e di un sistema integralmente proporzionale.
Orban rischia, a sua volta, di rimanere prigioniero del proprio personaggio e dei suoi variopinti sostenitori, oltre che della sua costituzionale aggressività. E’ in guerra con il suo partito popolare, sta a fianco dei cosiddetti sovranisti pronti a sbranarsi fra loro, privi come sono di un qualsiasi progetto comune.
Che diavolo significhi poi, in concreto, sovranismo nessuno riesce a spiegarlo, ma questa è un’altra storia.
Sia quel che sia questo arcano sovranismo, Orban potrebbe essere costretto dalle circostanze a percorrere la via impervia di una resistibile ascesa fino al disastro inevitabile che lo attenderà a conclusione della sua avventura.
Orban: un furbastro ambizioso e pericoloso
Nato nel 1963 in una famiglia non disagiata della minoranza religiosa calvinista (15% circa del totale) il piccolo Viktor trovò ben presto la maniera di emergere durante gli studi, conquistando subito la carica di segretario dell’organizzazione giovanile comunista (KISZ). Dopo l’invasione sovietica del 1956 e la successiva impiccagione dell’allora primo ministro Imre Nagy l’incarico presupponeva, necessariamente, adesione senza riserve al regime, contrasto militante di ogni dissenso, fiducia piena nella polizia segreta. Caduto il muro, nel 1989, Orban separò subito il proprio destino da quello dello sconfitto socialismo reale, ripudiando pubblicamente le convinzioni precedenti e il recente passato. Si legò, dimostrando notevole spirito di adattamento, a Gyorgy Schwartz, un imprenditore di origine ebraica meglio noto nel mondo come George Soros; il mutamento di cognome risaliva al lontano 1936, un mimetismo difensivo per via del crescente antisemitismo varato dal governo autoritario magiaro al potere fra le due guerre e oggi ben rivalutato dal partito sovranista di governo, che in quell’esperienza afferma di trovare le proprie radici.
Il comunista divenne democratico, liberale e progressista, ottenendo dal miliardario (patrimonio stimato: 25 miliardi di dollari) una borsa di studio presso una rinomata università del Regno Unito; terminati gli studi, nella nuova repubblica ungherese fu eletto deputato al parlamento, nelle file di centro sinistra, convinto protagonista della lotta per i diritti civili.
Oggi sappiamo che il pur abile Soros investì male il suo denaro; nei mesi scorsi infatti una legge gli ha imposto la chiusura dell’università privata, e siamo ormai allo scontro aperto fra i vecchi alleati. Il miliardario non è persona gradita alle autorità di governo.
Fiutando il vento Viktor sorprese ben presto tutti quanti, spaccò il partito (Fidesz) e svoltò decisamente verso destra, al tempo stesso entrando nelle file ospitali dei popolari europei; disse che era ritornato a difendere i valori cristiani. Per una legislatura, fra il 1998 e il 2002, divenne anche primo ministro; ma guidava una coalizione troppo fragile e perse le elezioni successive, battuto dai socialisti che meglio conoscevano la macchina dello stato e del consenso. Seppe mettere a frutto la lezione. Si liberò degli alleati e sviluppò in modo spregiudicato la linea aperta con la legge del 1999 a sostegno delle minoranze etniche ungheresi nei paesi confinanti.
Nel 2008, con un colpo maestro (che tuttavia nulla insegnò al nostro Matteo Renzi), vinse il triplice referendum sociale, conquistando una solida base in provincia e tagliando le gambe alla sinistra, schieratasi incautamente dalla parte della speculazione finanziaria e del liberismo radicale.
Nel 2010 trionfò alle elezioni parlamentari e da allora nessuno è più riuscito a rimuoverlo dal potere. Il suo esecutivo di destra ha rafforzato in questi anni il settore pubblico, giungendo fino a nazionalizzare i fondi pensionistici privati e ad imporre imposte sulle telecomunicazioni; l’originario liberismo divenne una sorta di autoritarismo nazionalista in salsa ex socialista, senza reazioni significative dell’Unione Europea che lo accettò, quieta e per nulla polemica, nel 2011 quale presidente semestrale di turno. Le riforme costituzionali erano rivolte a limitare il peso del dissenso, ma non ci furono proteste efficaci nelle strutture comunitarie. Nessuno ostacolò davvero Orban nella sua strada verso l’autoritarismo (o se piace: sovranismo).
La svolta decisiva avvenne dopo le elezioni del 2014, ancora una volta concluse con un successo pieno e vasto della destra nazionalista di Fidesz. Nel settembre 2015 l’Ungheria si trovò al centro di una straordinaria emergenza migratoria, in forme tali da scatenare e far risorgere mai sopiti odi e antichi conflitti. Non dobbiamo dimenticare che il regime dell’ammiraglio Horthy (1920-1944), rivalutato da Orban, fu il primo a varare leggi antisemite (1921 e 1938); neppure va taciuta la discriminazione che per secoli ha colpito gli zingari; e ancora bisogna considerare la guerra contro l’impero turco che a lungo aveva dominato il paese (dal 1541 al 1699).
La Serbia non è parte dell’Unione Europea. Il Regolamento di Dublino assegna la gestione dei richiedenti asilo al primo paese in cui il migrante transita, ma riguarda solo gli stati aderenti. I gitani discriminati in Serbia, Macedonia e Montenegro cominciarono ad attraversare la frontiera ungherese di Roszke, diretti a nord; soprattutto ci fu un esodo di siriani, afgani e iracheni in fuga dalle guerre. Passavano senza sosta, non avevano intenzione di fermarsi, ma erano pur sempre numerosissimi.
Orban scelse, durante la crisi della migrazione, il proprio destino, dichiarando guerra agli sfollati, senza alcuna riserva e senza alcuna pietà. Fece costruire un muro lungo i confini, ordinò rastrellamenti e concentramenti, nella città di Szeged istituì anche una specie di coprifuoco. Significativo il proclama programmatico della crociata contro lo straniero: chiudete le frontiere, fermateli, o arriveranno a milioni!
In quei giorni Orban divenne il campione di tutti i partiti xenofobi nel vecchio continente, l’esorcista delle paure ancestrali alimentate ad arte nelle periferie europee, dell’aggressione al diverso. E oggi rivendica con fierezza questo ruolo. L’interpretazione di un personaggio costruito per vincere le elezioni in una piccola provincia dell’impero ha ormai segnato e imprigionato per sempre questa maschera teatrale, costantemente sospesa fra il tragico e il comico.
La sua forza sta nel silenzio, rassegnato e sciocco, delle due forze attualmente più significative nel parlamento europeo; per questo Orban ha reagito con tanta violenza al voto sulla mozione Sargentini, una mozione che scompaginava il quadro e che per la prima volta lo contestava apertamente.
L’anomalia ungherese
Non sono molti gli abitanti dell’odierna Ungheria, neppure dieci milioni; meno di quelli che vivono al Cairo, la metà anzi, se si vuol tener conto dell’area metropolitana.
Secondo le statistiche la mortalità è superiore alla natalità, il numero dei magiari appare in costante diminuzione; il meticciato incide in misura modesta e i pochi immigrati provengono prevalentemente da zone limitrofe. In questo terreno apparentemente inadatto ha attecchito l’ideologia fondata sulla affermazione di una sovranità dentro i confini e sulla riconquista di una pretesa identità etnica, religiosa, nazionale; l’isolamento e il rifiuto del diverso si sono trasformati in un valore.
A partire dal 2010, per iniziativa di Orban, il 4 giugno è stato dichiarato giorno di lutto, per ricordare la fine della Grande Ungheria, dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale. I (ridotti) confini attuali risalgono al 1920, con il trattato di Trianon. Le rivendicazioni territoriali evocate da Orban toccano Ucraina, Slovacchia e soprattutto Romania. Alleanze e scontri si alternano, dentro una vera e propria polveriera che la Commissione Europea – impegnata soltanto a rimuovere gli ostacoli al profitto – si ostina a non vedere.
Il gruppo di Visegrad fu concepito nel 1991 allo scopo di agevolare l’ingresso dei paesi ex socialisti nell’Unione Europea e nella Nato; ma ben presto prese una direzione completamente diversa. Già nel marzo 1990 (Martie negru) le comunità rumene e ungheresi della Transilvania si affrontarono a Targu Mures, e ci furono almeno otto morti oltre a centinaia di feriti. La Romania si chiamò fuori dalla struttura, prima ancora di entrarvi. La frattura non si è mai ricomposta, naturalmente senza alcun intervento ricompositivo della Commissione Europea, in altre faccende affacendata.
Ma sarebbe un errore pensare che i quattro associati di Visegrad abbiano una strategia comune, se si esclude quella di non farsi carico dei migranti. La Slovacchia (cinque milioni) è l’unica ad aver adottato l’euro, in Cechia (dieci milioni) si sprecano le barzellette sul perché di questa decisione.
Il governo slovacco di Peter Pellegrini è a guida socialista; a Praga si è insediato Milos Zeman, russofilo, sostenuto dai comunisti nostalgici; in Polonia (38 milioni) la destra ultranazionalista cattolica coltiva invece un rapporto privilegiato con gli angloamericani in aperto conflitto con Putin.
L’Ungheria si colloca in una posizione geograficamente pericolosissima, confinando con ben sette stati indipendenti, di cui due (Ucraina e Serbia) non aderenti all’UE. Costruire muri in un simile contesto non è facile, soprattutto in caso di guerra non sarebbe tutela comunque sufficiente ad evitare disastri.
La grande crisi del flusso migratorio nel settembre 2015 si è caratterizzata per due eventi in contraddizione fra loro. Da un lato si è radicata la scelta sovranista e xenofoba del governo ungherese, con l’attacco violento alle colonne di profughi in fuga a causa dei conflitti; conflitti provocati dall’intervento militare (Siria, Iraq, Afganistan), con l’appoggio sia dello stesso governo Orban sia di quello italiano (allora di centrosinistra). Ma, d’altro lato, al tempo stesso, avvenne una specie di miracolo, in piena controtendenza rispetto alla deriva nazionalista. Centinaia e centinaia di autovetture private partirono da Austria e Germania, creando una meravigliosa catena di solidarietà e soccorrendo i fratelli in viaggio, senza chiedere documenti o porre condizioni per l’aiuto spontaneamente organizzato e prestato.
In quei giorni, a Vienna, città quanto mai meticcia e multietnica, anche in pieno centro si toccava con mano l’ampiezza della partecipazione, la portata di questa rivolta popolare contro il cinismo silente della Commissione Europea. E lo stesso sappiamo che avvenne in Germania, così profondamente scuotendo le comunità da imporre allo stesso partito popolare il sostegno all’iniziativa di massa che aveva costruito la catena automobilistica di aiuto ai migranti. Non dobbiamo dimenticare questa esperienza sul campo; contiene le basi per una ripresa del cammino verso l’emancipazione del precariato europeo che le Commissioni vorrebbero sussunto nel processo di rapina dell’esistenza pervicacente perseguito in questi anni.
Nel 1673 l’italiano Raimondo Montecuccoli, condottiero posto a capo dell’esercito asburgico nella guerra aspra che si sarebbe conclusa con la fine del dominio turco, annotava nel suo Libro inedito (cfr. Opere, volume terzo, pagine 243-274): nessun tempo è stato mai quieto nell’Ungheria… le loro leggi sono dissonanti ed esorbitanti… le leggi senza le armi non hanno vigore, le armi senza le leggi non hanno equità.
E qui sta il nodo pericoloso della vicenda; non è sufficiente l’inconsistenza storica e politica del personaggio Orban, non bastano neppure la marginalità economica dell’economia magiara o la modestia dell’apparato militare. Questo piccolo tiranno ha ormai assunto un ruolo simbolico e si appresta a giocarlo nel corso delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento dell’Unione; dentro il Partito Popolare e contro il Partito Popolare, a fianco delle liste xenofobe (ormai presenti in tutti i paesi dell’Unione) e tuttavia autonomo da esse, con il traguardo ambizioso (neppure celato) di riuscire a determinare nuovi equilibri autoritari.
Una resistibile ascesa
L’inatteso giunge sovente atteso, ed aspettiamo l’inaspettato. Così va la vita. (Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Ui). Inevitabile ricordare questa celebre opera teatrale, di fronte allo scenario che si prepara in occasione della scadenza elettorale nella prossima primavera. Brecht terminò la stesura, annota a mano, il 29 aprile 1941 con queste tremende parole:
vicinissimo il suono di un fucile mitragliatore
(si abbatte)
Ui e i suoi vermi! C’è nessuno che li fermi?
Già. Ora che la mozione di Judith Sargentini è passata, c’è nessuno che fermi Viktor Orban?
L’infortunio della Brexit ha lasciato strascichi irrisolti, in parte irrisolvibili. Nei cinque (residui) paesi più popolati le due forze principali si trovano in seria difficoltà, ma non sembrano rendersene conto.
In Spagna non solo la frantumazione delle liste è crescente, ma nella regione più ricca e più produttiva (quella Catalana) la maggioranza è rappresentata da dirigenti eletti che si trovano in galera o in esilio. Il tema non fa tuttavia parte dell’agenda politica europea. In Italia oltre il 60% dell’elettorato (di cui il governo attuale è una sia pur singolare espressione) si pone in aperto contrasto con l’attuale dirigenza dell’Unione, che invece nicchia; in Polonia il nazionalismo reazionario del partito al comando domina la scena senza neppure una reale opposizione; e perfino nella solida Germania rischia di vacillare la grande coalizione, varata a fatica e numericamente ridimensionata. In Francia il sostegno a Macron crolla con rapidità, lasciando intravedere la possibilità di una sconfitta clamorosa alla verifica di primavera; del resto che cosa si aspettava dopo aver usato i consensi, ottenuti da chi paventava Marine Le Pen, per completare lo smantellamento dello stato sociale, bastonare gli studenti, depredare il ceto medio in crisi, arricchire le banche?
Negli ultimi anni la scelta economica e politica della Commissione Europea, scelta accettata e messa in opera dai singoli governi nei paesi-guida, è stata quella di allargare la forbice fra ricchi e poveri, di favorire fiscalmente le imprese finanziarie, di sgretolare il welfare, di abbassare il livello salariale all’ingresso, di aggredire le tutele dei lavoratori all’uscita, di rendere ordinaria la precarietà introducendo perfino forme di prestazione gratuita quale condizione di accesso futuro al reddito. Ogni dissenso nazionale – la lezione inflitta alla Grecia rimane nella memoria dell’antagonismo – veniva con veemenza aggredito dalla Commissione e dalla BCE, con attuazione di sanzioni economiche durissime, capaci di piegare non solo la resistenza ma anche la resilienza. In Italia, a partire dal 2012, fu inviata la lettera segreta a carattere minatorio e si scatenò l’ondata speculativa, con il fine di cancellare la filiera dei diritti e di introdurre il Jobs Act, poggiando su Forza Italia e PD come quinta colonna.
Concordi nell’imporre misure di attacco al salario (nominale e reale) i due partiti del governo europeo trovarono intesa pure nel tralasciare qualsiasi serio contrasto della deriva xenofoba, prima sottovalutandola per stolta pigrizia, poi fingendo che non esistesse come forza di massa. La sequenza di errori compiuti dai dirigenti nazionali legati ai popolari e ai socialdemocratici attende ancora oggi uno storiografo che le colleghi e le cataloghi, per rendere finalmente l’idea di quanto miope fosse la strategia e quanto sconsiderata l’articolazione tattica. Non stupisce che l’unico leader individuato da entrambi come decisivo per la sfida in arrivo sia un soggetto politico in caduta libera come il francese Macron!
Con i movimenti scomposti di un pugile suonato – o ripetendosi come un disco rotto – l’intero apparato decisionale dei due partiti tradizionali nega che esista la possibilità di una sconfitta alle urne di primavera, rifiuta sdegnosamente la revisione dei programmi e della strategia politica. Insistono i demopopolari nel candidarsi quale unica alternativa alla deriva sovranista, in sostanza si propongono come un male minore e per questa ragione escludono qualsiasi mutamento di rotta, esigono arroganti una cieca sottomissione alle regole del potere finanziario.
La giunta di Milano, l’ultima metropolitana rimasta in mano al PD, costituisce un esempio tipico di questa volontà suicida diffusa fra i partiti di sinistra nei cinque paesi. Non hanno aumentato il prezzo del trasporto in città. Hanno annunciato di volerlo fare, non subito, fra sei mesi, in prossimità del voto, così che i pendolari abbiano un lungo tempo di rabbia da covare e possano sfogarsi nel segreto dell’urna. Negli stessi giorni non hanno sgomberato il centro sociale Macao, frequentato da migliaia di giovani precari; hanno annunciato di volerlo mettere in vendita libero (cioè sgomberato!) incaricando la francese Paribas di provvedere all’operazione. Nella loro testa vuota pensavano di battere la concorrenza di Salvini e hanno così perso gli ultimi consensi popolari senza sottrarne uno solo ai populisti. Geniale!
Mario Draghi, dopo le elezioni italiane del 2013, aveva riassunto il suo parere con una suggestiva immagine: a prescindere dal risultato le riforme proseguiranno perché ogni governo nazionale viaggia con il pilota automatico. Cinque anni dopo la confusione pare notevolmente aumentata e il pilota automatico non sembra capace di individuare gli ostacoli a causa della scarsa visibilità. Il bastimento della BCE e della Commissione Europea, laddove si ostini a non affrontare la realtà di una navigazione dentro la burrasca, rischia davvero il naufragio.
Una composizione rivoluzionata del parlamento europeo potrebbe agevolare soluzioni impreviste, seppur non imprevedibili. Il sistema proporzionale puro e le divisioni profonde all’interno degli schieramenti sono in grado di creare condizioni di caos e l’implosione politica della struttura complessiva dell’Unione. Le mutate maggioranze nazionali possono provocare una diversa articolazione della Commissione Europea; gli equilibri stessi della BCE, in attesa delle nuove nomine, sono a rischio.
In questo quadro l’ambizioso piccolo tiranno ungherese spera di consolidare il proprio ruolo, cancellando Judith Sargentini; la sua resistibile ascesa è promossa da sostenitori litigiosi, senza programmi, e soprattutto trova forza nel vuoto di chi occupa oggi la cabina di comando.
Tutti dimenticano che la guerra permane e prosegue ai confini dell’Unione: in Ucraina come in Medio Oriente. Molti sono i disperati che non hanno quasi nulla da perdere. Basta un innesco insignificante, come un minuscolo Viktor Orban, perché qualcuno decida di dar fuoco alle polveri.
Immagine di copertina da express.co.uk



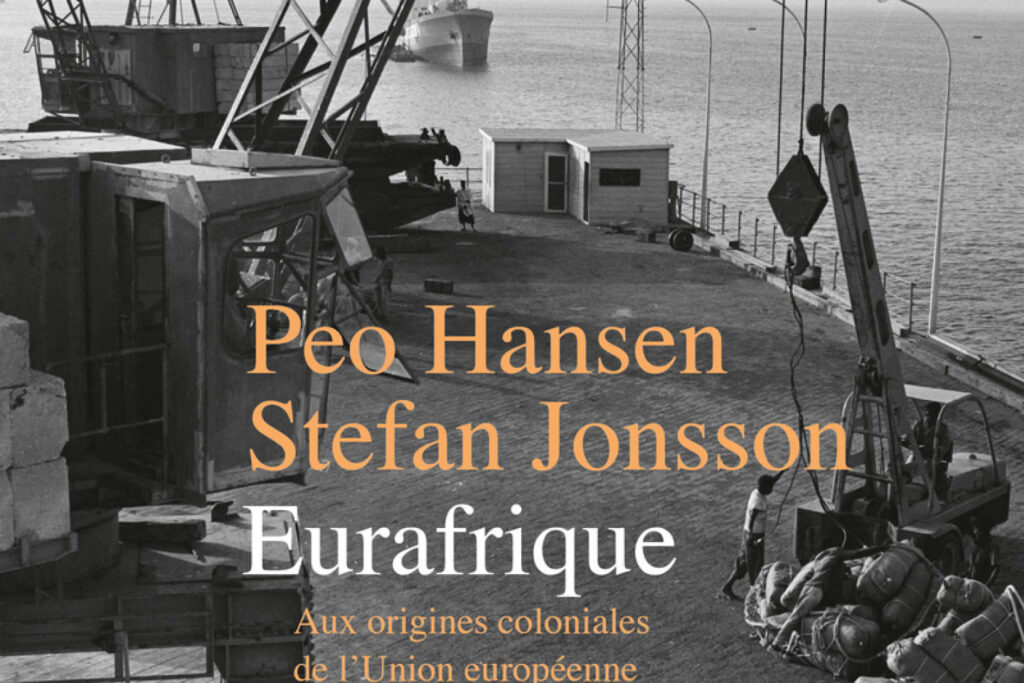




Scrivi un commento