Mi a la to’ età saltàa i fossi per el longo
Bepi, 2020
Il provocatorio articolo di Bifo apparso su Effimera qualche giorno fa ha senza dubbio sortito l’effetto desiderato dall’autore, sempre che l’effetto desiderato fosse effettivamente quello di rinverdire l’atavico scontro generazionale. La scelta di farlo a quarantena finita mostra comunque un sano senso di conservazione.
Esiste tutto un composito filone di ironia e sarcasmo che racconta questo scontro: i (baby) boomers – figli del dopoguerra e della ripresa economica che nella seconda metà del ‘900 divengono i protagonisti di contradditorie trasformazioni epocali – odiano i millennials – i nativi digitali, o come preferisco definirci io, la generazione con Plutone in Scorpione – perché sono troppo “soffici”, “emotivi”. “Bamboccioni”, è stato detto, ma anche picky – o era choosy? Insomma, per capirci il senso è quello.
Suvvià millennials! Fatevi crescere due begli zebedei. Ribellatevi o rassegnatevi!
Dal canto suo, la generazione Z, prima ancora che venga il suo turno alla gogna, alla gerontocrazia diffusa risponde con sarcasmo, risparmiandosi al momento lo stillicidio riservato ai fratelli maggiori.
La millennial che scrive è stata buona in quarantena per quasi tre mesi. Lavoro infatti a Padova, nella cui provincia si trova Vo’ Euganeo, una delle prime zone ad essere costrette alle misure contenitive. Essendo io una millennial mi sono ritirata nella provincia profonda, vivendo la reclusione con la mia boomer (s)preferita. Ho tentato di tutelarla il più possibile, evitando, anche quando avevo necessità lavorative – talking about DAD, provincia e digital divide – e affettive, di sconfinare. E, per inciso, in casa mia l’odio per i confini è un tratto transgenerazionale. Nella reclusione ero finora riuscita nella nobile impresa di non scrivere nulla sul Covid. Ma l’oggi arriva che si sia pronti o no, e oggi Bifo mi costringe, purtroppo, a scrivere di faccende Covidose.
Il succinto, quasi impudico, provocatorio testo da per spacciate le nuove generazioni, destinate a “lasciarsi succedere tutto”, come ha dimostrato il fatto che abbiano accettato di buon grado le misure restrittive e contenitive, misure a cui l’a–corporalità dell’epoca digitale le ha più che egregiamente preparate. Se il Covid19 fosse successo negli anni ’70, mai e poi mai i giovani avrebbero permesso di essere reclusi. Se ne sarebbero andati di casa, avrebbero fondato comuni, reinventato relazioni (anagraficamente segregate ma vabbé dai: Harold se la troverà dopo il Covid la sua Maude se ne avanzano), e via cantando – cantando per inciso pezzi francamente noiosi, manco un po’ di rap, indie o trap, ma questa è un’altra storia.
Noi no, questi millennials sensibilotti hanno seguito le regole, dandosi all’azione sociale diretta e al mutualismo. Hanno offerto il loro aiuto ai geronti che li denunciavano per una corsetta cento metri più in là, e con il loro corpo tatticamente presente e assente hanno fatto da scudo ai loro cari (e meno cari) più vulnerabili. Non solo “i vecchi”, come dice Bifo, ma anche tutti gli immunodepressi, anche a costo di deprimerci un pochino noi.
Perché l’abbiamo fatto? Non riusciamo a staccarci dalla gonna della mamma?
Innanzitutto, la ringrazio della domanda, e se mi è concesso la prendo un po’ come è formulata, un tanto al kilo insomma.
Dunque: un tanto al kilo il Covid negli anni ’70 non c’era. Insieme al Covid non vi era un flusso di persone, dati, e microorganismi quale quello di oggi. Siamo in una condizione di globalizzazione avvenuta, dove un virus che nasce in estremo oriente può mietere il maggior numero di vittime in estremo occidente. Come abbiamo incontrato questo destino di globalizzazione, secondo quali (non) regole questo processo di unificazione è avvenuto, non è certo appannaggio dei millennials.
Qual è la relazione tra le trasformazioni economico/materiali e politiche degli anni ’70, ’80 e ’90 e questo virus? Ma soprattutto, quali politiche internazionali e/o internazionaliste sono state messe in campo affinché potessimo rispondere come una comunità di interesse unica ad una pandemia che, come da meme, sembra ricordarci la scandalosa nudità del re piuttosto che evocare terribili vicende bibliche, fatte di lebbrosi che vagano per le strade e vengono allontanati dalle città. Dal canto nostro, certo non abbiamo curato appestati, ma abbiamo cercato di non escludere nessuno, anche a costo di “autoescluderci”.
Ma cosa rivela l’impudica nudità del sovrano? Nulla, se non che facciamo parte di una comunità politica, quella statale, che ci spoglia del nostro diritto a godere di tutto. In cambio di cosa? Di sicurezza. Una prospettiva realista certo, ma concreta. E non è solo sicurezza personale, ma la promessa che ai più vulnerabili tra noi verrà garantita cura. Personalmente non cederei il mio diritto a tutto per nulla di meno. Eppure, il re è nudo. Qualcuno ha provato a dirci di non cedere la nostra libertà di movimento alla paura e alla psicosi.
Lo hanno fatto Sala e Zingaretti. “Milano non si ferma”? E invece Milano si sarebbe dovuta fermare subito. L’ha fatto Boris Johnson, mentre molti inglesi si mettevano in auto-quarantena. L’ha fatto Confindustria, costringendo al lavoro migliaia di persone, spaventate per sé e per i propri cari, senza misure di protezione. L’ha chiesto Renzi, con insistenza, perché “ce lo chiedono i morti di vivere”. Ognuna di queste voci ha rivelato il corpo ripugnante del sovrano sotto le fittizie vesti pastorali.
Noi invece abbiamo guardato i carri militari portare via le salme da Bergamo e siamo rimasti in casa. È stato detto che le riprese sono circolate apposta, come una “sottile” forma di governo della paura. Ma noi, che nella società dello spettacolo ci siamo nate, sappiamo già che con le immagini si fa politica, e siamo state capaci di sentire il silenzio dei saluti mancati sopra al rumore della macchina mediatica. Abbiamo pianto lacrime per morti che non hanno lasciato ai vivi il diritto al lutto, comprendendo in piccola parte cosa significhi per le famiglie dei migranti lasciati affogare nel Mediterraneo non avere uno spazio, un corpo, un addio. Siamo sensibilotti. Siamo fatti così (siamo proprio fatti così).
Siamo rimasti in casa, uscendo bardati solo per fare la spesa per chi non poteva uscire, recapitandola davanti a casa, senza poter sfiorare una mano nel consegnarla. Forse perché siamo dipendenti? È questo che succede quando non si sa conquistare l’autonomia?
La generazione a cui appartengo si è vista negare una stabilizzazione nel lavoro, pressata nell’anticamera del precariato. È mancato un welfare capace di permetterci di costruire delle vite economicamente autosufficienti, in un mercato del lavoro che continua ad assorbirci ed espellerci, a cicli di cococo, cocopro, voucher, tirocini, contratti a chiamata e collaborazioni occasionali che però magari mi vieni continuamente dato che ci sei, tac, e così via. E anche tenuto in considerazione ciò, la mancata autosufficienza economica non è l’unica ragione per cui in tante e tanti hanno accettato le misure restrittive, talvolta tornando a casa dei genitori e privandosi della sudata indipendenza. Perché in questi soffici millennials, che sono cresciuti a pan di stelle e femminismi, vi è la consapevolezza che l’autonomia non consiste nel vivere al di fuori delle responsabilità e delle relazioni di cura, anche quelle intergenerazionali.
Siamo figli della vulnerabilità ma questo non fa di noi dei deboli. Non è un segno di debolezza chiedere aiuto. Il manifestarsi di forme diffuse di disagio psicologico, su cui si sofferma Bifo, non indica la loro assenza in precedenza, ma l’abbattimento di un tabù e un movimento di riflessività proattiva. Il malessere psicologico, per cui abbiamo smesso di avere vergogna, lo raccogliamo come un fatto collettivo, e la sua cura come un diritto sociale. Chi chiede aiuto apre la strada affinché un domani il diritto al benessere psicologico sia riconosciuto, libero, accessibile e garantito a tutt*.
Ecco, questa generazione verso la quale le precedenti sono un po’ in debito, fosse anche in debito solo di spazio, è stata ore, e ore, e ore davanti a zoom, a fare assemblee, a spiegare a chi aveva bisogno di welfare come accedervi, a confortare chi aveva solo bisogno di parlare, chi si sentiva soffocare, chi temeva di ammalarsi, chi aveva paura per il lavoro, chi aveva perso i genitori, chi non aveva il pc per seguire la didattica a distanza (…). Lavoro sindacale, di cura, emozionale? Di tutto un po’.
Noi ci siamo piegati alla DAD – raccogliendo il disprezzo di un altro “storico”, Giorgio Agamben – pur di non uscire dalle vite delle nostre studentesse, pur di non lasciarle sole in case di cui non conosciamo le storie. Stanche, perché tutto il giorno è diventato lavorativo, e con gli occhi che bruciano, perché siamo tutti videoterminalisti ora.
Ci sono state dette molte cose su questo virus. Non sono un’epidemiologa, né una virologa, eppure ho capito che questo virus riguarda l’ambiente, l’inquinamento, l’allevamento intensivo, lo sfruttamento capitalista. Questo virus riguarda l’impossibilità di accedere ad una cura adeguata nei sistemi sanitari privati, come negli Stati Uniti, dove la malattia segue una linea del colore, di classe e di genere, che si intersecano mietendo il maggior numero di vittime nella comunità afro-americana femminile. Questo virus ci racconta della svolta neoliberale e dei tagli che negli ultimi 30 anni hanno portato allo smantellamento di uno dei migliori sistemi sanitari del mondo. (Sì, il nostro). Noi millennials non c’eravamo, non manifestavamo, non votavamo, non avevamo l’età della consapevolezza e in alcuni casi non eravamo nemmeno ancora nell’orizzonte di possibilità dell’immaginario dei nostri geronti – pardon – genitori. Noi abbiamo ereditato il Covid molto più di quanto non abbiamo ereditato la psicopatologia dell’alienazione di cui parla Bifo. Per il Covid, e non solo, i millennials dovrebbero ricevere delle scuse.
Siamo state resistenti in casa perché sappiamo che il mondo è irrimediabilmente uno. Abbiamo reso le nostre comunità più resilienti assicurandoci il più possibile che nessuno rimanesse indietro, nemmeno i lenti, nemmeno i “vecchi”. Questa non è la nostra sconfitta. Questo è il nostro marchio. Non stiamo chiedendo allo stato di essere qualcosa che (al momento) non è, stiamo materializzando un’alternativa. Transgenerazionale e transpersonale. Intersezionale e consapevole. Stiamo lottando contro il nemico più grande di sempre, che non è il Covid, ma il golem nato dalle sconfitte che ci hanno portato fin qua. Lo vogliamo fare dentro e oltre lo stato, dentro e oltre la classe, dentro e oltre la razza e il genere. Non ci stupisce che non vengano viste le nostre armi, se fossero state riconoscibili avremmo forse ereditato più vittorie. Ma non saper vedere qualcosa non ne decreta l’inesistenza.
Mentre chiudo questo pezzo sento sulla spalla la mano invisibile e delicata di una sorella che non ho ancora conosciuto, una della generazione z, di quelle che il venerdì, fuor di Covid, non vanno a scuola ma a lottare per quel futuro che i ruggenti anni ’70 (e non solo per carità) hanno ipotecato. E del resto, voi volevate tutto, noi solo un futuro per tutt*. La vedo ridacchiare, con quella meravigliosa arroganza di chi non ha tempo per farsi crucciare dal passato, troppo impegnato ad aggredire l’oggi, a conquistarsi un domani. Mi convince ad occuparmi di lei, invece che degli anni ’70. Le faccio cenno di sì, anche se non so come chiudere. Lei sì, lo sa bene, e del resto non mi sarei aspettata meno da una Plutone in Sagittario: non a caso, in rosa…
Ps: si certifica che per quanto sistematicamente ignorat*, nessun appartenente alla generazione X è stat* fisicamente maltratto durante la scrittura di questo pezzo. In quanto millennial, tuttavia, sono consapevole del fatto che la forclusione sia una forma di violenza epistemica, quindi: xdono!






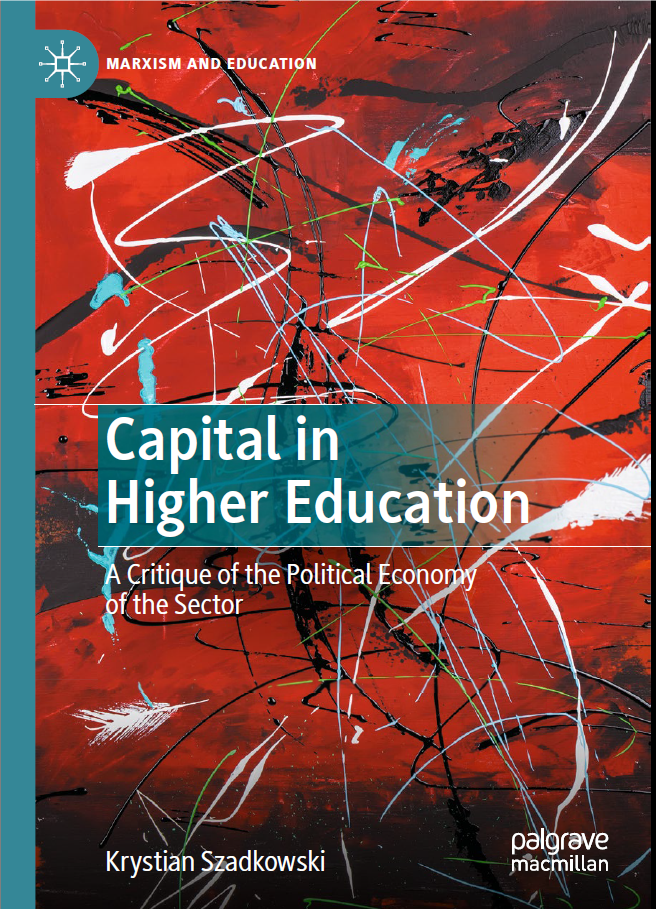





Ci sono alcune gravi inesattezze di fondo nella tua risposta. Innanzitutto, negli anni 70 non c’era il coronavirus, ma ci fu una catastrofica epidemia di colera.
https://www.vanillamagazine.it/agosto-1973-panico-per-l-epidemia-di-colera-a-napoli/
E la popolazione obbedi’ abbastanza ciecamente alle autorita’. Anche prima, del resto, la popolazione obbedi’ Quindi non si capisce bene questo manipolo di eroi che gridano “me ne frego!” e non obbediscono alle autorita’. Quindi hai ragione, ma per il motivo sbagliato: i boomers hanno obbedito a tutte le restrizioni durante la crisi di Chernobyl, e via cosi’. Onestamente in Italia non ci sono state grandi ribellioni di massa alle autorita’ dopo il 1970, e a dire il vero nemmeno prima. Quindi, se la teoria del boomer (e bada bene, perche’ io negli anni 70 c’ero, e il boom e’ arrivato in Italia negli anni 80: parlo contro di me) che si ribella e’ vera, diciamo che la generazione di Bifo e’ molto brava a ribellarsi… in segreto.
Ma il problema vero e’ un altro: la narrativa politica italiana parla di un luogo ideale inesistente, che forse esiste nel cielo dei pensieri di platone. Quindi se il governo ti segrega a casa e’ un atto politico.
Rimane un fenomeno abbastanza significativo che alcuni chiamano “realta’”: e’ in corso un’epidemia che ha ucciso 33.000 persone in Italia. Questo “piccolo dettaglio” ha avuto la pretesa (hybris!hybris!) di entrare nel perfetto cielo dei pensieri e delle idee , manifestando il fatto che magari si, il lockdown aveva piu’ a che fare con un virus che con Julius Evola.
Semmai si dovrebbe disquisire sul COME si e’ fatto il lockdown, ma sul fatto che esiste anche un fenomeno fisico, a volte non blando, detto “Realta’”, che ci siano posti incredibili dove essa ha una sua rilevanza, tipo l’ Universo, oggi esistono pochi dubbi. Semmai vedo rancore in chi e’ ancora infastidito dal fatto che un frammento di realta’ abbia interferito con le idee.
Poi, se qualcuno ci vede qualcosa di liberticida, forse dovrebbe indagare sul come, e non sul cosa.
https://keinpfusch.net/loweel/la-phase-thue
Aggiungo a questa ottima risposta quello che Scòzzari, che ai tempi c’era, testimonia nel suo “prima pagare poi ricordare”
“Nottata dopo nottata, numero dopo numero di Re Nudo, mi veniva confermato un sospetto tremendo: il movimento era sostanzialmente triste, uggioso. Cupi, incazzati. Non esistevano spiritosi. Tutti si prendevano bestialmente sul serio. Per alcuni si trattava di andare allo scontro con la forma stato matura e con le multinazionali, mica cazzi. Altri si rimettevano in discussione circa ogni trenta secondi (cioè, invitavano a farlo), andavano alla verifica, volevano superare la fase, ripensavano la vita e il tempo-lavoro (la massa di tempo di vita estranea al lavoro, come la chiamava Bifo in una sua lettera-contributo). Additavano, denunciavano, testimoniavano, pensavano, scrivevano, organizzavano feste del proletariato giovanile, ma nessuno rideva. Giusto le donne qualche volta ci provavano, quando alle feste s’imbizzarrivano e rompevano in quei loro girotondi con zoccoli che mandavano in bestia «il Borghese», «il Resto del Carlino» e «il Corriere». Ma erano gli obbligatori sorrisi-di-donne-liberate, guardate-come-siamo-vincenti-e-felici-infatti-sorridiamo-e-ci-abbracciamo-tra-donne-visto? Sorrisi al ciclostile, ininfluenti.”
Le generazioni deprecano il proprio passato e vantano il proprio futuro….dato che il presente è in mano ad altro.
Qualcuno l’ha definita”la generazione scomparsa”, quella che ha preferito l’eroina al “piacere di incontrarsi, di studiare insieme, di corteggiarsi, di far l’amore e così via”. La generazione che non avrebbe mai accettato la Detenzione Sanitaria Obbligatoria (DSO) ma che ha scelto la Detenzione Tossicomanica Volontaria (DTV).
Grazie Mackda, mi sono riconosciuta in ogni tua parola. Nel senso di profonda responsabilità che ho provato stando in casa e uscendo solo per fare la spesa per me e per i miei genitori e per la vicina di casa anziana, lasciando la spesa sulla soglia del loro appartamento mentre loro mi venivano incontro per accogliermi e io sorridendo gli intimavo di stare alla larga. Mi sono sentita responsabile per ogni anziano, per ogni immunodepresso, per ogni persona fragile che, rispettando le regole assieme agli altri, ho tutelato. Mi sono sentità parte di una grande comunità, perché pur isolati nelle proprie case – nello stesso tempo più della metà della popolazione mondiale era in lockdown – stavamo affrontando, per una volta, le stesse avversità. Non ho mai pianto per il mio disagio o la mia situazione personale – anche se non è stato leggero stare sempre in casa – ma anche io, come te, per i morti di Bergamo, per quella lunga fila di camion militari che portavano nella mia regione le salme di una città che non riusciva più a contenere i suoi morti. Ho lavorato in smartworking ben più di quanto lavorassi in presenza, utilizzando quei mezzi digitali che alcuni trovano freddi e segreganti per trasmettere vicinanza e supporto oltre che contenuti. Ho fatto pure le cene su Meet con gli amici e parenti… sempre meglio che niente! 🙂 Mi aveva stupito, fin dall’inizio della quarantena, vedere post che parlavano della situazione in corso collegandola a concetti quali dittatura, carcerazione, privazione della libertà, strategia autoritaria, quando in fondo si trattava (e si tratta) di misure di sicurezza sanitaria e collettiva. Mi colpiva il fatto che questi post in genere fossero scritti da persone di una certa età, solitamente da intellettuali. Non ho compreso il senso di queste “proteste” e di questa insofferenza, se non riconducendola a una nostalgia per la propria gioventù ribelle. Eppure, in quella situazione, mi sono parse come posizioni tremendamente, ciecamente individualiste mentre la maggior parte delle persone era intenta a fare una cosa: preoccuparsi della collettività, facendo del proprio meglio nelle condizioni richieste. Sembra strano ma in quell’isolamento, e oggi nel distanziamento fisico, ho sentito più forte che mai la vicinanza con gli altri e un senso di comunità.
Grazie Mackda, grazie da una che si lascia succedere di tutto.
Chiedo per un* amic*, ma dici che tra 3 generazioni troveremo una zanzara mezza fossilizzata nell’ambra con al suo interno il sangue di un Bifo e potremo allora distillate finalmente il DNA della pura militanza, dando origine ad una stirpe di militanti degni di un Militant Park?
Mi guardo bene dal rispondere a Mackda, che ringrazio per l’attenzione con cui mi legge. Sono anzi disposto ad ammettere che ha ragione lei. Anzi no, che ho torto io.
Ho torto perché ho autorizzato (e avrei dovuto evitarlo) una lettura “generazionale” del mio articolo sul sistema psico-immunitario della generazione proto-digitale. (ma che razza di titolo è?)
Fondare un ragionamento qualsivoglia su un’identificazione “generazionale” è idiota, lo so. Eppure lo faccio talvolta, nella furia scrittoria.
E’ idiota perché giustifica delle reazioni del tutto speculari, come quella di Mackda; ne risulta una discussione un po’ da bar Messico, con qualche aspetto patetico come quando Mackda definisce noiosa la musica degli anni ’70.
Sono convinto (da sempre) che le generazioni non esistono come insiemi culturalmente omogenei.
Per capirci: della mia generazione, quella nata nel decennio post-bellico, fanno parte anche: Giuliano Ferrara, Tony Blair, George Bush, e se proprio vogliamo infierire, anche Rodrigo Duterte e Jaroslav Kaczynski.
Tutti amici miei, compagni di bisboccia.
Negli anni settanta aborrivo l’identificazione generazionale, schifavo quelli che definivano il movimento degli studenti bolognesi come un movimento “giovanile”. Le culture, i movimenti, gli stili non si definiscono in base all’atto di nascita, ma alla collocazione sociale, alle scelte ideologiche, estetiche, politiche, eccetera.
Dagli anni novanta in poi ho cominciato ad apprezzare la nozione di generazione in un contesto molto preciso: quello della mutazione tecno-comunicativa. L’accesso al digitale crea le condizioni per individuare un vero e proprio salto cognitivo, e quindi anche psichico che differenzia gli individui nati più o meno in contemporanea con la nascita di Internet. Da allora mi sono permesso di usare talvolta una definizione generazionale, per individuare l’emergere di competenze cognitive e patologie psichiche strettamente legate (a mio modesto parere) alla riformattazione connettiva dell’attività cognitiva degli individui.
Quando mi è venuto voglia di scrivere quell’articolo che è stato pubblicato da Effimera e da Operaviva ce l’avevo soprattutto con alcuni miei coetanei che se la prendevano con la irresponsabilità di questi giovinastri che vanno sui Navigli milanesi a bere birra in folta compagnia.
Allora ho pensato di entrare nella discussione in maniera un po’ estemporanea, senza tanti distinguo teorici.
Non pensavo di essere preso tanto sul serio, dal momento che scrivevo:
“quasi in tutto il mondo, i ragazzi e le ragazze hanno rinunciato alla scuola e hanno accettato le regole della detenzione sanitaria obbligatoria (DSO).
Cioè hanno rinunciato alle due cose più importanti per una persona in età giovanile, hanno rinunciato al piacere di incontrarsi, di studiare insieme, di corteggiarsi, di far l’amore e così via.
Perché l’hanno fatto? L’hanno fatto per non ammazzare il nonno asmatico o il padre cardiopatico. Bravi bravissimi, in quanto nonno asmatico non so come ringraziarvi. “
Mi rendo conto del fatto che la facoltà preziosa che talora chiamiamo “ironia” scarseggia di questi tempi, per ragioni che tendo ad attribuire all’appiattimento emotivo prodotto dalla riformattazione connettiva.
Ma signori, il nonno asmatico dovrebbe placare ogni rigore esegetico. Invece no.
Mi dicono che in Facebook qualcuno mi dà del cretino. Be’ sono cose che capitano quando si frequentano ambienti poco raccomandabili, come quello di Facebook. Se accetti l’umiliazione di entrare nel social medium di un robot fascistoide (ladro di idee altrui) che si chiama Mark Zuckenberg, non ti puoi lamentare se incontri dei cialtroni che hanno passato gli anni di formazione ad ascoltare Maria de Filippi.
Ecco, di questo mi rammarico: di avere accettato l’umiliazione di usare il social medium che più di ogni altro (più di Twitter e più di Apple, tanto per dire) oggi copre e fiancheggia il razzismo trumpista.
Perché l’ho fatto? Perché continuo ad entrare nel mio profilo Facebook pur sapendo che tutto quello che faccio lì dentro non vale niente per la semplice ragione che alimenta la macchina della demenza?
Di questo ne parliamo un’altra volta. Magari non in Facebook.
franco berardi
Solo una precisazione storica e fattuale. La Tefaù dice: “a lottare per quel futuro che i ruggenti anni ’70 (e non solo per carità) hanno ipotecato”, dimostrando una profonda ignoranza della nostra storia. Le ricordo che quel poco di buono, pubblico e solidale esistente oggi, è frutto proprio di quegli aanni 70 che lei demonizza, Tralasciando “bazzecole” come lo Statuto dei Lavoratori ed altre, sappia che il Servizio Sanitario Nazionale pubblico universale viene istituito in tre passaggi: nel 1968, 1974 e 1978, proprio grazie a quella stagione velocissima ed eccentrica, prima della quale e dopo (quindi anche oggi) esiste solo il caos delle mutue, delle assicurazioni sanitarie, la giungla che divide il popolo tra garantiti e no. Forse dovrebbe ridocumentarsi.
mi scuserete gli errori nello scrivere? lo sgrammaticare dovuto all'”emotività”? prevedo che se mi faccio prendere dalla cosa scriverei almeno una 50ina di metri di parole ma, soprattutto in questo periodo mi rompo le palle di leggere cose lunghe, quindi mettendovi nei mie panni cerco di tagliare corto. premetto che mi sento sintetico, che letto l’articolo e il commento di franco berardi non mi viene altro da fare che coniugarvi, miscelare i contrasti emersi e cercare di unire l’apparente polemica, ma avendo vari scorpioni anche io nel tema natale credo che non mancheranno sottointesi velenosi, e critiche fastidiose, ma non solo per un fatto astrologico bensì anche per un fatto culturale, se ho vissuto repressione espressiva e poi mi si da la libertà di esprimermi alla pari è logico che schizzerò nello sbilancio (e ben vengano allora i dissidi, è stato uno spasso ad esempio leggere le critiche a Franco Berardi fatte da Umberto Eco in Sette anni di desiderio). bando alle premesse, la mia messa riguarda un paio di punti.
1. Giorgio agamben e chi come lui ha esposto ed espone una visione totalitaria delle misure di sicurezza recenti e dell’amministrazione statale eccezionale che viene somministrata ai sudditi già da un po’, sono letteralmente atomi di ossigeno che tengono in vita gli esseri viventi, ma sarebbe meglio dire spirituali di questo pianeta o Realtà.
(e stiamo parlando di persone che sono arrivate a far intersecare la critica sociale con l’etnografia della memoria personale.. stiamo parlando di Pokémon leggendari, che nonostante la merda in cui sono costretti a sguazzare hanno la nobiltà d’animo di fumarsi una canna e di essere psicoattivamente rivoluzionari)
sulla questione delle generazioni cervo di evitare di cadere in queste categorie del cazzo (come gli altri binomi occidente/oriente, corpo/mente, non solo la Haraway ma anche G. Bateson docet) e poi il cervello non ha questa plasticità transgenerazionalmente estesa? se siete d’accordo allora in qualche modo nella scrittura collettiva del grande romanzo della rete fatto di articoli e comm. non sussiste.. siamo un cervello sociale senza età, non mi serve un granché o un crocchè stare lì a riferirmi ai miei anni (o almeno non mi serve per difendere una mia presunta appartenenza), posso riconoscere la vecchiaia (in questo caso in accezione negativa visto il tono in cui se ne sta parlando) e non lo spirito giovanile (alla Benjamin) dalla sclerosi che affligge la struttura di un sintagma non certo dai dati anagrafici.
1. (cit. Nino Frassica – il bi e il ba) ha ragione anche la Ghebremariam a dire che pur non condividendo le analisi ciniche sente che sono svalutati certi contropoteri contemporanei, ma a me stizza leggere tutti gli anglicismi imposti dalle nuove forme di lavoro, soprattutto scriverli come fossero normali, non è normale che costringiamo la nostra lingua al flusso stilistico imposto dalla pubblicità personalizzata dalla bolla di filtraggio che racchiude i nostri dispositivi, come non era normale quello che veniva propinato negli anni 60/70′ del 900, non solo in Italia ma soprattutto nei paesi “più sviluppati”, sarebbe invece normale riprendere Baudrillard certo ma anche Wilhem Reich, quando analizza la compulsività emersa dopo la rivoluzione bolscevica nelle comuni giovanili (in la Rivoluzione sessuale), e applicarlo alla nostra quotidianeità. Siamo compulsivi, noi digitatori del presente effimero, scorriamo più o meno intensamente la novità, critichiamo la fascistizzazione della cognizione-emozione delle piattaforme sociali eppure su Instagram (che devo ricordarmi che è di Mark Zuckerberg, perché me lo dimentico continuamente.. ) ci arrivano le immagini delle proteste in USA come quelle in Cile che vanno avanti dall’anno scorso, come quelle di Hong Kong, come sui canali indipendenti furono trasmesse in streaming le proteste e il tentativo di assedio al parlamento in Grecia nel 2008, come su youtube (scaricatevi YouTube crakkato per piacere, non bruciatevi i neuroni ascoltando spot del cazzo ogni tre canzoni: https://www.xda-developers.com/youtube-vanced-apk/ ) si trova la rivoluzione televisiva dell’89 in Romania (Harun Farocki – videograms of a revolution), come scaricandosi il torrent di Santiago di Nanni Moretti, si può vedere una ricostruzione dei fatti del Cile nel 73’… ma una volta fatto l’aggiornamento teorico, una volta compulsato, quando ci vediamo per le strade, per i luoghi Sociali potremmo anche fare un passo in avanti.. c’è bisogno di autoorganizzare convivenze, di autogestirsi… non solo cercando alternative come Telegram (che tra l’altro se non fosse stato per il canale dei Wu Ming avrei continuato ad avere attacchi di panico leggendo gli art. su not ero) o Signal o Mastodon etc. o partecipando ai concerti e ai cortei ma parlo proprio di mettere in condivisione la nostra fiducia, andiamo a vivere insieme! telefonatevi, telefonatemi, aggiorniamoci sulle terre, le case a prezzo ribassato, trasferiamoci nelle occupazioni.. i soldi, fin quando sarà mantenuto il sistema di sfruttamento ci saranno, basta cercare qualche lavoro stagionale come bracciante agricolo e le “tasse” vitali si pagano, poi nella rosea previsione che l’esercito si ammutina e si sovvertono i palazzi e le ville e i terreni del potere, si passerà all’esproprio sottoproletario, il Presidente della mia Regione, De Luca, credo sarà ben contento, con la sua laurea in filosofia, di collettivizzare i suoi beni per sfamare le masse alla ricerca di suolo da seminare o forse la filosofia insegna qualcos’altro?
scusate possibili effetti malefici, amen
questo è il mio numero 3389034883
[…] Mackda Ghebremariam Tesfau, “In risposta a Bifo”, Effimera, 5 giugno […]
La coronavirus (COVID-19) è una malattia infettiva causata da un coronavirus recentemente scoperto.
La maggior parte delle persone infette dal virus COVID-19 sperimenterà una malattia respiratoria da lieve a moderata e guarirà senza richiedere trattamenti speciali. Gli anziani e quelli con problemi medici di base come malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche e cancro hanno maggiori probabilità di sviluppare malattie gravi.
Il modo migliore per prevenire e rallentare la trasmissione è essere ben informato sul virus COVID-19, sulla malattia che provoca e su come si diffonde. Proteggi te stesso e gli altri dall’infezione lavandoti le mani o usando uno sfregamento a base di alcol frequente
Il virus COVID-19 si diffonde principalmente attraverso goccioline di saliva o secrezione dal naso quando una persona infetta tossisce o starnutisce, quindi è importante praticare anche l’etichetta respiratoria (ad esempio, tossendo in un gomito flesso).
Al momento, non esistono vaccini o trattamenti specifici per COVID-19. Tuttavia, ci sono molti studi clinici in corso che valutano potenziali trattamenti. L’OMS continuerà a fornire informazioni aggiornate non appena saranno disponibili i risultati clinici.
Tieniti informato:
Questo è quello che c’è scritto nel sito ufficiale dell’ OMS. Potete controllare voi stessi andando su WHO.int- pagina iniziale- menù in alto a destra (griglia di colore azzurro vicino alla lente di ingrandimento) -health topics- cliccate sulla lettera C- Covid19 e vi appare questo ( se usate google col traduttore).
Davvero tutto quello che è successo e che soprattutto succederà è minimamente proporzionato alla descrizione di questa malattia (che è LIEVE O MODERATA, e solo per una piccolissima percentuale della popolazione PUÒ essere grave) a detta di quella stessa “organizzazione” che ha iniziato questa surreale, mostruosa, gigantesca tragedia?
D’altronde si vedeva già da subito (e si continua a vedere) dal sito dell’ ISS (Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia) . E lo scrive una persona che ha perso nel giro di in anno e mezzo (2016-2017) entrambi i genitori ultraottantenni e con patologie, e come ” colpo di grazia” hanno avuto la polmonite..in un ospedale pieno di anziani e malati con polmonite. NON voglio banalizzare, intendo dire che è una tragedia che c’è da SEMPRE e , sino ad ora, considerata come cosa “normale”..andate a vedervi le mortalità da influenza 2017 secondo l’OMS.. potrei continuare e scrivere un libro. Bisognerebbe cominciare a ragionare, informarsi, non dai giornali o televisione, ma andare alle fonti, guardare i DATI reali, non avere paura, non farsi rendere schiavi. Ma, purtroppo, questo non è accaduto.
Tutti e tutte supergonzi e supergonze!! Come giustamente scrive Giovanna la questione FONDAMENTALE è che la pandemia non esiste! Nel 2015 sono morte in sovrappiù 45000 persone nei primi 8 mesi. Nel 2017 l’OMS stimava che l’influenza ammazza ogni anno dalle 250000 alle 650000 persone. E gli ammalati di COVID hanno in media 62 anni, mentre i morti 80., che poi è la speranza di vita in Italia.
Quindi poco importa dice chi ha ragione, la cosa che conta è rendersi conto che CI (VI, in quanto a 50 anni e cardiopatico nn ho mai messo mascherina se nn dove obbligatorio e da bravo misantropo di sentimento sto distante da quasi tutt* ma bacio e abbraccio in pubblico chi sento vicino al Cuore) STANNO PRENDENDO PER IL SEDERE. Non ribellatevi che vi fanno un TSO, ma prendete in giro chi ubbidisce prono.
Ciao
Buongiorno! un altro complottista, vedo..anche tu credi che la terra sia piatta e giri con la stagnola in testa? Oppure sei un fascista, no-vax antisemita? Dimenticavo: un troll Russo? Quello che mi ha sconvolto maggiormente è il fatto che milioni di persone intelligenti, istruite, persino colte non abbiano visto le bieche e crudeli manipolazioni linguistiche, di immagini, psicologiche..ancora non mi capacito..comunque c’è una piccola speranza..un piccolo gruppo di medici ha inviato una lettera aperta al governo, facendo quelle stesse domande (più o meno) che mi ero fatta io. Ovviamente sui giornali italiani non ve ne è traccia..l’ho trovato in un giornale on-line Tedesco: Rubikon.
https://www.docdroid.net/tyjp8lv/istanza-finale-2-pdf
P.S. letture consigliate (tra le tante) Sorvegliare e Punire, M. Foucault