Questa mattina ci ha lasciati Benedetto Vecchi, compagno e amico da molti anni, responsabile della pagina culturale de Il Manifesto, attivo sul sito di EuroNomade e nella discussione politica e teorica interna al pensiero critico marxista e neo-operaista. È stato autore di numerosi scritti e libri (uno per tutti, Il Capitalismo delle piattaforme, ManifestoLibri, Roma 2017), che ruotano intorno ai temi delle nuove tecnologie, della rete e dei suoi diritti, sempre con una visione critica, raffinata e una capacità anticipatoria non comune.
La sua penna, le sue recensioni su Il Manifesto, il suo pensare aperto e insieme rigoroso ci mancheranno molto.
Lo vogliamo ricordare ripubblicando questa sua intervista, concessa a Massimo Franchi, uscita sul sito Diritti Globali (che ringraziamo) lo scorso 11 maggio 2019 e tratta dal 16° rapporto sui Diritti Globali. Con ciò , Effimera esprime la propria affettuosa vicinanza alla moglie e alla figlia di Benedetto, oltre che al collettivo del quotidiano Il Manifesto e al collettivo EuroNomade
* * * * *
I big data, il complesso militare digitale e la democrazia. La fabbrica del consenso
Intervista a Benedetto Vecchi, dal 16° Rapporto sui diritti globali
di Massimo Franchi – 11/5/2019
Dal caso Cambridge Analytica agli ultimi dibattiti sulla “post verità” e il web come “bene comune”, Benedetto Vecchi – uno dei massimi esperti in Italia di questi temi – sostiene che la rete può essere uno strumento a disposizione di tutti solo se ognuno di noi si impegnerà a conoscerne strutture e funzionamento, difendendo così anche la propria privacy.
Rapporto Diritti Globali: Il caso Cambridge Analytica ha messo a fuoco le possibili dirompenti conseguenze della vendita dei big data da parte dei social network. Abbiamo visto già tutto o dobbiamo attenderci nuovi scandali?
Benedetto Vecchi: Cambridge Analytica è solo la punta dell’iceberg. Il caso ha occupato lo spazio mediatico perché era coinvolta Facebook, cioè la società di Mark Zuckerberg, ed era evidente l’influenza, meglio la manipolazione dell’opinione pubblica da parte dei social network e di quella rete di imprese globali che sono raccolte sotto l’espressione big data, cioè di chi raccoglie dati personali, li elabora, li impacca e vende a società che li possono usare per aggressive campagne pubblicitarie personalizzate o a chi vuol influenzare un referendum – quello inglese sulla Brexit – o elezioni generali o presidenziali, come è accaduto in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti. Non c’è giorno che in Rete non venga pubblicata notizia di uno scandalo o della condanna di un’impresa o il rifiuto di un tribunale di dare corso a una denuncia da parte di un singolo o di un gruppo di utenti che intravedono nell’operato di questa o quell’impresa una violazione dei propri diritti individuali. Negli USA, ma se ne cominciano a intravedere echi anche in Europa, ci sono class action contro Uber o Airbnb perché hanno sfruttato economicamente i loro dati. Oppure ci sono molte amministrazioni cittadine che intraprendono progetti per costruire piattaforme digitali dove è rigorosamente rispettata la privacy individuale e i dati non possono essere sfruttati economicamente. In altri termini, è rispettato il diritto all’oblio, cioè quella clausola voluta nelle leggi nazionali e internazionali da molti giuristi – in Italia il paladino è stato Stefano Rodotà – in base alla quale dopo un certo numero di anni (generalmente due) i dati vanno automaticamente cancellati; oppure il fatto che in ogni momento il singolo possa chiedere la loro cancellazione senza avere nessuna penalizzazione nell’uso della piattaforma digitale.
I big data sono dunque sempre più qualificati come un’“arma di distrazione di massa”, che mette in discussione la democrazia e la capacità dei singoli di autodeterminare la propria vita. Come si può intuire siamo dentro una critica che trae forza dal paradigma liberale della modernità. La democrazia è sempre espressione di individui autodeterminati, cioè che recidono i propri legami sociali e relazionali per poi stringere un patto dove cedono allo Stato, o all’impresa, parte della propria autonomia e libertà. Chi rivolge ai social network una critica liberale non ha fatto tesoro di quella dialettica dell’illuminismo che mette in discussione l’assunto che una persona informata sia capace di prendere decisioni razionali e dunque non prigioniere da passioni o interessi egoistici. I big data e la Rete costringono semmai a guardare alla formazione dell’opinione pubblica e alla costruzione di una soggettività collettiva come un assetto produttivo, cioè una fabbrica tesa a produrre consenso alla società data e dunque ai rapporti sociali e di potere dominanti.
Questa premessa è indispensabile per comprendere appieno come è potuto accadere Cambridge Analytica o, per molti versi, aiuta a comprendere l’impatto delle rilevazioni di Julian Assange o Edward Snowden. Se lo scandalo della Cambridge Analytica coinvolge in fondo alcune imprese private e spregiudicati leader politici, le rivelazioni di Snowden sulla gestione da parte del Pentagono e della National Security Agency della Rete per monitorare e spiare le conversazioni on line dei cittadini mette a fuoco l’esistenza di un complesso militare digitale che può nuocere alla democrazia alla stessa maniera dei big data.
Dunque, la Rete come fabbrica del consenso, per usare una fortunata espressione di Noam Chomsky. E questa fabbrica ha un’organizzazione produttiva, delle gerarchie, un modo di produzione ormai abbastanza indagato. Dunque: c’è un modello di business dominante che vede uno scambio tra servizi gratuiti – posta elettronica, mappe del territorio, possibilità di usare software più o meno sofisticato – e cessione dei dati personali. Quando si sottoscrive un account con Gmail, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Uber, Airbnb si accetta sempre una policy che dice che i tuoi dati possono essere usati dall’impresa che li raccoglie, impegnandosi a garantire l’anonimato, anche se non è sempre così. La cosa certa è che i tuoi dati diventano di sua proprietà. Ormai questo modello viene qualificato come capitalismo delle piattaforme, perché ogni impresa funziona come una piattaforma che estrae la propria materia prima – informazioni – per poi elaborarle, modificarle. Qui subentra un altro aspetto della fabbrica del consenso, cioè i rapporti di lavoro e i diritti dei lavoratori. Se vediamo da vicino come funziona Amazon, Facebook, Apple troviamo uno strato più o meno numeroso di knowledge worker molto qualificati, che accedono alle stock option (cioè la possibilità di poter acquistare in maniera privilegiata azioni della società), che usufruiscono dei piani assicurativi e pensionistici. Il loro salario è alto rispetto magari a compagni di lavoro che svolgono le stesse mansioni ma che sono temp, cioè lavoratori a tempo determinato. Sono cioè precari, che non hanno stock option, né piani assicurativi e pensionistici. Esemplari sono i racconti di molti “schiavi della Rete” statunitensi, che hanno un salario basso, che svolgono lavori certo qualificati ma tutto sommato ripetitivi e che possono essere cacciati dal giorno alla mattina. Accanto a questo dualismo, nei knowledge workers c’è l’esercito in divenire di chi svolge lavori di pulizia, di logistica. Un esercito precario, intermittente, con bassi salari. Molti studiosi parlano di taylorismo digitale, per segnalare la dequalificazione, il lavoro ripetitivo, una gerarchia soffocante che controlla ogni loro movimento e gesto attraverso una raccolta di dati favorita da badge e dispositivi digitali usati per documentare spostamenti di oggi. Il caso più noto e clamoroso è quello di Amazon, che ha attirato l’attenzione per il clima da caserma e da prigione in molti suoi stabilimenti americani, tedeschi, francesi, spagnoli e nell’Est europeo. Qualche timida denuncia è stata fatta anche per l’Italia.
Dunque, un modello di business rodato che però comincia a manifestare qualche scricchiolio, qualche messa in discussione. Da una parte, ci sono dunque gli utenti dei social network o chi acquista merci on line, affitta taxi per spostarsi in città o appartamenti per spostamenti di lavoro o per week end di svago e divertimento; dall’altra, le imprese, che hanno bisogno tuttavia di verificare continuamente l’indice di gradimento dei servizi offerti. I feed back degli utenti sono dunque indispensabili. Sono cioè materia prima per produrre innovazione di processo e di prodotto, per usare un lessico economico. Si tratta in realtà di lavoro “donato gratuitamente” alle imprese. Qui si cominciano a incontrare resistenza, poca collaborazione e una richiesta da parte dei singoli di vederci chiaro su come sono usati i loro dati e di come può essere tutelata la loro privacy.
Oltre a questa riottosità crescente dei singoli, ci sono le campagne di denuncia sulla manipolazione appunto dell’opinione pubblica. Cambridge Analytica è solo la punta più visibile del problema, perché la raccolta di dati è una attività in continua espansione. Senza fare analisi sul futuro, già adesso sono all’opera progetti di investimento per applicare l’intelligenza artificiale al fine di rendere più fluido il flusso e l’appropriazione privata dei dati personali. È un modo neanche tanto velato di aggirare le resistenze degli utenti e dei conflitti di lavoro che cominciano a manifestarsi nel settore della logistica. Sarebbe dunque auspicabile che gli attivisti dei diritti civili nella Rete stabilissero rapporti di coordinamento e di “alleanza” con i sindacati che operano in questo settore al fine di un mutuo soccorso. Una strada in salita, certo, ma che andrebbe comunque percorsa.
RDG: La tutela della privacy on line è sempre più richiesta dagli utenti. Ma senza una normativa globale i giganti del web possono aggirare i controlli degli Stati. Come risolvere il problema?
BV: I giganti del web non vedrebbero male una normativa globale alla luce dei rapporti di forza attuali. Sotto molti aspetti già esiste ed è qualificata come norme sulla proprietà intellettuale, che sono tutte a favore delle imprese. Se cedi i tuoi dati all’impresa quelli automaticamente possono essere e sono considerati proprietà intellettuale. Cioè tu rinunci alla proprietà di un tuo dato. Una volta fatto questo, la privacy diventa un optional, una possibilità che è a discrezione delle imprese. Questo non significa che va abbandonato il campo. Ci sono proposte di alfabetizzazione informatica e di autorganizzazione digitale per difendere la privacy. Ci sono corsi di autodifesa digitale organizzati, in alcuni casi, come in Inghilterra o Spagna, dal sindacato. Ci sono poi le campagne per stabilire norme sovranazionali sulla riservatezza. In Europa e all’ONU ci sono personalità politiche, funzionari, una rete di organizzazioni non governative, un pulviscolo agguerrito e preparato tecnicamente e teoricamente di mediattivisti che si battono per un’adeguata normativa sovranazionale, perché la Rete non ha confini e ciò che viene raccolto in Italia può dunque essere elaborato oltre frontiera.
C’è un “però” che va tenuto conto. Finora abbiamo sempre rappresentato la Rete come uno spazio pubblico sovranazionale. C’è tuttavia qualcosa che sta cambiando e che va analizzato con attenzione. Il riferimento è all’esercizio della sovranità digitale da parte di alcuni Stati. La Cina, gli Stati Uniti, la Russia, ma anche l’Iran e altri Paesi non democratici dicono apertamente che vogliono esercitare un potere di controllo e di gestione della Rete. Ovviamente lo fanno per preservare l’integrità dei dati personali messi in pericolo dalle imprese private. Più realisticamente, tanta passione per il sovranismo digitale è dovuta al fatto che vogliono controllare e censurare la comunicazione on line sia per esigenza di sicurezza nazionale che per repressione del dissenso. Ma c’è anche un altro aspetto che va messo in conto. Così come c’è una fabbrica del consenso, comincia a delinearsi una fabbrica della privacy.
Ci sono ormai imprese che forniscono programmi informatici per avere il proprio diritto all’oblio, affinché la propria navigazione in rete non sia tracciata. Insomma, per diventare invisibile. Allo stesso tempo, gli Stati nazionali raccolgono già una massa ingente di dati personali. In questo vogliono agire come uno Stato imprenditore, cioè che si mette a produrre i propri big data, facendoli diventare un settore economico. È questa una tendenza neoliberista dello Stato imprenditore, che svolge un doppio movimento: è una tecnologia del controllo sociale, dunque ha una funzione di “governo della vita” per usare il linguaggio dei politici della vita sia conservatori che progressisti; ma lo Stato si pone sul mercato. Il complesso militare digitale è il contesto dove maturano, sono sviluppati progetti imprenditoriali che vedono una partnership tra privato e pubblico all’interno di una logica tipicamente capitalistica. Qui non c’è privacy che tenga quando è lo Stato ha doverla gestire direttamente. Dunque, occorre non cadere in facili entusiasmi quando si parla di sovranismo digitale. Mi sembra che questo alluda soprattutto a un mutamento di quel modello di affari alla base dei big data dove è lo Stato a gestirlo direttamente, all’interno però di un patto sociale e politico che lo legittima. È l’intero sistema democratico che viene messo in discussione. Questo per dire che la battaglia per la difesa della privacy non ha nulla di antico o di inattuale, ma che investe proprio il funzionamento della fabbrica del consenso. E dunque riguarda anche i rapporti sociali di produzione. Esistono segnali in questo senso, come la liceità o meno delle aziende di spiare i propri dipendenti mentre lavorano con un computer, monitorando così la loro produttività e controllando i loro comportamenti. Insomma, la privacy è sì roba da grande o piccolo fratello, ma anche di governo del lavoro vivo.
RGD: La riforma europea dei copyright informatici è molto discussa. C’è il rischio che favorisca le big company?
BV: Direi di distinguere tra copyright dei contenuti video, musicali, delle idee e il copyright relativo ai media. Nel primo caso, c’è una complessa procedura che vede i trattati internazionali della WTO (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), le norme sovranazionali guida definite dalla World Intellectual Propriety Organization (WIPO) dell’ONU, le norme europee e le leggi nazionali. Nel corso del tempo c’è stata un’armonizzazione tra tutto ciò che ha rafforzato il potere delle imprese sulla produzione dei contenuti, ma anche lasciato degli spiragli per azioni di riappropriazione dal basso o nazionali della proprietà intellettuale.
La WIPO ha, per esempio, caldeggiato la costituzione di un sistema misto tra logica proprietaria e, scusate il tecnicismo, e logica open source, cioè di contenuti che possono essere usati da tutti senza però che la loro rielaborazione possa essere sottoposta invece a copyright, a brevetti o alla logica del brand. Anche la potente WTO è stata messa sovente in difficoltà attraverso l’articolo 27 dei TRIPS, che stabilisce la possibilità di non rispettare i trattati internazionali in base a forti necessità nazionali. Un grimaldello, questo, usato dal Sud Africa per produrre farmaci per la cura dell’AIDS senza pagare le royalties all’industria farmaceutica multinazionale. Oppure che, in maniera meno eclatante, hanno usato alcuni Paesi per i farmaci salva vita. Questo è un terreno dove il conflitto tra la nozione di bene comune e logica proprietaria privata è più aspro. E non sempre le Big company ne escono bene, almeno a livello di immagine. Su questo aspetto una revisione radicale dei TRIPS andrebbe perseguita non solo dai governi nazionali ma anche dai movimenti sociali. Sarebbe certo espressione di un “riformismo dal basso” che non fa la rivoluzione, ma uomini e donne vivrebbero meglio per quanto riguarda l’accesso ai farmaci o la possibilità di accedere ai contenuti intellettuali, musicali, cinematografici a prezzi più sostenibili dai quelli attuali.
C’è poi l’aspetto del copyright per i media. Qui si apre un capitolo dove i problemi sono numerosi e i protagonisti della scena pubblica sono molteplici e contraddittori nei loro comportamenti. La violazione sistematica del copyright non viene certo dal ragazzo o dalla ragazza che si costruisce la propria playlist di brani musicali o della famigliola che si scarica le serie televisive dal web senza pagare nulla. I violatori massicci del copyright sono imprese come Google, attraverso YouTube o altri media, che piratano contenuti prodotti dai loro concorrenti. In questo caso, si delinea un conflitto tra modelli di affari diversi. Da una parte, le piattaforme digitali; dall’altra, i colossi in difficoltà dei media e dell’entertainment. Finora le modifiche delle norme sul copyright hanno teso a riequilibrare il potere tra old media e capitalismo delle piattaforme. C’è però il terzo incomodo, che è il pubblico della Rete, che pervicacemente continua a pensare che l’accesso ai contenuti debba essere gratuito e che si inventa di tutto e di più per aggirare ostacoli software e hardware che impediscono l’accesso gratuito a musica, film, tv e libri.
RDG: Il mondo del giornalismo è invece diviso su un’altra norma di questa riforma: la cosiddetta link tax. Remunerare il lavoro giornalistico senza aumentare quello dei giganti del web è possibile?
BV: Mi sembra che dietro questa domanda ci sia un equivoco. Chi lavora in un giornale o in una televisione sa benissimo che cede il proprio diritto d’autore a quel giornale o tv, anche se è un freelance, anzi questi ultimi sono meno tutelati dei giornalisti strutturati. Certo, poi ci sono i livelli di negoziazione individuali dovuti alla fama o all’accreditamento professionale. A seconda del contesto vige il principio dell’individualizzazione del rapporto di lavoro, come nel caso degli Stati Uniti, Australia e Inghilterra; oppure all’esistenza di un contratto nazionale di lavoro che risponde però al principio del mestiere o della professione. Quando subentra la negoziazione, un giornalista o una giornalista possono chiedere, in base al proprio potere contrattuale, un ritorno del copyright entrato nelle casse della propria testata. Ma sono casi limite, un’eccezione rispetto alla regola che il diritto d’autore è quello ceduto all’impresa che ne diviene proprietaria. Quella in discussione nell’Unione Europea è dunque solo una norma che accoglie le richieste degli old media rispetto a chi ha fatto profitti, eludendo anche le tasse, attraverso la libera circolazione dei contenuti. È un conflitto che non dovrebbe vedere uno schieramento con l’uno o l’altro fronte. Si tratta sempre di grandi imprese globali sia che si chiamino Google o gruppo Murdoch, Facebook o Vivendi, senza nominare i colossi dell’entertainment asiatici o africani che si sono affacciati sul mercato mondiale. Bisognerebbe affermare il principio che i contenuti sono un bene comune, perché prodotto dal nostro stare in società. Capisco che può risultare forse astratto, ma produciamo libri, musica, immagini in base alle relazioni sociali che abbiamo. Respiriamo lo stesso spirito del tempo e lo elaboriamo. Quando scriviamo un articolo, un romanzo, un saggio, un jingle attingiamo a un sapere comune diffuso che non può essere privatizzato. Questa è la battaglia che va condotta.
RDG: La rivoluzione digitale sta riducendo la discussione politica a pura propaganda e cura dei profili personali dei politici stessi. Come invertire la tendenza?
BV: La propaganda c’è sempre stata. E la politica spesso è stata solo propaganda. Quello che mi sembra stia emergendo non è il dominio della propaganda, ma quello che filosofi e neuroscienziati chiamano il mondo della “post verità”. Cioè tutto diventa interpretazione, tutto è verosimile, tutto può essere vero o falso. Sono cioè crollate tutte le gerarchie del sapere e della conoscenza del mondo. È questa la realtà con la quale fare i conti. Inoltre, c’è una metafora usata per descrivere i comportamenti in Rete. È quella dello sciame che si forma in base a un obiettivo da raggiungere, alla condivisione di un modo di essere, di un sentimento o di un risentimento. Si forma e si dissolve una volta che l’obiettivo è stato raggiunto o il sentimento si stempera, fino a dissolversi. Dunque, la politica nel web deve tenere conto dei flame, degli scontri aspri, degli insulti, perché viene meno l’intermediazione classica del partito, del sindacato, delle associazioni degli interessi. L’opinione pubblica è cioè soggetta a fluttuazioni, flussi di idee che non trovano mai verifica. Per alcune forze politiche, la rete sarebbe il regno della democrazia diretta che può fare a meno di ogni forma istituzionale. È una baggianata. La democrazia diretta si fonda sulla discussione, sulla messa in campo di opzioni collettive condivise e messe in tensione e in conflitto con altre opzioni, punti di vista. È questo quel che avviene nel web? C’è da dubitarne. Funziona così quando c’è un linkage tra ciò che accade fuori e quello che accade dentro la Rete. Ma quando c’è assenza del fuori, la Rete diviene il fondo limaccioso della post verità. Come affrontare questa situazione? Tornando al passato? No, ma attrezzandosi per acquisire strumenti – tecnici e culturali – per demolire le post verità che vengono proposte. Può sembrare una riduzione del danno, ma significa fare leva sulla crescita di consapevolezza dei singoli, sulla loro capacità di stabilire cooperazione sociale. Insomma, occorre rompere la visione del navigatore della rete come una monade senza legami o come un individuo proprietario che ragiona solo in termini di interessi individuali. È la concezione neoliberista dominante, che ha anche una versione tecno-progressista, che va sovvertita, cambiata, affermando che la natura umana è sociale. Senza le nostre relazioni umane, affettive, professionali non saremmo nulla. Per questo serve fare politica dentro e fuori la rete. In fondo siamo animali sociali. E politici come diceva Aristotele.
RGD: Il web può essere considerato un “bene comune”? E, se sì, come tutelarlo?
BV: Evgenij Morozov, un eccentrico studioso della netculture bielorusso che da collaboratore di George Soros si è nel tempo radicalizzato teoricamente e politicamente, propone una socializzazione dei mezzi di produzione della Rete. Una provocazione la sua, che contiene tuttavia una indicazione politica che non va respinta. Il web è un bene comune perché prodotto dalle nostre relazioni umane. Poco importa se gli investimenti iniziali siano stati statali, militari, universitari. Era usato per comunicare, cioè per quell’attività che è una caratteristica della nostra specie animale. C’è poi qualcuno che se ne è appropriato. C’è stata una accumulazione primitiva e un’espropriazione da parte di imprese private. Bene, l’unico modo per difenderlo è arduo, ma dovrebbe costituire l’orizzonte delle iniziative politiche tese a una riappropriazione di ciò che le imprese e gli Stati nazionali hanno espropriato.


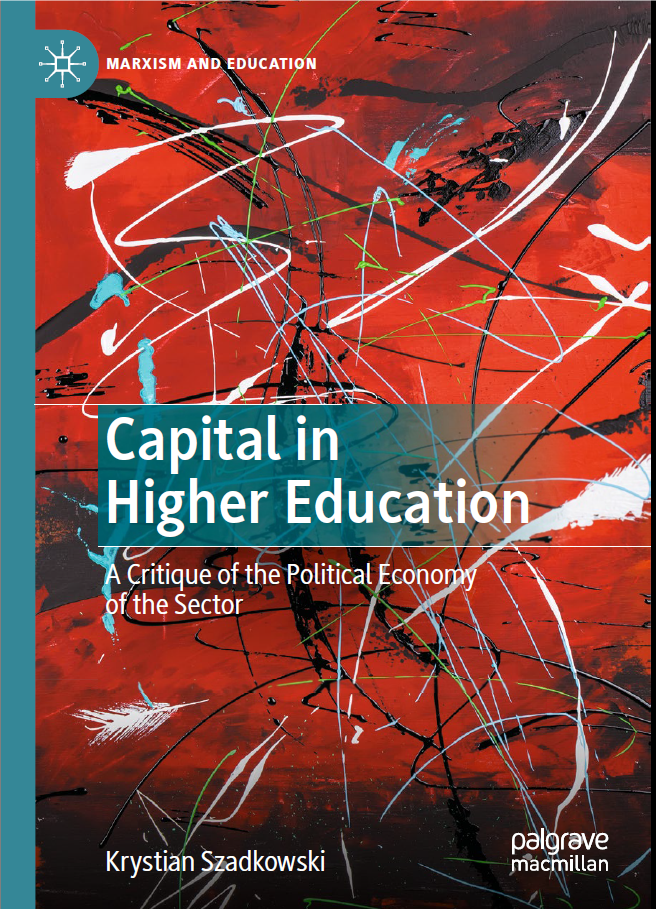





[…] Massimo Franchi, “In ricordo di Benedetto Vecchi. I big data, il complesso militare digitale e… […]