Erano gli ultimi giorni di febbraio, esattamente tre anni or sono, e tutte le testate giornalistiche nazionali riportavano in prima pagina la notizia con toni allarmistici: iniziava a diffondersi anche tra i cittadini italiani il Coronavirus Sars-cov2, fino ad allora ritenuto un “virus cinese” che stava innescando un’epidemia come altre già osservate in tempi recenti, la cui diffusione (si sperava a queste latitudini) non avrebbe probabilmente superato i confini del continente asiatico. Di lì a poco invece l’Organizzazione Mondiale della Sanità diffuse un comunicato in cui sottolineava la rapida diffusione del Covid-19 in oltre 100 Paesi e per questa ragione estendeva l’invito a considerarla una vera e propria pandemia. Dopo circa un anno e mezzo di drammatica crisi sanitaria, a tratti rallentata dalle misure di contenimento del contagio e dall’implementazione delle campagne vaccinali nei Paesi ad economia capitalistica avanzata, si iniziò a diffondere il termine sindemia per indicare come i livelli di incisività e diffusione dell’agente infettivo dipendessero anche dalle caratteristiche sociali, economiche ed ambientali proprie del contesto e dalle specificità dei soggetti su cui attecchiva. Per dirlo con un termine harawayano, è stata in questo modo sottolineata la dimensione naturalculturale del virus dopo che già era stata riconosciuta come sua causa la distruzione ecosistemica prodotta dallo sviluppo capitalistico globale. Nonostante ciò e nonostante i costi sociali ed economici che questa crisi ha determinato, tutte le scelte politiche sono state orientate alla salvaguardia del sistema produttivo più che ad un suo parziale o radicale ripensamento. Il processo di naturalizzazione e individualizzazione della malattia che è stato funzionale all’affermarsi di questo ordine di discorso ha raggiunto la sua massima espressione quando, a fronte del diffondersi di varianti considerate meno pericolose, è stato annunciato il raggiungimento di una fase di sviluppo endemica del virus. Questo ha portato alla rimozione di ogni tipo di misura precauzionale e, cosa ancor più preoccupante, non sono stati pensati o programmati interventi che andassero nella direzione di una prevenzione dai rischi connessi a potenziali futuri eventi pandemici come il potenziamento e ripensamento dei sistemi sanitari e di tutte le politiche di welfare.
Ma in che modo la pandemia e questa sua gestione neoliberale hanno avuto un impatto sugli strumenti di governance, sulle condotte individuali e collettive, sulla costruzione della soggettività ed in generale sul funzionamento della società capitalistica contemporanea? Questo è l’interrogativo da cui Federico Chicchi e Anna Simone muovono riprendendo un ragionamento avviato alcuni anni prima e che aveva trovato un punto di condensazione nella pubblicazione di La società della prestazione (2017). Il sociologo e la sociologa ripartono esattamente dalle frasi conclusive di quel volume e dalla speranza che possa “riaprirsi il campo del desiderio e del soggetto imprevisto che scombina gli ordini discorsivi e i dispositivi del tutto previsto” (ibid., p.168). Molto più di un filo rosso lega i due testi e a distanza di cinque anni alcune categorie vengono aggiornate, mentre si individuano tendenze (come quella verso la digitalizzazione o piattaformizzazione) che sembrerebbero non solo confermate, ma addirittura approfondite nella contingenza pandemica. La società della prestazione era stata descritta in quanto fase di sviluppo capitalistico caratterizzata dall’universalizzazione del mantra della competizione e della concorrenza e dalla generalizzazione della forma impresa sin nei meandri della soggettività. Questa spinta all’autoimprenditorialità e lo sviluppo di forme di assicurazione privata che l’hanno accompagnata, avrebbero determinato il superamento della società del rischio descritta da Beck alcuni decenni prima. Sostengono oggi l’autore e l’autrice che la parziale ristrutturazione sistemica avviata dalla contingenza della crisi pandemica abbia determinato il ristabilirsi di un clima di insicurezza sociale e il riattualizzarsi del rischio non più come limite o minaccia da cui difendersi, bensì come elemento divenuto sistemico e ineliminabile, funzionale alle strategie di governo. In questo modo il principio prestazionale e l’imperativo dell’autoimprenditorialità che ne deriva non sono stati rimossi, ma semmai estesi e rafforzati nonostante la promessa di un benessere futuro sia divenuta sempre meno credibile nei tempi incerti che stiamo vivendo, segnati dalla crisi ecologica e dai suoi prodotti derivati come appunto il Covid-19 o meglio il “soggetto imprevisto”. Questo è il titolo del libro che mi appresto a discutere, edito nell’estate del 2022 dalla casa editrice Meltemi e già presentato e dibattuto in diverse occasioni negli ultimi mesi. Con questo termine i due scelgono di riferirsi appunto all’evento pandemico riprendendo una locuzione che in passato alcune autrici avevano usato per descrivere l’irrompere del pensiero dei movimenti femministi nella scena politica e nel dibattito pubblico nazionale a partire dagli anni Settanta. Il primo utilizzo del termine viene fatto risalire a Carla Lonzi, ma è stato successivamente ripreso in altre occasioni tra cui recentemente come titolo di una mostra d’arte dedicata al rapporto tra arti visive e movimenti femministi tenutasi a Milano nel 2019. È l’elemento di rottura e di potenziale innovazione che viene sottolineato da tale espressione e per questa ragione Chicchi e Simone si chiedono se il suo utilizzo nell’attuale contesto possa rivelarsi funzionale anche al tentativo di inquadramento politico dell’evento pandemico e dei suoi effetti nella società odierna. La conclusione a cui giungono è che nonostante l’iniziale interruzione di una parte dei flussi economici e la sospensione della routine ordinaria avessero aperto uno spazio politico e un tempo utili per ripensare il senso dello sviluppo capitalistico, in breve tempo il sistema è stato in grado di riorganizzarsi e proseguire sulla strada della neoliberalizzazione trovando il modo di “negare le sue responsabilità di fronte alla tragedia” (p.57).
A livello di struttura il libro segue (non in maniera pedissequa, ma a grandi linee) lo schema già sperimentato nel volume precedente, che vede i contributi dei due muoversi in un dialogo aperto e costante seppur organizzati in sezioni differenti. I primi capitoli sono dedicati all’analisi dei mutamenti nel contesto politico e degli effetti prodotti a livello della soggettività. Se il sistema sociale ed economico è in parte (im)mutato seppur ancora contraddistinto dall’affermarsi dei principi del neoliberalismo come “ragione del mondo” (secondo l’ormai celebre definizione di Dardot e Laval), il venir meno della sua dimensione promissoria ha fatto sì che crescesse ancora di più il disagio psichico che già caratterizzava la soggettività prestazionale e che si diffondessero e sistematizzassero maggiormente i tentativi di far fronte a ciò attraverso una sempre più diffusa medicalizzazione.
I capitoli centrali sono invece dedicati all’analisi dell’infrastruttura tecnica che ha contraddistinto e reso possibile lo sviluppo della società della prestazione prima e della sua declinazione pandemica poi. Chicchi e Simone tornano quindi a parlare del ruolo delle tecnologie digitali e delle piattaforme sottolineando gli elementi di novità che l’arrivo del soggetto imprevisto ha portato e i processi che ha accelerato o esteso. La sociologa del diritto si concentra sull’effetto che ha avuto il momentaneo spostamento di tutte le interazioni sociali nello spazio della rete durante il primo lockdown sostenendo questo abbia aperto una possibilità al divenire totalizzante del web e abbia portato una parte della popolazione a sperimentare un passaggio significativo da una situazione di separazione (per quanto sfumata) tra attività online e offline al progressivo venir meno di questa divisione dentro il paradigma delle esistenze onlife dove il digitale è incorporato in ogni attività quotidiana. Conclude il discorso con un monito importante per il prossimo futuro, affermando che “le grandi sperimentazioni utilizzate in condizioni di necessità, urgenza ed emergenza di solito lasciano dei segni che modellano il mutamento sino a generare una nuova dimensione di normalizzazione dell’eccezione” (p.88). Chicchi spinge fino alle estreme conseguenze la riflessione sul ruolo delle piattaforme arrivando a sostenere che il rilancio della soggettività prestazionale nel quadro del capitalismo neoliberale sia passata per una riorganizzazione dei sistemi e dei rapporti produttivi e riproduttivi attraverso i dispositivi della governamentalità algoritmica, ossia le piattaforme. Riprende dal pensiero di Antoinette Rouvroy la categoria di governamentalità algoritmica, da intendersi in quanto strategia di governo fondata sulla capacità di predizione e prelazione propria degli algoritmi e sostenuta necessariamente dalla grande disponibilità di dati che le tecniche di data mining e l’immersione pressoché totale dei soggetti nelle reti del capitalismo digitale oggi rendono possibile.
Prima di giungere alle conclusioni i due si soffermano su un’ulteriore questione aprendo una riflessione sul contributo della riproduzione sociale e del lavoro di cura nel contesto pandemico. La centralità da questi assunta, affermano Chicchi e Simone, è stata solo in parte determinata dalle recenti circostanze poiché in generale rappresenta l’esito di in un processo di radicale messa in discussione del confine tra attività produttive e riproduttive che era già avviato da diverso tempo. Da un lato viene sottolineato il ruolo che le tecnologie e le piattaforme digitali hanno avuto nel consentire una sempre maggiore estrazione di valore dalle attività riproduttive, dall’altro invece viene posta l’attenzione su come l’enfasi sul contributo del lavoro di cura, che ha caratterizzato soprattutto le prime fasi della pandemia, non abbia avuto alcun effetto migliorativo per le condizioni di vita e di lavoro di chi lo sostiene, ma abbia anzi precarizzato e svuotato di valore ulteriormente tali mansioni per lo più femminilizzate. Paradossalmente ciò è avvenuto mediante il riconoscimento del ruolo essenziale di tali attività, ma al posto che evidenziare lo sfruttamento insito in esse e l’invisibilizzazione che le aveva fino ad allora contraddistinte, sono stati tratteggiati gli aspetti eroici determinando una sentimentalizzazione della cura che è stata la migliore soluzione possibile per il rilancio dell’economia capitalistica in un momento in cui cresceva la “consapevolezza generalizzata di una condizione irreversibile di vulnerabilità collettiva” (p.153).
Un’ultima analogia con il loro precedente libro si ritrova sul finale, quando Chicchi e Simone propongono tre diverse e interconnesse figure del rovescio (in Società della prestazione venivano definite come figure per resistere o aree di incurabilità, ma si tratta sostanzialmente della stessa idea di strumenti utili a pensare l’interruzione e la trasformazione). Arte, misura e desiderio erano state individuate sei anni fa come concetti utili per costruire una cultura del limite. Oggi che tale cultura è stata strumentalmente sussunta dalle teorie che utilizzano il concetto di sostenibilità per promuovere un’ulteriore mercificazione di ogni aspetto della vita, è necessario trovare nuove figure intorno a cui costruire alterità e alternative: conflitto, economia della restituzione e materialismo sensibile. Il primo termine è sicuramente di più facile lettura, mentre per quanto riguarda gli altri mi preme solo qui specificare che per restituzione si intende qualcosa di più della semplice redistribuzione e che il materialismo sensibile sostiene una politica che rimetta al centro i corpi e ne indaghi l’intima connessione con la dimensione desiderante troppo spesso frustrata.
“Ecco allora la nostra attuale urgenza che si fa vivida: dobbiamo imparare ad ascoltare il soggetto imprevisto come quella possibilità di accensione di un’inedita intermittenza dentro la quale interrompere il processo di disapprendimento dell’amore cui siamo continuamente sottoposti nella società della prestazione e del funzionamento algoritmico”(p.116).
Molto probabilmente saremo condannati a confrontarci con altre “comete” (i due utilizzano talvolta questa metafora riprendendola dalla narrazione in chiave allegorica presentata nel film Don’t look up analizzato nelle pagine iniziali) dagli effetti devastanti se non saranno i movimenti presenti e futuri ad imporre un nuovo ordine del discorso e una svolta radicale, se non sapranno essere i nuovi soggetti imprevisti.


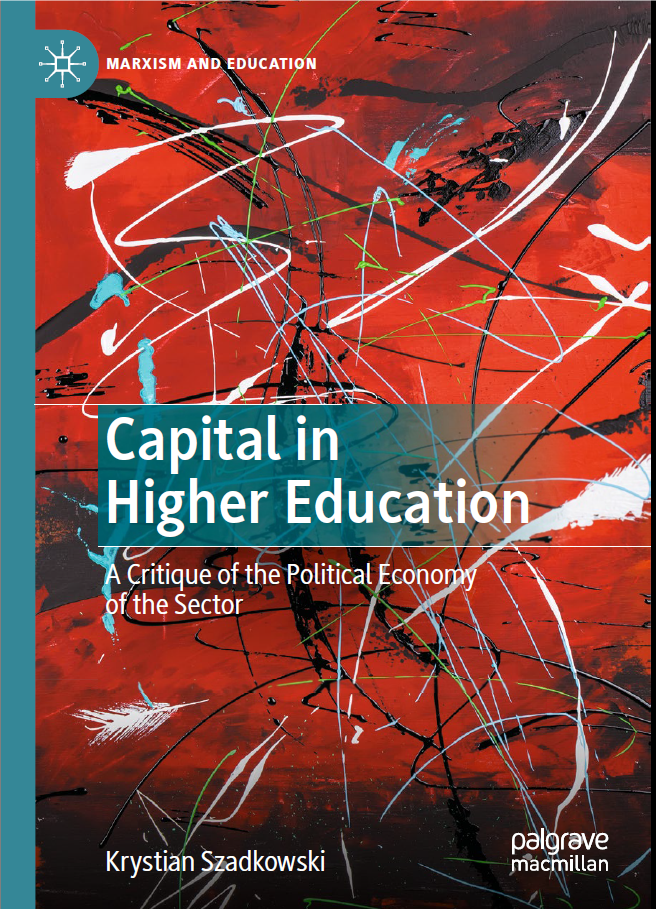





Scrivi un commento