Detta più semplicemente: la vita stessa è simbiosi dall’inizio alla fine.
Margaret Mc Fall-Ngai
Secondo The Carrier Bag Theory of Fiction, testo pubblicato nel 1988 da Ursula le Guin in Women of Vision: Essays by Women Writing Science Fiction, c’è la Storia – la storia che non racconta, ma si limita a trascrivere la lotta tramite cui, dal pre-umano al post-umano, l’umanità ha rappresentato i modi della sopravvivenza uccidendo, guerreggiando, violentando, sfruttando, penetrando, catalogando e dividendo – la storia dell’omicidio – e ci sono le storie, le storie della vita. Già fin dalla preistoria, il canone narrativo ha prefigurato l’incontro con l’altrimenti-che-umano, inscenando la vita come lotta per la sopravvivenza. La caccia, la violenza e la sopraffazione acquisiscono valore solo se trasposte in rappresentazione. Come afferma Le Guin, «non fu la carne a fare la differenza. Fu la storia».
Antonia Anna Ferrante, attivista e ricercatrice, terrona e transfemminista, in Cosa può un compost. Fare con le ecologie femministe e queer (Luca Sossella Editore) rilegge la FantaScienza della scrittrice americana – il cui racconto sulla sacca ripropone in versione italiana – nei termini di un’operazione speculativa-narrante con l’obiettivo, se così si può dire, di cogliere la logica del senso – ma, del resto, fin dal titolo del volume è evidente l’influenza di Deleuze – di un uso alternativo della vita, soprattutto in un momento, quale l’attuale, in cui l’apocalisse capitalista sembra dettare le sue ultime volontà prima del congedo definitivo dell’umanità (e de* altr*) dalla Storia. Più che soggetti resilienti, secondo la vulgata liberista, siamo vittime della fine di tutte le fini, come scrive Roberto Ciccarelli in Una vita liberata. Questa fantascienza è, in altre parole, un errare oltre i confini del consenso e del consentito; è uno s/piegare, un distendere le pieghe, un aprirsi alle trasformazioni di mondi. Pertanto, la domanda Cosa può un compost? – relazione oscena tra scarti di vita e putrescenti combinazioni sociali – tradisce e traduce, nella furia del presente, la domanda, umana, troppo umana, Cosa può una vita?
La sacca, allora, costituisce l’elemento cardine per ricostruire la storia – finora solo immaginata – di un mondo alternativo, strutturato sulla conservazione del tempo, degli alimenti e dello spazio in cui vivere e abitare. Da questa prospettiva, anche la casa materializza l’idea di involucro, di recipiente piuttosto che di possedimento, di proprietà –in Le nozze di Cadmo e Armonia, Roberto Calasso sottolinea che la pentola di bronzo ha segnato uno dei vertici della civiltà umana, dalla Cina all’antica Grecia, poiché a questo oggetto veniva delegata una funzionalità pratica (la cottura dei cibi) e cultuale (il fatto che fosse sempre rivestita di figure teriomorfe è un’evidente allusione a una primitiva forma di compostaggio culturale e biologico). Il recipiente come primevo dispositivo culturale è insomma una tana in cui trovare rifugio e in cui conservare cose e alimenti che andranno a formalizzare il canone ecologico della convivenza, prima intraspecifico e, in seguito, interspecifico, o meglio, transpecifico. La sacca è l’archetipo della convivenza e della relazione simbiotica tra esseri, oggetti e dispositivi semiotici in divenire. In questo senso anche un libro, un libro come questo, tracciato con sensibilità ecologica queer, è un contenitore di parole che diventano cose che diventano significati che diventano racconti che diventano relazioni “speciali”.
Il racconto fantascientifico di Le Guin – ma anche la mostruosa criptobiologia di Donna Haraway o la biologia co-evolutiva di Lynn Margulis o gli assemblaggi polifonici di Anna Tsing o la fisica meticcia di Karen Barad… – restituisce un senso della vita come insieme di «ammucchiate, parassitaggi, collaborazioni e boicottaggi» (p. 47), un insieme che ispira Ferrante in quanto de-istitutivo della centralità antropocentrica dell’Eroe su cui ha preso forma la gloriosa narrazione letteraria occidentale e la mitologica autopoiesi dei Sapiens. Al contrario, le storie di Le Guin sono scarti dell’universo, frammenti morti di supernove che ricompongono nuove costellazioni atomiche, invasioni extraterrestri che si ibridano con i/le nativ* originar*, producendo simbiogenesi contronatura: «Lo scarto entra in composteria senza alcuna malinconia della propria identità, accettando di divenire altro, trasformandosi individualmente e trasformando l’intero composto; eterogeneo assemblaggio multilivello tra molecole, corpi uni e pluricellulari che cooperano, negoziano, si invadono e parassitano, cambiando in continuazione la loro composizione e ciò che li circonda, al punto di rendere impossibile la differenziazione degli elementi» (p. 9).
Se il compost è un processo in cui funghi, batteri, vermi, rifiuti… collaborano, spesso opponendo le proprie ontologie in un incontro/scontro in cui a decomporsi è l’organizzazione umana della vita e della morte, di tale processo la lettura transfemminista e queer evidenzia che la capacità di agire simbioticamente appartiene alle relazioni intime tra partner diversi piuttosto che ai singoli individui; relazioni talmente intime e co-dipendenti da mettere a repentaglio l’ordine del discorso che ancora considera i corpi umani e quelli inumani come entità da immunizzare – da preservare a tutti i costi da pericolose contaminazioni o da eliminare se già considerate infettate. Sta di fatto emergendo con sempre maggiore evidenza che la vita stessa altro non sia che un brulicante compostaggio di alleanze e negoziazioni, in cui la vulnerabilità diventa ciò che permette di «ripensare il nostro ruolo negli ecosistemi fuori dalle gerarchie dell’umano» (p. 21). In breve, come sostiene Haraway, siamo humusità più che umanità. Oppure, come direbbe Margulis, non siamo mai stati individui, semmai licheni. La teoria della simbiogenesi, la relazione simbiotica con effetti progressivi sull’evoluzione delle specie, ha pertanto il grande merito di decostruire la retorica scientista sulla presunta indissolubilità e integrità dei singoli organismi al cui vertice bio-eco-logico è sempre posto l’Umano. Si comprende così che la sacca di Le Guin è il mondo stesso dentro cui co-evolvono e co-divengono tutte le creature –umane e non umane, se questa cesura ha ancora un qualche senso.
La potenza del saggio di Ferrante sta nella sua indefinibilità concettuale e forse la maniera migliore per approcciarlo è ricombinare, come in un puzzle, le parti scritte con i tentacoli del polpo che ne attraversano le pagine. Una lettura metonimica del libro permette, infatti, di far convergere i dettagli del polpo – corpo espanso e cervello diffuso – con lo spirito dissidente e disobbediente che anima l’autrice, mettendo in tal modo in evidenza l’antagonismo queer militante con cui si intende confutare la linearità progressista liberale. Il fatto stesso che Ferrante opti per un’identità terrona obbliga a una lettura semioticamente improntata a radicare la battaglia ecologica, politica, femminista e antispecista in concrete esperienze di conflitto territoriale. Napoli, anche per la sua storia di continui incroci etnici, culturali e politici, diventa il luogo dove compostare racconti per apprendere nuove possibilità di stare al mondo. Vivere in una Terra condannata – o, se preferite, citando Haraway, sopravvivere su un pianeta infetto – significa interpellare il dispositivo coloniale dello sfruttamento che vede la città partenopea farsi catalizzatore storico delle contraddizioni del Bel Paese: «Non intendo fare del colonialismo una metafora, ma indicare il rapporto che c’è tra ingiustizia sociale e ingiustizia ambientale, il regime di sfruttamento di corpi e territori del sistema sociale ed economico del nostro sistema epistemologico, cioè il modo in cui abbiamo costruito un sistema scientifico e filosofico fondato sulla violenza» (p. 17). Napoli è città compost, crocevia di una genealogia non lineare né binaria dove grovigli bastardi di femminelle, trans e neri a metà hanno attecchito fermentando sottoterra; incroci umani e non umani eredi delle mitologie mediterranee pre-patriarcali e pagane, che rigettano l’epistemologia occidentale e trasformano il lessico discriminatorio e razzista del potere in semiotica della resistenza e del conflitto. In ricerca di parentele simpoietiche in grado di smantellare le politiche criminali delle società capitaliste basate sulla ri/produzione dello stesso; di parentele non-generative della medesima specie, di parentele rigenerative di una nuova humusità che prescinde dai legami di sangue – sanguinosi e sanguinari. Come è il caso di Osden nel racconto di Le Guin Più vasto degli imperi e più lento, in cui, grazie al suo autismo, può sviluppare alleanze con l’intero vivente senza alcuna inibizione e può comunicare con un nuovo pianeta senza la necessità di alcuna codificazione linguistica.
Le parentele compostiste che Ferrante è impegnata a cartografare sono uno stimolo a intraprendere forme di “genitorialità surrogata” estranee alle logiche familiste, eteropatriarcali, razziste e speciste del capitalismo. In questo senso, esse hanno poco a che fare con il tecno-capitalismo contemporaneo, che immagina un mondo postumo più che postumano. Anche Osden è un compost in quanto, disinnescando le proprietà specifiche del soggetto, esplode in molteplici corpi dissidenti sospesi tra un “regno” animale ancora da inventare e un “regno” vegetale ancora da comprendere. La fantascienza utopica di Le Guin è sempre indeterminata, priva di soluzione e di finali; esattamente come i racconti compost di Ferrante che revocano i rapporti causa-effetto e si rivoltano al divenire – più conatus e meno cogito, più Spinoza e meno Cartesio, come nel Ciclo della Terra Piatta di Tanith Lee, altra scrittrice per la quale il genere fantasy è fantasia sessuale fluida narrata facendo leva sulle forme arcaiche-future del racconto orale.
La politicità delle storie di Ferrante si evince inoltre dalla diffidenza con cui l’autrice smonta la hybris dei codici emancipativi del liberismo progressista che, con la scusa di salvare il pianeta e i suoi abitanti, cioè loro, rimane ossessivamente legato ai codici reazionari del noi: indiscutibile è la nostra presenza sul palcoscenico della vita; indispensabile il nostro intervento intelligente sul destino de* altr* ridott* a natura…; insomma senza di noi niente fine, niente inizio e niente mondo. Sarebbe invece necessario pensare con la macchina – che nulla ha a che fare con lo sfruttamento tecnologico della natura –, perché è la macchina che può aiutarci a capire che i corpi – i loro e i nostri – sono assemblaggi di cellule, virus, circuiti, norme e prestazioni socio-culturali – brown commons come direbbe Josè Esteban Muñoz: collettivi umani e non umani che si “salvano” grazie a operazioni di compostaggio esistenziale in cui si condividono parole e cose; nuove soggettività politiche in grado di sfidare le divisioni tra umano e non umano o tra vivente (ciò che significa) e non vivente (ciò che è insignificante). Per Ferrante la tecnologia non è uno strumento per uccidere, ma un contenitore di energie latenti come il cibo che sostiene o i fiori che commuovono. In questo senso, il corpo è un recipiente «che consente l’espansione della forza vitale in ogni direzione. È così che il racconto stesso è una sacca che permette di raccogliere, portare, trasmettere storie che raccontano altre storie della vita, in cui la prospettiva ecologica non esclude la tecnica, ma la contiene cambiandola di segno» (p. 69).
Ferrante aggiunge la sua voce narrativa ai video digitali di Maria Klonaris e Katerina Thomadaki, artiste pluridisciplinari e cineaste di cinema corporel, il cui compost politico-concettuale è un misto di energia visiva, chiaroveggenza transindividuale e futurità simbiotica; alle litanie incantate di Zola Jesus, cantautrice e performer americana, la cui “stregoneria” diventa strumento di liberazione dall’Apocalisse e dall’avidità con cui il capitalismo continua a colonizzare menti e territori; alle illustrazioni di Maurice Sendak, i cui mostri selvaggi danno corpo a una neo-cultura cyborg che supera la dicotomia biologia-scienza, riposizionando l’umano nell’ambiente e l’inumano nello spazio della cultura e dell’etica… Non siamo ancora de* sopravvissut* fintanto che potremo raccontare un altrove in cui lotta politica dal basso – lotta di classi e di classificazioni – e redistribuzione del sensibile rovescino il conformismo apocalittico della fine propagandato dal neoliberismo. E questo Ferrante lo sa bene, e altrettanto bene lo racconta.
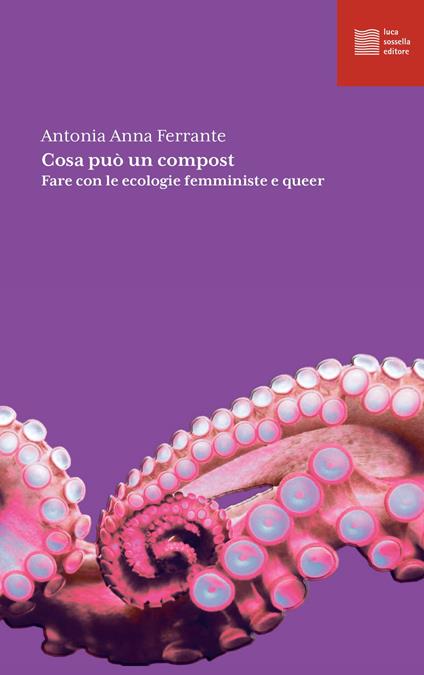







Scrivi un commento