- Culture dell’audit
L’università, la ricerca e la trasmissione del sapere stanno vivendo negli ultimi anni in Italia un cambiamento epocale, dentro un generale senso di smarrimento da parte di molti suoi lavoratori: più che il definanziamento strutturale, l’austerity e la crisi economica, è l’immissione di modelli di audit (valutazione) dei processi lavorativi come riforma tecnico-amministrativa che ha drammaticamente mutato il senso di una lezione, di un progetto di ricerca e del senso delle relazioni sociali: di fatto, intaccando ampiamente la libertà e autonomia del lavoro universitario, precario e strutturato.
Poco visibili e ‘manifestabili’ all’esterno dell’università, e poco comunicabili al suo interno proprio perché ammantate come manna efficientistica e morale per risolvere i problemi organizzativi, le culture dell’audit introdotte in nome dell’ottimizzazione delle risorse stanno svuotando da dentro i significati della didattica e della ricerca attraverso la costruzione di una miriade di scatole procedurali e valutative di ogni atto lavorativo. Parte di un flusso di modelli globali che hanno già stravolto i sistemi educativi e universitari nell’“anglosfera”, i modelli dell’audit, all’interno delle riforme di new public management dei servizi statali sono entrate come un fiume in piena in Italia in occasione della crisi finanziaria, del debito e della shock economy che hanno determinato: il sapere si sta riconfigurando alle sue fondamenta, in un processo di rottamazione e nuovismo, direttamente nelle pratiche mondane di lavoro, dove è valutato e risemantizzato in base ad “azioni” di “produttività” e “competitività”, e attraverso nuove politiche del numero.
Ma questi modelli sono culturali: hanno una loro storia, una cosmologia e costruzione simbolica e un nuovo linguaggio composto dai termini anglofoni dell’audit, che per necessità riprendo in queste pagine. Tutto ciò attiva “rituali di validazione” Una costellazione di procedure di valutazione compone oggi il lavoro universitario, in una burocratizzazione perversa che è diventata spesso fine a sé stessa, oltre che una forma di disciplina e auto-disciplina che opera a molteplici livelli. Un “pieno” di procedure è diventata l’occupazione principale dentro un doppio cambiamento, riscontrabile in altri settori lavorativi: la delega burocratica a valutare e misurare per comporre “ranking” a ogni livello, ma anche l’immissione di piattaforme informatiche che “comandano”, misurano, indirizzano il lavoro, entro cui il medium si fa messaggio. Nella loro congiuntura, il lavoro quotidiano è costituito da criteri cangianti e contradditori delle misure del lavoro – anche di ciò che non è misurabile, come gran parte delle dimensioni culturali e sociali – e da una dimensione arbitraria, discrezionale e, quindi, quotidianamente violenta fatta del “non ci sono alternative”; una “performance” di efficienza nella ridefinizione del lavoro di insegnamento e di ricerca, dunque, che maschera frammentazione, paura, ricatto e alienazione perché sotto continua valutazione arbitraria. Ma la buona notizia è che sono modelli culturali! Ho incontrato e studiato, da antropologo, i sistemi di audit in Giordania, introdotti non a caso nelle politiche di aggiustamento strutturale a fine anni Ottanta nell’aiuto allo sviluppo per l’ottimizzazione dell’acqua in agricoltura, come controllo finanziario delle risorse amministrative del paese: già allora, come in tanti altri contesti del sud del mondo, uno strumento di controllo finanziario (accountance) si trasformava in una ridefinizione delle politiche interne e in un effettivo cambio di governo in nome di procedure tecniche, in “conditionalities” ai fondi di sviluppo, in una definizione esogena dei bisogni degli agricoltori e di categorizzazione del loro lavoro, esulando completamente dai processi sociali locali e tanto più dalle dinamiche di marginalità e povertà. Una “invenzione” dell’Altro nei discorsi dello sviluppo (ampia è la letteratura) dove uno strumento finanziario si traduceva in strumento di ingegneria sociale, in leva politica e in scontro culturale tra diverse definizioni e mondi di senso relativi a cosa fossero l’acqua, il coltivare, i beni comuni tra pianificatori e popolazioni locali: modelli di tecno-politica con tutte le loro contraddizioni, dove i maggior cambiamenti avvenivano attraverso atti amministrativi discreti, depoliticizzanti. Tecnici, per l’appunto. Già a fine anni Settanta i modelli di audit furono inseriti nella macchina dello sviluppo nelle frontiere post-coloniali come controllo finanziario delle risorse, dove gli strumenti e indicatori di valutazione erano innanzitutto finanziari, e, in secondo luogo, erano negoziati con le amministrazioni “partner”: lo strumento contabile (accountance) era ben distinto dalla valutazione dei processi lavorativi (accountability), due livelli che nella realtà italiana sono venuti a fondersi e confondersi in modo perverso. “Non c’è più il buon vecchio audit” di un tempo, si potrebbe dire! Nel momento in cui oggi vivo sulla mia pelle ciò che gli agricoltori giordani e palestinesi vivevano come irrealtà e politica arbitraria (ma con dimensioni collettive di manipolazione e resistenza a queste politiche), in Università ci ritroviamo “senza alternative”, in una situazione in cui risuona quotidianamente quell’esclamazione della Thatcher, “there is no such thing as society!”, che coniò quelle politiche iperliberiste oggi tornate come unico margine di senso del politico. Evidenziare alcuni aspetti antropologici di questa costellazione sociale calata dall’alto è il primo passo per estrarli dal loro mondo tecnico e ridare significato a un sistema morale e simbolico che sta ridefinendo la stessa organizzazione della società e le forme di gerarchia e di esclusione, presentandosi come nuovo principio organizzatore etico e morale, non solo dell’Università dove si sperimenta. E se il modello è culturale, una lotta culturale è possibile e le alternative ci sono. 1.1 Nuovi assoggettamenti Più che un mero processo di contabilità finanziaria i sistemi di audit ridefiniscono dall’interno i ruoli del docente (erogatore e produttore astratto dalle relazioni sociali di lavoro) e dello studente (ormai “cliente” in una relazione di customer-satisfaction, ma in competizione con altri clienti…), misurati nella loro “produttività”, “efficienza economica”, “performance” e capacità di fornire ‘value for money’ (VFM): da modello finanziario, questi dispositivi sono diventati un modello generalizzato di governo e di ridefinizione del sociale e della relazione didattica, dove la relazione è sussidiaria ed è “erogazione”. Il docente è valutato, e quindi esiste, solo come un individuo atomizzato, monitorato e in competizione (per i Fondi di finanziamento ordinari, per avere un tutor a supporto della didattica, per i risultati della Valutazione qualitativa della ricerca e dei suoi “prodotti”), “libero di assoggettarsi” a questa nuova disciplina che si presenta con un linguaggio etico, e quindi apparentemente difficilmente criticabile (chi non vuole un università più trasparente ed efficiente come servizio pubblico?). E ogni individuo lavoratore è monitorato, e potenzialmente monitora altri, su indicatori misurabili, in una scala gerarchica di piccoli e grandi fratelli mensili (senza spettatori, se non l’apparato dell’Anvur, l’Agenzia nazionale per la Valutazione della Ricerca), di talenti e premialità come nuovi rituali burocratici dove contabilizzare la propria “performance”, in un gioco della concorrenza condotto però in regime di distribuzione della scarsità. Un fantasma si aggira a ogni gruppo di lavoro, aleatorio e arbitrario nella sua impersonalità: “siamo monitorati”, “siamo valutati nella perfomance” da parte dell’Anvur, l’istituzione di controllo pubblica ma sempre più privata, attraverso indicatori e logiche magico-esoteriche, oppure dalle “macchine” delle piattaforme informatiche, che accentuano il disorientamento e l’invenzione delle categorie astratte dal lavoro universitario. Le nuove forme di assoggettamento non sono repressive, ma persuasive e seduttive; si fondano su termini etici, sulla sensatezza del lavoro (efficienza), sulla libertà di competere come individui atomizzati. Farsi portatori della “trasparenza dei fondi pubblici” e di una migliore organizzazione sono chiaramente dei fini comuni, ma assieme scorre una “violenza organizzata di questa macchina ideologica che dissimula la soggettività del giudizio sotto un apparato ipertrofico di numeri, parametri, percentuali, algoritmi, medie, mediane”[2]. Le retoriche del merito e dell’insostenibile leggerezza dell’eccellenza, della performance degli obiettivi produttivi diventano il nuovo e fragilissimo ordine simbolico e morale delle condotte, della carriera connesse a un mondo economico immaginato. La realtà sociale di condivisione di ricerca e di insegnamento nella relazione didattica sono astratte; l’affrontare esclusioni e l’imparare dalle fragilità perdono legittimità.[3] A sua volta, a un tale regime di lavoro si contrappone un co-isolamento di tanti individui atomizzati (come nel resto della società), dove il corpo docente difende come può le decrescenti risorse, ma non ha tempo e parole per criticare un modello culturale, peraltro in una delle case della produzione culturale. Queste costellazioni disorientate di procedure sono sì tecniche, ma di costruzione del sé, come uno studio etnografico in Inghilterra ha mostrato: «routine e pratiche disciplinari sono i veicoli attraverso i quali i governi cercano di instillare nuove norme di condotta e comportamento nelle popolazioni a loro sottoposte».[4] Le politiche del numero sono state uno strumento fondamentale in epoca coloniale per reinventare “gli Altri”, tanto per porre nuove forme di governo (imperiale, ai tempi) e inventare nuovi soggetti, quanto, per esempio, per introdurre nuove misure d’acqua e di terra nell’estrazione indebita delle risorse.[5] Da sempre quantificare – i gruppi sociali così come l’acqua o i processi lavorativi – compone una politica del numero che applica e nasconde insieme nuove forme di governo e dove dinamiche anche di violenza politica assumono il linguaggio tecnico-burocratico del misurare, o inventare gli “altri” secondo nuovi indicatori, astraendo dalla realtà, come processo di semplificazione e riduzione nell’opera modernizzatrice[6]; processi sociali denominati, in contesti di pianificazione dello sviluppo, come “costruzione dell’ignoranza”[7], proprio nei luoghi del sapere intensivo. La costellazione delle misurazioni in università è una politica del numero per misurare (punire/premiare) la produttività economica, dal singolo lavoratore al corso di laurea, dal dipartimento fino ai ranking tra università, attraverso lo strumento arbitrale impersonale, tecnico e centralizzato della gara per l’eccellenza. L’arbitrarietà degli indicatori è amplificata dalla loro incoerenza, mutevolezza e dalla loro dinamica disciplinare (o misuri o chiudi): le “misure” e i saperi istituzionali, sembrano non avere più legittimità , mentre i processi educativi e di ricerca sono in larga parte non misurabili, ma comprensibili e valutabili con altri modelli, come la maggior parte del lavoro scientifico: come misurare il public engagement come si propone oggi? Come misurare la crisi sociale e la sofferenza? Come misurare il fatto che in ragione del sovraccarico burocratico non si ha più tempo e autonomia per fare ricerca e didattica, dignitosamente e a favore degli studenti? Ops, dimenticavo, clienti consumisti… Il nostro lavoro quotidiano parla di altre passioni e realtà diversificate. La cultura dell’audit è un nuovo linguaggio, esoterico, provincialmente e magicamente anglofono, dove si rinomina, tecnicizzandoli, ogni aspetto cruciale del lavoro universitario in modalità routinizzata: «il modo sottile e seducente in cui i concetti e le terminologie manageriali sono diventati parte integrante nel linguaggio quotidiano».[8] Io non “erogo” lezioni, ma insegno e dialogo in relazioni educative; non svolgo lezioni “frontali”, ma soprattutto oblique e circolari; non mi faccio “imprenditore” di me stesso, ma attore della condivisione del sapere; non valuto il mio collega dalla VQR che porta appesa alla schiena, ma sono convinto che l’unica speranza rimanga la condivisione della ricerca multidisciplinare sulle questioni della società; non insegno la politica dei numeri ma le relazioni e i desideri del sapere critico; e non con-corro, ma corro tra un’aula e l’altra assieme ad altri, tutti un po’ persi! Inoltre, l’audit all’italiana è un linguaggio della colpa e della costruzione di sfiducia[9], come nel resto della società sotto austerity: infantilizzati da procedure di valutazione, dobbiamo discolparci dallo stigma di lavoratori pubblici inefficienti e abbiamo spesso introiettato questo sentimento di redenzione/colpa che pervade tutto il linguaggio e gli atti amministrativi. La politica e il collettivo perdono rilevanza in qualsiasi ordine del giorno e la dimensione morale della colpa si fa performance pubblica quotidiana per l’urgenza e il ricatto sociale connessa alla loro “emergenza” ed eccezionalità strutturale e strutturante. Questa traduzione di strumenti manageriali si traduce inevitabilmente in linguaggi coercitivi in ragione della distanza dalla realtà lavorativa e provoca inevitabilmente il proprio opposto: si lavora peggio in competizione e senza riconoscimento del valore del proprio lavoro, così come ogni studio sulle risorse comuni e istituzionali mostra; una letteratura che è al centro oggi dell’innovazione (altra parola abusata nell’audit!) a fronte dei cambiamenti ambientali e della crisi sociale. Il feticismo burocratico delle quantificazioni e dell’evidenza (la prova burocratica del lavoro fatto di fronte all’ispettore) entra in conflitto aperto con i tempi e l’autonomia del lavoro didattico e delle relazioni didattiche. La forma-scatola della performance prende il sopravvento sui contenuti che diventano irrilevanti, in un capovolgimento della realtà sconvolgente. Il vuoto principio di prestazione sostituisce il principio di realtà e i desideri di sapere (del docente, dello studente e anche dell’amministrativo); il principio di performance esibita nei rituali di misurazione sostituisce il fare didattica e ricerca con i suoi tempi, strumenti, fatiche e passioni. Inoltre, la cultura dell’audit all’italiana si presenta come pedagogia nel suo costruire un lavoratore intellettuale nuovo, nell’insegnarli come essere performante e valutante in corsa e nel sapersi autodisciplinare in quanto nuovo soggetto: siamo aiutati ad auto-valutarci,[10] siamo liberi di essere controllati e controllare, all’interno di un’insicurezza permanente (tanto più nel vasto precariato strutturale ma sotto ricatto) e nell’arbitrarietà delle regole del gioco. E se tutto ciò assomiglia a dinamiche più generali e sociali nel neoliberismo, è da comprendere che il rischio di questa sovversione istituzionale a partire dall’università appare come un esperimento di ingegneria sociale. Certo, tutto ciò disegna una ridefinizione del lavoratore come dipendente salariato del lavoro cognitivo neoliberale, che tanto contrasta con il capitale simbolico dell’accademico; ma, soprattutto, ridefinisce ciò che è il sapere scientifico, le sue finalità e le sue necessarie libertà per la società, come iscritto nella nostra Costituzione.[11] Come già Herzfeld ha mostrato,[12] le culture burocratiche hanno una propensione per la “produzione dell’indifferenza”: astrarre, semplificare, tecnicizzare i processi sociali del corpo amministrativo e della società per produrre disciplina e per depoliticizzare decisioni politiche. Osservare le somiglianze e le diversità culturali dell’audit all’italiana nel contesto globale e storico non è certo la priorità della ricerca antropologica, ma oggi lo si rinviene sulla pelle di ogni antropologo/a così come di ogni ricercatore: come fare etnografia della diversità nell’epoca dell’indifferenza burocratica? Mitchell ha mostrato come l’aiuto allo sviluppo della UsAid americana sia stato uno strumento centrale per “inventare” e disciplinare l’Egitto: producendo categorie amministrative di clientele astratte dalla società, mappando e quantificando le risorse idriche e fondiarie con nuove misure a-sociali attraverso pratiche tecnico-amministrative finalizzate a depoliticizzare il cambiamento. Già vent’anni fa ci invitava dunque a immettere l’“aiuto” sulla mappa dell’Egitto, come attore integrante delle questioni di povertà e marginalizzazione che si volevano combattere.[13] La stessa cultura dell’audit, che sembra non avere luoghi fisici se non virtuali e monitoranti, va reimmessa nella mappa nelle università: si presenta come soluzione dei problemi, ma è parte integrante ormai dello svuotamento del lavoro universitario e delle relazioni sociali. Ma questi modelli sociali sono una copia raffazzonata di flussi globali nel contesto italiano: da noi più che altrove, chi monitora non è monitorato e valutato, disciplina con criteri contraddittori e arbitrari che non hanno controllo o negoziazione pubblica (neppur nelle enormi spese), né contempla un processo istituzionale che segua il profondo processo di cambiamento e la sua “efficienza” fuori dalla propaganda quantificante. La buona novella è quella che va verso l’“eccellenza”; i costi sociali, ma anche produttivi, per tutti i cittadini non sono contemplati lì dove il sistema di audit si pone come esterno al processo, in completa contraddizione ai modelli di audit nel sud del mondo dove sono nati. L’audit confonde strumentalmente il controllo finanziario con il controllo sociale e culturale del lavoro, e come tale va identificato: depoliticizza atti di potere, con la costruzione di una nuova gerarchia sociale. Questa costruzione della sfiducia collettiva e della colpa interiorizzata rende tale conflitto non manifestabile; un “silenzio pubblico” che non si trasforma in possibilità di parola, di partecipazione o conflitto proprio per la difficoltà di contestarlo collettivamente e pubblicamente: d’altronde, sono problemi simili alle relazioni di lavoro nella crisi e nella trasformazione tecnologica, dove è possibile, con il sacrificio dei lavoratori, a bloccare materialmente la logistica; più difficile contestare un sito web o il ricatto dei tagli di fronte a studenti appassionati o in via di fuga, se vi riescono, dall’Italia. E tutto questo racconta di come l’Università si stia trasformando in un’azienda che “produce” competizione e atomizzazione, che poco hanno a che fare con l’insegnamento e con la ricerca come valori primari e sociali. L’alternativa però c’è: svelarne la dimensione culturale dietro la routine tecnica e condividere altri linguaggi se si vuole ricostruire un bene comune e pubblico. Note [1] Mary Strathern, Audit Cultures, Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy, Routledge, London, 2000. [2] Federico Bertoni, Universitaly. La cultura in scatola, Laterza, Roma-Bari 2016. [3] Bertoni ben sintetizza i passi inesorabili di questo processo: 1) Tagliare i finanziamenti pubblici in modo graduale e inesorabile; 2) costringere gli atenei ad autofinanziarsi, senza tenere conto (o forse sì) che certe aree disciplinari e certe zone geografiche sono nettamente svantaggiate; 3) sgretolare di fatto il carattere pubblico, generalista ed egualitario dell’istruzione superiore, quello sancito dalla Costituzione; 3bis) eventualmente varare provvedimenti legislativi che diano una sanzione giuridica a questo processo (trasformare le università in enti privati, abolire il valore legale del titolo di studio, ecc.); 4) introdurre sistemi di valutazione e di ripartizione delle risorse attraverso i quali: a) legittimare i tagli finanziari con la retorica del merito e dell’eccellenza; b) classificare in modo gerarchico le strutture universitarie e i livelli di istruzione, visto che il binomio researching university e teaching university è un eufemismo anglicizzante per dire università di serie A e università di serie B ; c) strozzare, impoverire e infine chiudere sedi giudicate scadenti o marginali, che nella maggior parte dei casi si trovano in “aree depresse” (17) [4] Cris Shore Audit culture and Illiberal Governance, Universities and the Politics of Accountability, in «Anthropology Today», 8, 2008, p. 279. [5]Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis 1996. [6] James C. Scott, Seeing Like a State, Seeing like a state. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press, New Haven/London 1998. [7] Mark Hobart, An Anthropological Critique of Development. The Growth of Ignorance, Routledge, London 1993. [8] Shore, op. cit., p. 283. [9] Susan Groundwater-Smith and Judyth Sachs, The Activist Professional and the Reinstatement of Trust, in «Cambridge Journal of Education», 32, 3, 2002, pp. 341-358. [10] Mary Strathern, op. cit. [11] L’articolo 33 della Costituzione che dice «l’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento». [12] Michael Herzfeld, The Social Production of Indifference, University of Chicago Press, Chicago 1992. [13] Timothy Mitchell, Rule of Experts, Egypt, Technopolitics, Modernity, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 2002. Per approfondire il caso italiano (a cura della redazione): Abramo e D’Angelo 2015: goo.gl/RssvsR Baccini 2010: https://www.mulino.it/isbn/9788815137609 Baccini, Coin e Sirilli 2013: goo.gl/118zTr Borrelli 2015: https://www.ibs.it/contro-ideologia-della-valutazione-anvur-libro-davide-borrelli/e/9788878014817 Cassese 2013: https://www.rivisteweb.it/doi/10.1402/44137 Dal Lago (a cura di) 2013: http://autaut.ilsaggiatore.com/2013/12/360-valutazione/ Turri 2014: http://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538322.2014.889429 Immagine: Johannes Vermeer, Donna con una bilancia (particolare), 1664 circa, olio su tela, Washington, National Gallery of Art.







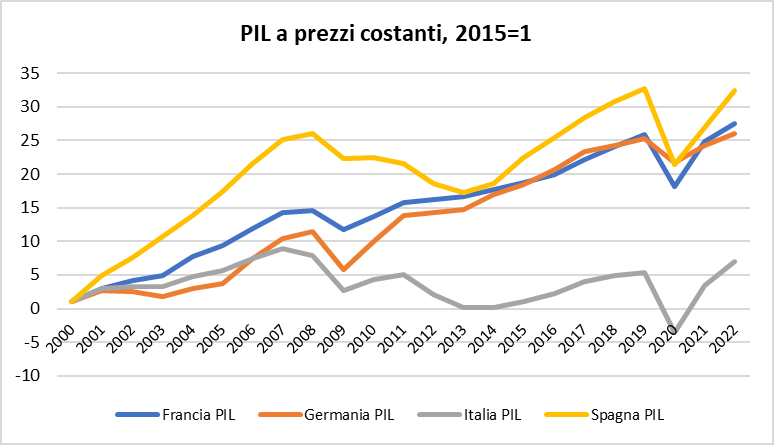
[…] che per necessità riprendo in queste pagine. Tutto ciò attiva “rituali di validazione” [1] e nuove definizioni del lavoro (si “eroga” una lezione, si scrive “un prodotto” o […]
desolato ma confondere audit con valutazione è un errore grossolano che inficia parte delle riflessioni dell’autore. Per distinguere audit da monitoraggio e va valutazione penso che sia sufficiente Wikipedia e non sia necessario leggere dei manuali (peraltro sempre utili quando si trattano materie che hanno una loro storia e spessore)