Una piccola necessaria premessa storica
Il conte Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865-1916) era un dirigente del movimento cattolico, scelto dal pontefice Pio X per dirimere il contrasto fra transigenti e intransigenti. Non vi è dubbio che fosse l’uomo adatto per poter ricucire lo strappo dell’enciclica contro il modernismo; pur se schierato con la fazione che sosteneva il dialogo con lo stato laico italiano Gentiloni era infatti un moderato che garantiva una convinta granitica avversione verso il partito socialista.
Con legge 30 giugno 1912 n. 666 venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile; il corpo elettorale passò dal 7% al 23%, il voto era articolato per collegi uninominali a doppio turno secondo un sistema maggioritario. Era una novità approvata malvolentieri, lasciava ampi margini di incertezza sul responso delle urne. Il ceto politico di governo temeva un possibile successo socialista e l’apparato di comando non intendeva consentire in alcun modo che questo potesse accadere.
Era in vigore il non expedit, la disposizione pontificia che conteneva il divieto (la prohibitio) per i cattolici di ogni partecipazione alla vita politica, come eletti e come elettori. L’astensione di un così ampio blocco conservatore era il rischio che andava rimosso. Il primo ministro Giolitti trovò con Gentiloni l’accordo, e il patto prese il nome di chi lo concluse per conto della Chiesa. Tutti i candidati della lista moderata (laici o cristiani che fossero) dovevano tuttavia sottoscrivere un impegno in sette punti (noto agli storiografi come eptalogo) garantendo opposizione al divorzio nonché ampi privilegi per le congregazioni e gli istituti religiosi d’istruzione privata. Il papa Pio X tolse il divieto in 330 collegi su 508, consentendo al blocco conservatore di sbaragliare i socialisti alle elezioni del 1913. L’apparente stabilità politica prodotta da questo stratagemma, antenato delle larghe intese, non riuscì tuttavia a frenare la crisi dello stato liberale, acuita poi dalla lunga guerra mondiale, con i nuovi equilibri che seguirono e l’affermarsi della dittatura fascista per un ventennio. Era infatti un semplice compromesso dettato dalla paura, privo di sostanza e di progetto; rinviava i problemi senza risolverne alcuno, senza la consapevolezza che stava morendo un’intera società giunta al tramonto.
Il quadro della situazione attuale
Matteo Renzi era convinto di poter rimuovere qualsiasi ostacolo, indotto a ciò dall’indubbia inconsistenza degli avversari. Dopo lo straordinario successo elettorale del 2014 la realizzazione di una svolta autoritaria, tale da assicurare la prevalenza del potere esecutivo, sembrava a portata di mano, in piena sintonia con la costituzione materiale non scritta in vigore nei paesi dell’Unione Europea. Rifiutata ogni mediazione il primo ministro ha giocato la doppia carta della legge elettorale e della riforma costituzionale, invocando l’investitura popolare del referendum.
La sconfitta, imprevista, si è rivelata oltremodo grave per le proporzioni che ha assunto; ma senza una reale elaborazione da parte di chi l’ha subita e con aperto fastidio anzi per le ormai prossime scadenze già in programma. Incombono infatti due incognite, fra loro connesse: la legge elettorale, allo stato ingestibile; i tre referendum sul lavoro promossi dalla Cgil. Il quadro di incertezza rende complicato attendere la fine della legislatura, soprattutto per via delle divisioni interne che caratterizzano le singole fazioni parlamentari. Ancora una volta rimane ferma l’opzione autoritaria per un verso e, contraddittoriamente, il pervicace ricorso al rinvio.
La Corte Costituzionale è da qualche mese priva di un membro; le due camere non sono in grado di nominare il sostituto, ad evitare risse imbarazzanti eludono la questione. Ma proprio sulla Consulta le pressioni si sono fatte quasi febbrili, invocando una soluzione che consenta di disinnescare le mine legate all’esito del voto che ha bocciato le riforme istituzionali. Volevano ridimensionare il ruolo di garanzia della Corte controllando, sul piano politico, le nomine; non ci sono riusciti con le urne e ci provano con la minaccia aperta, per imporre decisioni gradite che indicano apertamente come uniche possibili. Gli attacchi violenti in occasione della (inevitabile) pronunzia che ha cancellato la riforma Madia sono stati, per certi versi, una sorta di avviso ai naviganti. E dentro il collegio dei giudici costituzionali tesse la sua tela filogovernativa Giuliano Amato, inossidabile, inserito in quella posizione da Giorgio Napolitano, il tutore dell’assolutismo.
Puntano ad ottenere, già il 24 gennaio, una correzione della legge elettorale, che elimini il ballottaggio e che sia simile a quella disegnata, sempre con sentenza, per il Senato; dunque un proporzionale con ampia soglia d’ingresso (attualmente 8%).
E vogliono sia dichiarato inammissibile il referendum più spinoso in tema di lavoro, quello relativo all’articolo 18. I giuristi militanti nelle file del partito democratico (Treu, Del Conte, Ichino) hanno provveduto ad elaborare una traccia tecnica che renda possibile questo risultato; è un ragionamento assai poco convincente (la natura sostanzialmente propositiva del quesito sarebbe incompatibile con la natura esclusivamente abrogativa dell’istituto referendario). Ma il problema non sta davvero nell’interpretazione delle norme, è tutto politico. Si chiede alla Corte una scelta di schieramento, avvisandola che una pronunzia sgradita non sarebbe considerata segno di autorevole indipendenza, ma uno strappo, un segnale di aperta ostilità.
Eliminato il primo quesito basterebbe operare qualche mutamento legislativo in tema di voucher e di responsabilità del committente e salterebbe la scadenza referendaria sul lavoro, al completo, con prosecuzione fino al termine naturale della legislatura.
Il nuovo patto Gentiloni
Dopo il referendum occorreva tuttavia, in attesa dei futuri sviluppi, trovare un compromesso che consentisse la sopravvivenza del potere. Trascorso ormai un mese possiamo dare per acquisito che non ci sono state catastrofi, accelerazioni speculative o crisi istituzionali; nel giro di pochissimi giorni, dopo le consultazioni al Quirinale, le due camere hanno confermato la fiducia alla maggioranza sconfitta consentendole di tenere salde in mano le redini del comando.
Non sono mutate le linee guida del governo, e sotto questo profilo risponde al vero affermare che non sia cambiato nulla. Il governo nazionale, del resto, ha il solo compito di eseguire quanto statuito elsewhere, il suo destino si è ormai consumato and now he has stopped hurting. Il processo di trasformazione dello stato in senso autoritario moderno e di sussunzione del precariato dentro le articolazioni lavorative a chiamata non poteva certo arrestarsi a causa del referendum italiano, così come era stato capace di travolgere l’oxi greco nel giugno 2015, piegando le speranze di Tsipras.
Dentro la strategia immutata qualche variazione tattica deve tuttavia essere colta, subito, per comprendere in anticipo quello che ci aspetta nei prossimi mesi, ovvero una pressione fiscale più gravosa e un allargamento ulteriore della forbice che separa la ricchezza dalla povertà. L’apparato di potere ha compreso infatti che sono necessarie, nel contesto attuale, larghe intese politiche capaci di assicurare continuità al processo costituente elaborato al fine di poter mantenere il controllo sul ciclo di accumulazione della ricchezza e di esproprio del modo di produzione fondato sul comune. La posta in gioco è di fondamentale interesse.
Si tratta di spaccare il fronte della variopinta destra italiana, abbandonando al loro destino le ultime schiere del neofascismo nostalgico (i patetici Fratelli d’Italia), i localismi razzisti legati alla crisi industriale del nord, il cattolicesimo integralista della piccola provincia italiana. Si tratta di separare il dialogante governatore lombardo Maroni dal rampante Salvini, il sindacalismo sociale vicino a casa Pound dagli amanti dell’ordine che si annidano nella burocrazia pubblica. Berlusconi ha già tracciato la via.
Sul fronte di sinistra l’operazione appare più semplice, basta tagliare le ali più estreme, recidere i residui rapporti con i movimenti locali di lotta e resistenza, coinvolgere dentro le istituzioni locali, insieme al PD, i sopravvissuti della naufragata esperienza vendoliana.
Quanto ai 5 Stelle, imprevedibilmente cresciuti fino a diventare protagonisti di uno scenario definito tripolare, la soluzione che si profila è quella tradizionale, ovvero la conventio ad escludendum. Nella spartizione delle cariche e dei proventi i pentastellati vanno esclusi dunque da qualsiasi alleanza, collaborazione o partecipazione, confinati, in quanto inaffidabili, nelle sole posizioni senza rilievo. Bisogna dire che i destinatari del disegno concepito a loro danno si prestano assai, per loro storia, a questo destino, testardamente refrattari come sono a qualsiasi variazione di comportamento. Per un verso è la chiave del loro successo, per altro verso li mantiene perennemente sull’argine del fiume da attraversare.
Questo è il contenuto del nuovo patto Gentiloni, come sempre concordato nelle segrete stanze e prudentemente in totale assenza di forma scritta, per non lasciare traccia.
Il nuovo primo ministro (Paolo, nato nel 1954) è un discendente del vecchio conte Vincenzo; ebbe giovanili simpatie per un piccolo partito di sinistra, rapidamente caduto nell’oblio, il Movimento Lavoratori per il Socialismo. Poi con due amici ecologisti, Chicco Testa ed Ermete Realacci, tornò a palazzo; la carriera politica di quest’uomo incolore procede da un quarto di secolo, tranquilla e progressiva, priva di scosse, senza colpi di genio ma senza infortuni. Ha occupato molte posizioni di potere, come il ministero delle comunicazioni o degli affari esteri; e ha sempre cercato di non dare fastidio a nessuno. Nel 2015, sotto la sua direzione della Farnesina, le licenze di esportazione per gli armamenti sono triplicate, da 2,9 fino a 8,2 miliardi di euro, una cifra record nel secondo dopoguerra.
Gentiloni il piccolo (secondo la definizione di Victor Hugo) è sembrato a tutti quanti la persona adatta, l’unica capace di garantire la sostanza dell’accordo.
Matteo Renzi ha ottenuto la conferma della sua pattuglia di fedeli, dirigendo al tempo stesso il partito di maggioranza e gran parte dell’apparato di governo, in attesa della rivincita. Silvio Berlusconi è rientrato di fatto nella stanza dei bottoni, liberandosi della scomoda obbligata compagnia leghista e ricucendo i legami con i faccendieri del centro-destra. Le banche hanno ottenuto quanto desideravano; le imprese sono riuscite ad imporre la centralità dell’impegno a disinnescare gli effetti dei tre referendum sul lavoro. La cabina europea di comando ha in mano le redini di controllo, anche se rimane comunque vigile e attenta di fronte al dipanarsi della vicenda italiana.
Quale che sia la legge elettorale (o tracciata dalla Consulta o alla peggio cucita in accordo con Berlusconi) la prossima legislatura – e anche questa, naturalmente – sarà contrassegnata da larghe intese. Il Partito Democratico e Forza Italia si preparano a convivere, secondo gli equilibri tracciati dal voto, dentro le scadenze già fissate nel programma europeo. Garantiranno i costi delle grandi opere e delle spese di guerra, i trattati contro l’ambiente e l’alimentazione; procederanno spediti, e se occorre violenti, sulla via del sequestro di sapere, risorse, di ogni elemento comune. Perché è proprio il comune quello che percepiscono come principale nemico, l’avversario da piegare. Il patto Gentiloni si pone, in apparenza, contro il cosiddetto populismo ma mira, nella realtà, a rendere la condizione precaria un dato definitivo, incontestabile. Il moderno contratto sociale prevede la cessione dell’intero tempo di vita in attesa di frammentarie chiamate al lavoro, chiave necessaria di accesso al reddito, ma senza garanzie e senza diritti. Nasce una nuova forma di assolutismo, con la maschera della vecchia democrazia, ma fondato sull’imposizione da parte dell’autorità sopranazionale; quello che andiamo chiamando autoritarismo. Senza prevaricazione e senza l’uso della forza repressiva, del resto, nessuno accetterebbe le clausole oggi imposte dal potere; lo spettro della crisi, la paura degli attentati, il timore del diverso sono certamente strumenti di governo sapientemente utilizzati, ma da soli non basterebbero e per questo serve un esecutivo capace di impedire ogni forma di concreta opposizione. Juan José Linz Storch de Gracia (1926-2013) ha ben delineato le possibili forme moderne dello stato autoritario, cogliendone l’essenza proprio nella riduzione o limitazione programmatica del pluralismo; i poteri sono volutamente mal definiti, pur essendo al tempo stesso prevedibili, in assenza di valori fondanti alla base delle azioni (si veda il numero 57, monografico, della rivista Trasgressioni, uscito nel 2013).
L’opzione autoritaria. Un processo costituente del capitalismo finanziarizzato. Il caso del C.N.E.L.
In occasione del referendum costituzionale, fra le varie norme modificative della Carta, compariva la soppressione del C.N.E.L. Il clamoroso NO uscito dalle urne ha salvato questo misterioso organismo che pure nessuno si era preso la briga di difendere e che tuttavia è quasi miracolosamente sopravvissuto. Vale la pena di approfondire l’intera vicenda, in quanto, a modo suo, davvero significativa ed emblematica.
Il titolo III (parte seconda) della Carta regola l’attività di governo; tre sono gli organi ausiliari dell’esecutivo e della pubblica amministrazione (oggetto dei primi due titoli): la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e, appunto, il nostro Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (il C.N.E.L., disciplinato dall’articolo 99, in pieno vigore, mai abrogato). Secondo la Costituzione deve essere composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, tenendo conto dell’importanza numerica e qualitativa. Il primo comma impone sia alle Camere sia al Governo di avvalersi dell’attività di consulenza del CNEL; facoltativa è invece la possibilità (può) di contribuire mediante proposte di legge a costruire l’assetto normativo nei settori economici e sociali. Un giurista insigne, Livio Paladin (1933-2000), presidente della Consulta, aveva ben chiarito nei suoi saggi come il compito di attivare le funzioni del CNEL spettasse dunque, istituzionalmente, alle due Camere e al Governo. La nota riveste notevole importanza, posto che, in luogo di rendere l’organismo efficace, l’esecutivo di Matteo Renzi lo ha coscientemente paralizzato, con la complicità del Quirinale. Vedremo come questo rientri nel generale disegno autoritario di modifica per fatti concludenti del diritto positivo (una impropria costituzione materiale che ha stravolto il tradizionale stato di diritto delineato dopo la caduta del fascismo).
L’attuazione in concreto del CNEL richiese un certo lasso di tempo, come del resto era già avvenuto per la Consulta; solo nel 1957 entrarono infatti in vigore le regole di funzionamento, poi modificate significativamente nel 1987 (legge 936) e solo ritoccate con le correzioni inserite nel 2011.
Il primo presidente, assai autorevole, fu Meuccio Ruini (1877-1970), che già aveva diretto la commissione dei 75 incaricata di redigere il testo della Costituzione e successivamente il Consiglio di Stato (il suo capo di gabinetto era un allora giovanissimo Federico Caffè, figura ben nota agli economisti). Negli ultimi dieci anni del secolo scorso al vertice del CNEL si insediò il fondatore del CENSIS, Giuseppe De Rita, segno sicuro dell’importanza attribuita al Consiglio dal ceto politico italiano.
Secondo le norme confermate con il voto referendario (e mai venute comunque meno) i membri del CNEL debbono essere 64: 10 esperti (8 nominati dal Presidente della repubblica e 2 dal Presidente del consiglio dei Ministri), 22 rappresentanti del lavoro dipendente, 9 del lavoro autonomo, 17 dell’imprenditoria, 6 del volontariato. Il Presidente della Repubblica ha anche il compito (un vero e proprio atto dovuto) di mettere a capo dell’organo costituzionale di governo un Presidente scelto al di fuori del Consiglio, su proposta formale del Consiglio dei Ministri e a mezzo di apposito decreto (D.P.R.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ogni tornata del Consiglio ha durata quinquennale; l’ultima è giunta alla sua conclusione da molti mesi, il 15 luglio 2015. Violando la legge e la Carta il governo Renzi ha introdotto a mezzo di decreti il Jobs Act, modificando in forme radicali il diritto del lavoro vigente senza richiedere alcun parere al CNEL (articoli 10 e 11 L. 936/87) che avrebbe avuto l’obbligo di consegnarlo. In luogo della richiesta al CNEL l’esecutivo ha utilizzato un organismo non previsto dalla Carta, nominato direttamente dal primo ministro al di fuori di qualsiasi regola o controllo; del resto anche il parlamento era stato eletto a mezzo di norme dichiarate contrarie alla nostra Costituzione.
La scadenza del CNEL è indipendente dal corso della legislatura, le modalità di rinnovo sono automatiche e rappresentano un obbligo istituzionale, obbligo apertamente violato con un comportamento omissivo che si concreta in aperta ribellione. L’articolo 4 della legge 936/87 dispone che nove mesi prima della scadenza (nel nostro caso dunque entro ottobre 2014) il primo ministro proceda a pubblicare in Gazzetta Ufficiale l’avviso con indicazione alle organizzazioni sociali nazionali di trasmettere le proposte nominative per la composizione del nuovo consiglio. Concluso la procedura (in contraddittorio con le parti sociali) il Presidente della Repubblica pubblica la composizione e l’organismo si mette al lavoro.
Per evitare un dibattito ampio e sgradito dentro una struttura comunque articolata e pluralistica Renzi e Napolitano hanno omesso di avviare la procedura di rinnovo, di fatto cancellando un organo costituzionale di governo. Lo hanno sostituito con esperti di univoca provenienza governativa, in accordo con la sola componente imprenditoriale.
Le più alte cariche dello Stato hanno dunque modificato la costituzione materiale con un vero e proprio processo autoritario costituente. E lo hanno fatto contestualmente alla radicale modifica della legislazione giuslavoristica italiana, mediante leggi delega e successivi decreti applicativi, al di fuori di qualsiasi programma elettorale, in contrasto con il meccanismo delineato nel 1948 e secondo le direttive della ormai famosa lettera d’indirizzo elaborata nelle segrete stanze dei palazzi europei (ancora una volta elsewhere).
Non è cosa di poco conto quella che è avvenuta. In luogo di procedere al rinnovo del CNEL la maggioranza (PD e centrodestra) ha lasciato scadere il quinquennio, non ha sostituito l’ultimo Presidente (Marzano, ex ministro di Berlusconi), non ha sostituito i membri (ne sono rimasti 24 su 64), non ha tenuto in alcun conto di alcune revoche intervenute, ha sospeso l’indennità in favore dei componenti. Dal 16 luglio 2015 il CNEL opera in regime di prorogatio; ma anche questa è una modifica per fatti concludenti che si pone in contrasto con le norme vigenti e rappresenta una ulteriore prevaricazione autoritaria. La legge istitutiva, infatti, non prevede e di conseguenza non disciplina la prorogatio, che si concreta dunque in un illecito, in un’operazione politica a carattere eversivo.
L’articolo 99 della Costituzione era stato abrogato da Renzi e Napolitano ben prima di chiedere mediante referendum la soppressione dell’organismo; mentendo come di consueto gli autori dell’operazione si sono premurati di addebitare il mancato funzionamento, che avevano scientificamente determinato, al CNEL in quanto tale. La giustificazione fornita sui mezzi di stampa è tipica di questa nuova forma di autoritarismo: l’abbattimento della spesa pubblica e lo snellimento della burocrazia. Il movente è diverso, ma chiaro: accelerare senza ostacoli il processo di sussunzione e rimuovere qualsiasi forma di pluralismo politico-sociale concentrando il potere sulle sole strutture dell’esecutivo.
Significativa ci pare la concordanza di vedute in tema di CNEL fra maggioranza e opposizione. Tutti d’accordo nell’attaccare l’organismo come inutile e inutilmente costoso; nessuno che si sia posto il problema di condurlo o ricondurlo alla funzione originaria, di assicurare un corretto procedimento di rappresentanza anche al precariato e all’immigrazione, alla ricerca universitaria e al lavoro cognitivo. Il rilievo è importante, ma, va detto, non è questo il punto.
Il vero nodo sta nel metodo utilizzato e questo metodo riteniamo costituisca una scelta irreversibile del potere attualmente dominante, è la colonna portante del nuovo patto Gentiloni che dopo la tornata referendaria le due componenti delle larghe intese (Partito Democratico e Forza Italia) intendono utilizzare per mantenere il controllo (la governance) sulla società complessiva, proseguendo lungo la via imposta dalle strutture capitalistiche finanziarizzate e dal mercato dei beni immateriali.
Con la legge di stabilità 2015 risultano cancellate le indennità riservate ai consiglieri sopravvissuti, e già nel 2013 il garante Napolitano aveva rivendicato, in spregio al giuramento, la soppressione del CNEL. Si consideri che nessuno dei 14 disegni di legge elaborati dal CNEL è mai stato esaminato dalle due Camere, che hanno altresì omesso perfino di richiedere il parere e di utilizzare la banca dati (articolo 17 della legge istitutiva). Il metodo risulta essere dunque lo stesso applicato in Grecia e in Francia al fine di eliminare ogni possibile opposizione al nuovo ordine europeo, ovvero quello di piegare le norme di diritto vigente (anche quelle di rango costituzionale) alle necessità del ciclo di estrazione finanziarizzata della ricchezza. Prima hanno cancellato una struttura che rischiava di rallentare il processo di precarizzazione forzata della forza lavoro italiana, dopo hanno approvato la norma che ratificava quanto avvenuto, modificando a posteriori la Costituzione. Il voto referendario è stato solo un intoppo imprevisto, la marcia verso l’organizzazione autoritaria procede e si avvale, appunto, delle larghe intese di cui il nuovo patto Gentiloni è una matura espressione.
Basti vedere con quanta arroganza hanno accolto l’esito del referendum popolare; il CNEL continua ad essere composto da 24 consiglieri sopravvissuti e diretto da tale Napoleone (non è uno scherzo, si chiama proprio così), un imprenditore abruzzese laureato in farmacia, indicato da Confindustria. Non si registrano segnali di intervento istituzionale, tace Gentiloni e con lui tace Mattarella (il che non stupisce, ci vorrebbe Crozza per rappresentare il loro silenzio omissivo). La continuità nell’abrogazione di fatto, nel rispetto del comportamento attuato in precedenza da Renzi e Napolitano, rafforza la linea golpista che i due avevano indicato senza incertezze. A quanto pare del voto popolare il governo autoritario delle larghe intese sembra non tenere conto alcuno, come se non fosse mai avvenuto; come prima era avvenuto per quello sull’acqua pubblica.
Renzi, Napolitano, Mattarella e Gentiloni stanno interrompendo non solo un pubblico servizio (come si imputa ai militanti del movimento NO TAV), ma un organo costituzionale di governo, impedendone da 18 mesi, in concorso fra loro, il funzionamento. La magistratura inquirente, così sollecita nell’intervenire contro gli oppositori dell’Alta Velocità, potrebbe aprire un procedimento penale volto a porre argine a questo sconcio.
Ma non ci contiamo affatto. Sappiamo bene che questa violazione delle norme altro non è che esercizio del potere, attività moderna di governo. La repressione delle manifestazioni popolari in Val di Susa è strettamente, organicamente, legata all’impunità per chi blocca il funzionamento dell’organo costituzionale previsto dall’art. 99 e confermato da referendum. Sono articolazioni dell’autoritarismo. E questo metodo è il punto.
Questo metodo, autoritario e spregiudicato, è un elemento istituzionale dell’attuale compagine di governo. Non ha nulla a che vedere con il fascismo storico e neppure, a ben vedere, con il liberalismo repressivo del secondo dopoguerra; è un fenomeno che nasce dentro il villaggio globale, sulle ceneri degli stati nazionali, lungo quella linea d’ombra che separa la finanza dal territorio, senza ideologia, senza morale, perfino senza sogni o promesse. Le caratteristiche di questo nuovo autoritarismo sono ancora da comprendere appieno, presupposto questo assolutamente indispensabile per poterlo combattere; anche se non abbiamo dunque una formula che mondi possa aprirti esiste già la fiera consapevolezza che questo è l’avversario da battere per chi aspiri all’emancipazione.
Immagine in apertura: Charlie Chaplin “Il grande dittatore”, 1940


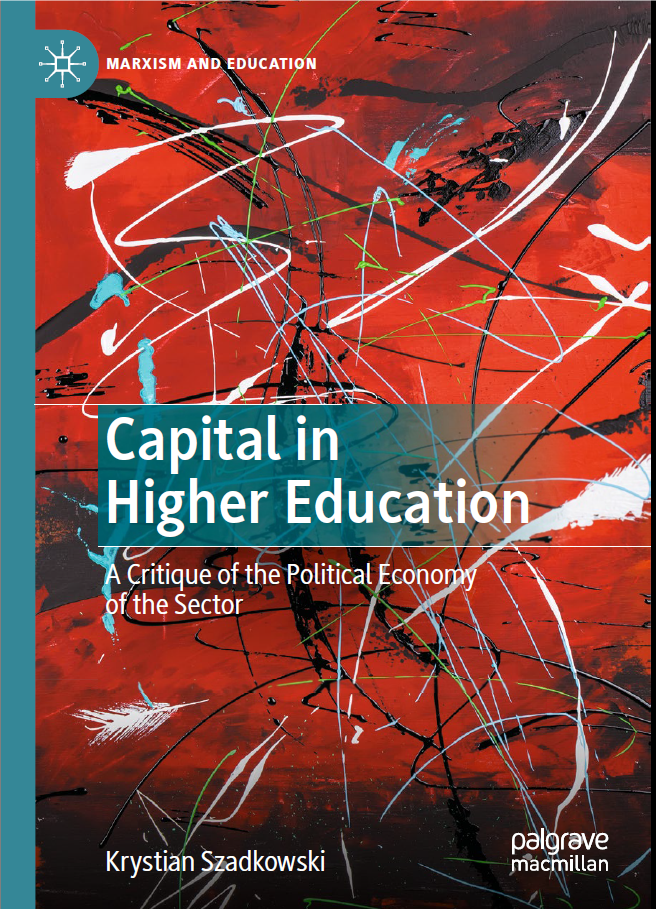





Grazie per questa lezione articolata e precisa di scienza politica. Ma non sarebbe possibile fare un dibattito a Napoli dove, una consapevolezza sulla necessità di resistenza della categoria “comune” da Lei scientemene delineata, sembra oggi possibile ricreare uno spazio fondante seppur disordinati ma realisticamente espressione di istanzè di precariato e povertà. Mi scuso se non sono stata all’altezza di poter commentare ma leggo tutti i vostri articoli da un bel po’ e cerco di resistere ogni giorno alla pratica di morte per sussunzone di materia grigia a cui siamo sottoposti qui.
Grazie buona vita
L’immagine che correda il pezzo è fuorviante, non la dittatura ma l’autoritarismo è l’argomento. La distinzione è importante perché in molti scrutano l’orizzonte per vedere segni di dittatura mentre già nuotano nel mare tiepido dell’autoritarismo.
[…] Non è una pronunzia di poco rilievo; è piuttosto la conferma di una svolta violentemente autoritaria che viene imposta all’intero paese. Non nascondiamocelo, sarebbe sciocco. Questa è una ferita consapevolmente inferta ai diritti residui, l’imposizione delle direttive provenienti dal complessivo governo europeo. Ci spiace, ma non ci sorprende; lo avevamo messo in conto. […]