Dopo un lungo sonno, dovuto a decenni di stagnazione economica, a dinamiche assai contenute della domanda aggregata e a periodi di stringente moderazione salariale, l’inflazione ha rialzato la testa negli ultimi due anni e la sua analisi è ritornata al centro del dibattito economico-politico. Ne fa fede anche il recente libro collettaneo “L’inflazione. Falsi miti e conflitto distributivo” con interventi di Giacomo Cucignatto, Lorenzo Esposito, Demostenes Floros, Matteo Gaddi, Nadia Garbellini, Roberto Lampa, Gianmarco Oro, Stan De Spiegelaere, introduzione di Joseph Halevi, pubblicato dalle Edizioni Punto Rosso (2023, pp. 202, Euro 18)
Si tratta di un libro importante, se non altro perché ha il merito di fare chiarezza sul tema, con lo scopo di individuare quelle che sono oggi le cause dell’aumento dei prezzi, fuoriuscendo dalla retorica mainstream, secondo la quale l’inflazione è causata o da un eccesso di moneta o da un insopportabile aumento dei salari.
Il primo capitolo del libro, redatto da Roberto Lampa e Gianmarco Oro (“Una rilettura critica della teoria quantitativa della moneta”), discute della validità oggi della teoria quantitativa della moneta, che sta alla base della credenza (in quanto non suffragata da dati empirici, se non tramite un’illusione ottica[1]) che sia l’aumento della quantità di moneta a essere la causa principale dell’inflazione. Un aumento dell’offerta di moneta (politica monetaria espansiva o, come si dice oggi, quantitative easing) avrebbe lo scopo di sostenere la domanda aggregata e creare occupazione ma invece, essendo il libero mercato in grado di raggiungere un equilibrio ottimale senza alcun intervento discrezionale di supporto, si traduce solo in un aumento dei prezzi. La moneta è così una variabile non solo esogenamente determinata dal regime di monopolio di emissione detenuto dalla Banca Centrale ma anche perfettamente neutrale, non potendo alterare le variabili reali del sistema economico. Purtroppo la credenza che il sistema di mercato sia in grado di raggiungere in modo autonomo un equilibrio ottimale (ossia in grado di garantire anche la piena occupazione) è, appunto, un’illusione. In un sistema capitalistico, ovvero in un’economia monetaria di produzione (business economy nelle parole di Keynes) e non in un’economia di scambio (barter economy, sempre secondo Keynes), la moneta è la variabile chiave che influenza le scelte di investimento che stanno alla base del processo di accumulazione. I prezzi intervengono nella sfera della distribuzione del reddito alterando il rapporto tra capitale e lavoro e la loro dinamica tende a essere dipendente dalla dinamica del conflitto in corso. Altro che neutralità.
In un’economia monetaria di produzione, la funzione creditizia è centrale e disvela il rapporto sociale che la moneta governa. Di conseguenza la moneta non può essere neutrale e l’aumento dei prezzi potrebbe essere innescato dalla recrudescenza del conflitto sociale in mercati non concorrenziali, dove il prezzo, lungi dall’essere determinato dalla legge della domanda e dell’offerta, è invece influenzato dalla dinamica dei costi e in particolar modo dai salari. Nell’attuale economia finanziaria di produzione, dove l’oligarchia finanziaria gestisce direttamente il processo di accumulazione e distribuzione del reddito, la validità della teoria quantitativa della moneta ha ancora meno senso. In questo contesto, come hanno ampiamento dimostrato le politiche monetarie di quantitative easing nel periodo post crisi del 2007-08, la creazione di moneta non ha portato all’aumento dei prezzi, che sono rimasti stabili o sono addirittura diminuiti in seguito a shock recessivi sulla domanda (grazie alle politiche di austerità europee e poi al lockdown dovuto alla sindemia da Covid-19) ma è servita a coprire i buchi patrimoniali delle banche e ad alimentare la tenuta dei mercati finanziari speculativi.
I due contributi seguenti (“Il controllo dei prezzi: uno strumento chiave in difesa dei salari” di Giacomo Cucignatto e “Gli indici dei prezzi al consumo” di Nadia Garbellini) affrontano due questioni centrali quando si parla di inflazione. Cucignatto discute della necessità di sviluppare politiche di controllo dei prezzi, almeno di quelli più nevralgici, come quelli energetici. Si tratta di un provvedimento più che mai necessario quando l’inflazione ha origini da fattori temporanei (fiammata dei prezzi energetici, alimentata da fattori speculativi e aumento dei costi della logistica, in seguito alla rapida ripresa della domanda nel periodo post-covid) e non da logiche reali di mercato. In nome di un supposto liberismo, il pensiero mainstream si è sempre opposto a tali misure, anche di fronte a chiare rendite di posizione in mercati tendenzialmente monopolistici. Nelle realtà della politica economica, invece si è potuto osservare come soprattutto in Cina e negli Usa, il governo abbia intrapreso politiche più drastiche di controllo dei prezzi, anche se, negli Usa, sono state accompagnate da politiche monetarie restrittive. In Europa e in Italia è stata invece utilizzata la leva fiscale. In particolare in Italia, rileva Cucignatto, tale leva “è stata utilizzata in maniera significativa per contenere la corsa dei prezzi energetici nel corso del 2021-2022. Nel biennio considerato, il governo ha destinato circa 62 miliardi di euro lordi (3,3% del Pil) per mitigare l’effetto dell’inflazione su famiglie e imprese. Tra le misure più rilevanti, nel 2022 troviamo:
- crediti d’imposta per le imprese a compensazione degli extra costi sostenuti per l’acquisto di energia o gas naturale (18,3 miliardi (1% del Pil);
- contenimento dei costi in bolletta per famiglie e imprese per 14 miliardi (0,8%)
- riduzione accise sui carburanti per 7,7 miliardi (0,4%)
- bonus sociali per utenze energia e gas per 2,8 miliardi (0,15%)” (p. 20).
Si tratta tuttavia di misure transitorie, perché non strutturalmente sostenibili in tempi di ristrettezze di bilancio (come, in effetti, è già avvenuto con il mancato rinnovo della riduzione dell’accise sui carburanti), i cui costi sono comunque a carico dell’intera collettività e non di chi approfitta dell’aumento dei prezzi. Inutile dire che il motivo principale per introdurre misure per il controllo dei prezzi dovrebbe soprattutto essere contrastare il calo del potere d’acquisto dei redditi da lavoro. Ma in Italia, c’è scarsa attenzione a tutto ciò, visto lo storytelling dominante che parla solo delle difficoltà delle imprese.
Nadia Garbellini, con un intervento tecnico molto puntuale, chiarisce il metodo di calcolo del tasso di inflazione e le sue lacune (ovvero la sua non neutralità). Senza entrare in dettagli per addetti ai lavori, ad oggi il tasso di inflazione viene calcolato utilizzando tre indici: NIC (indice per l’intera collettività nazionale), FOI (indice per le famiglie di operai e impiegati) e IPCA (indice armonizzato europeo). Ciascuno di questi indici viene utilizzato come parametro di adeguamento di diversi provvedimenti di politica sociale ed economica. In tutti e tre i casi, rilevazioni e metodologia di calcolo coincidono; a cambiare è la popolazione di riferimento, il paniere (cioè i beni e servizi considerati) o i relativi pesi. Occorre considerare che l’elemento cruciale della procedura di calcolo dell’inflazione è proprio la determinazione dei pesi: attribuire pesi maggiori ai beni e servizi il cui prezzo cresce di più implica ottenere un tasso di inflazione più elevato.
Ai tre indici menzionati, occorre aggiungerne un quarto, di estrema rilevanza per la contrattazione collettiva in quanto segna il livello di riferimento per le richieste sindacali di adeguamento dei salari per il rinnovo contrattuale: l’indice IPCA depurato dei beni energetici. A differenza degli altri, per il calcolo di tale indice “si deve quindi procedere necessariamente attraverso stime e approssimazioni” (p. 36). Detto in altre parole, tale calcolo è tutt’altro che oggettivo e infatti non stupisce che su di esso divampa il confronto: “poiché è questo l’indice su cui si basa la contrattazione, sarà interesse dei sindacati che la componente da scorporare (cioè la quota dei rialzi non assorbita dai salari) sia piccola; viceversa, alle organizzazioni datoriali farà comodo scorporare una componente maggiore” (p. 40).
Il contributo di Nadia Garbellini apre ai due articoli di Matteo Gaddi che trattano del tema dei meccanismi di indicizzazione dei salari e della scala mobile. Sono temi che sembrano essere usciti dalla preistoria ma che si rivelano invece di strettissima attualità. Nel primo articolo, Gaddi analizza i diversi aspetti dell’indicizzazione dei salari e rileva come il punto unico di contingenza favorisca, al netto dei rinnovi contrattuali dei diversi livelli retributivi, una riduzione del gap salariale tra chi viene meglio retribuito e chi meno. Checché se ne possa dire, si tratta di un fenomeno che presenta elementi di positività e equità, dato che l’aumento dei prezzi è uguale per tutti e che eventuali divari retributivi a seconda delle mansioni svolte non dovrebbe essere regolato dall’indicizzazione dei salari ma dalla capacità contrattuale. In assenza dell’indicizzazione, i divari salariali sono non a caso aumentati esponenzialmente. In secondo luogo, occorre rilevare come la “la tenuta del salario reale sia fortemente legata alla frequenza del meccanismo di indicizzazione del salario alle variazioni del livello dei prezzi” (p. 53). In ogni caso “nessun meccanismo di indicizzazione, per quanto frequente, consente di adeguare pienamente il salario all’andamento dei prezzi. Anche nel caso dell’indicizzazione mensile, infatti, l’adeguamento avviene nel mese successivo a quello in cui si è verificata la crescita dei prezzi. Qualsiasi sistema di scala mobile, quindi, per quanto possa essere frequente l’indicizzazione salariale, non consente mai un pieno recupero del potere d’acquisto” (p. 54).
Nel capitolo sulla scala mobile Gaddi ripercorre la storia degli accordi sindacali tesi a recuperare il potere d’acquisto perso in seguito all’aumento dei prezzi. È una storia poco nota, dal momento che tutti ricordano la scala mobile degli anni ’70 (anche se le nuove generazioni precarie non sanno neanche di che cosa si tratti) ma pochi sanno che nel 1951 e nel 1957 sono stati siglati accordi a tutela del potere d’acquisto salariale. Con tali accordi, i salari sono stati al passo dell’inflazione ma non a quello della produttività, con conseguente declino del salario relativo, che è la vera e unica misura della distribuzione del reddito tra salari e profitti. Con l’accordo del 1975 tra Agnelli e Lama, la scala mobile viene riveduta con un grado di copertura del 100%, che poi, nella realtà, non era tale, sia per le diverse modalità di calcolo tra i settori che per l’effetto del fiscal drag. Il dibattito sul tema ha innervato la fine degli anni Settanta e il testo di Gaddi lo riporta interamente. Non abbiamo qui lo spazio per approfondirlo, ma si tratta di un capitolo fondamentale, anche per capire il processo di smantellamento della scala mobile a partire dal decreto di San Valentino del Governo Craxi nel 1984. Non è altro che l’esito della sconfitta operaia seguita ai 40 giorni della Fiat nel 1980. Da quel momento, comincia il declino salariale in Italia, un declino che anche negli ultimi trent’anni, in presenza di bassa inflazione, non si è arrestato, al punto che i salari italiani sono fra gli ultimi in Europa e non solo sono fermi ma, anzi, sono diminuiti negli ultimi 30 anni. Sono più bassi del 12% rispetto al 2008 in termini reali, secondo i dati del Global Wage Report 2022-2023 presentato oggi dall’Ilo, Organizzazione internazionale del Lavoro.
Sempre Matteo Gaddi, nel capitolo seguente (“Contrattazione collettiva e inflazione: dall’inflazione programmata all’IPCA depurato) presenta l’accordo di fine luglio 1993 che dopo l’eliminazione della scala mobile (pur depotenziata) sancita nell’anno precedente, presenta il nuovo modello di difesa dei salari dall’inflazione. Gaddi analizza anche i vari rinnovi contrattuali che si sono succeduti sino ai nostri giorni. Il criterio principale è che l’eventuale recupero del potere d’acquisto dall’erosione inflazionistica avviene prendendo come riferimento il tasso di inflazione programmato, sancito unilateralmente dal governo sulla base del documento di economia e finanza (solitamente più basso di quello reale). Eventuali discrepanze possono essere recuperate dopo due anni. Si tratta di un cambiamento di metodologia assai rilevante, che forse doveva essere meglio sottolineato. Di fatto, gli aumenti salariali non sono più l’esito di una libera contrattazione tra le parti, da fissare sulla base dei rapporti di forza esistenti, ma sono vincolati ad un tetto massimo prefissato. È un vulnus che depotenzia alla base la capacità contrattuale dei sindacati e non a caso ha come esito il mancato recupero salariale (ben evidenziato da Gaddi con numerosi dati) e il declino della stessa contrattazione collettiva. Nelle intenzioni sindacali, tale minor capacità contrattuale doveva essere compensata dalla contrattazione aziendale di II livello, che, però, tranne poche eccezioni, non è mai decollata. Oltre a tirarsi la zappa sui piedi, tale situazione ha portato anche a crescenti divisioni nella strategia contrattuale tra i tre sindacati principali, come rileva Gaddi a proposito del rinnovo contrattuale dei metalmeccanici del 2009 dopo la decisione unilaterale della Uilm e della Fim-Cisl di disdettare l’accordo precedente del 2008.
Dopo aver ripercorso la storia della contrattazione sindacale dal dopoguerra ad oggi e evidenziato le problematiche teorico-statistiche nel calcolo del tasso d’inflazione, l’ultima parte del libro è dedicata a analizzare le cause dell’inflazione contemporanea (“Alcune note sull’inflazione e le imprese” di Lorenzo Esposito e Matteo Gaddi). Grazie all’analisi dei dati relativi ai bilanci delle imprese, nel corso del 2022, anno in cui l’inflazione ha toccato i valori massimi, si può evincere che il mark-up delle imprese non solo non è calato ma in molti casi è aumentato. Contemporaneamente, la dinamica salariale ha rilevato una pesante contrazione in termini di potere d’acquisto. Possiamo affermare che la causa di tale processo redistributivo dei redditi a favore dei profitti è imputabile principalmente al fatto che l’aumento dei prezzi delle componenti non salariali (energia e logistica, in primo luogo) si è immediatamente tradotto in un aumento dei prezzi finali mentre non è avvenuto il contrario: quando i prezzi, soprattutto energetici, hanno cominciato a calare i prezzi non sono immediatamente calati ma si è verificato una sorta di inerzia dell’inflazione. Solo a mesi di distanza, i prezzi oggi cominciano a ridursi, ma in ogni caso in maniera meno che proporzionale. Si tratta di una dinamica che è usuale per i prezzi dei prodotti energetici (quando il petrolio aumenta di prezzo, immediatamente i prezzi alle pompe di benzina si adeguano mentre tale adeguamento non avviene o è molto più lento nel caso contrario) e che oggi si è esteso a tutti i comparti. A differenza dell’inflazione degli anni Settanta, causata dall’aumento dei costi di produzione, in particolare di quelli salariali (la nota spirale salari-prezzi), l’inflazione di oggi è invece spiegata dal mantenimento di alti livelli di mark-up anche quando i costi non salariali tendono a ridursi. Si tratta quindi di un’inflazione da profitti. Non c’è nulla di strano in tutto ciò. Come ricordano gli autori, sono le imprese che fanno i prezzi e lucrano sull’eventuale esistenza di rendite di posizione o su strategie collusive. È il capitalismo, bellezza!
Eppure tale ovvietà fa fatica a essere accettata. Il pensiero mainstream fa sempre riferimento al rischio di una spirale “salari-prezzi” – in base alla quale l’ossessione dei sindacati di difendere i salari reali condanna il paese a una progressiva crescita dei prezzi. In questa narrazione, “non vale il discorso, che parrebbe di buon senso, che l’aumento dei salari viene dopo quello dei prezzi e non ne può dunque essere la causa” (p. 149). Tuttavia, il pensiero mainstream non può affermare che oggi siamo in tempi di forti incrementi salariali, anzi la realtà sembra andare in una direzione opposta. Ecco allora, che, con un colpo di bacchetta magica, si fa notare che sono le aspettative future a determinare i prezzi del presente. Sarcasticamente, scrivono Esposito e Gaddi: “Le imprese si aspettano che i salari aumentino (per recuperare la perdita di oggi del potere d’acquisto, ndr.) e quindi aumentano i prezzi da subito. In questo modo, aumenti salariali futuri possono determinare aumenti dei prezzi precedenti, un ragionamento che ricorda la logica che il lupo usa per sbranare l’agnello nella nota favola di Fedro ma che ha fruttato premi Nobel e carriere prestigiose a chi l’ha ideato” (p. 150).
Se non sono i salari di oggi a causare l’inflazione, lo saranno i salari futuri. In ogni caso è sempre colpa del lavoro e dei lavoratori: cornuti e mazziati.
Il libro presenta poi altri contributi. Il primo (di Lorenzo Esposito, Roberto Lampa, Gianmarco Oro) analizza 50 anni di politiche monetarie della Banca Centrale nel contrastare l’inflazione. Al riguardo, ricordiamo che il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, se nelle “considerazioni finali” presentate alla tradizionale assemblea nazionale del 31 maggio scorso ha sostenuto l’utilità del salario minimo, in interventi precedenti si era espresso contro la necessità di adeguare i salari all’aumento dei prezzi, proprio per non incorrere nel rischio di alimentare la spirale “salari-prezzi”. Il secondo (di Stan De Spiegelaere) invece fa una panoramica degli aumenti salariali automatici nei contratti collettivi in Europa.
In conclusione, siamo di fronte ad un libro ampio, rigoroso e ben strutturato, in grado di mostrare come in Italia le politiche di controllo dei prezzi sono a carico dell’intera collettività (leva fiscale) mentre i guadagni solo esclusivamente ad appannaggio dei profitti. Vengono così confermate le profonde iniquità dell’attuale sistema economico: iniquità che possono essere solo alleviate dalla ripresa di un sano conflitto sociale.
* * * * *
NOTE
[1] Milton Friedman ha scritto una ponderosa opera sulla storia della politica monetaria statunitense per sostenere tali tesi, guadagnando pure il Nobel per l’economia nel 1976.


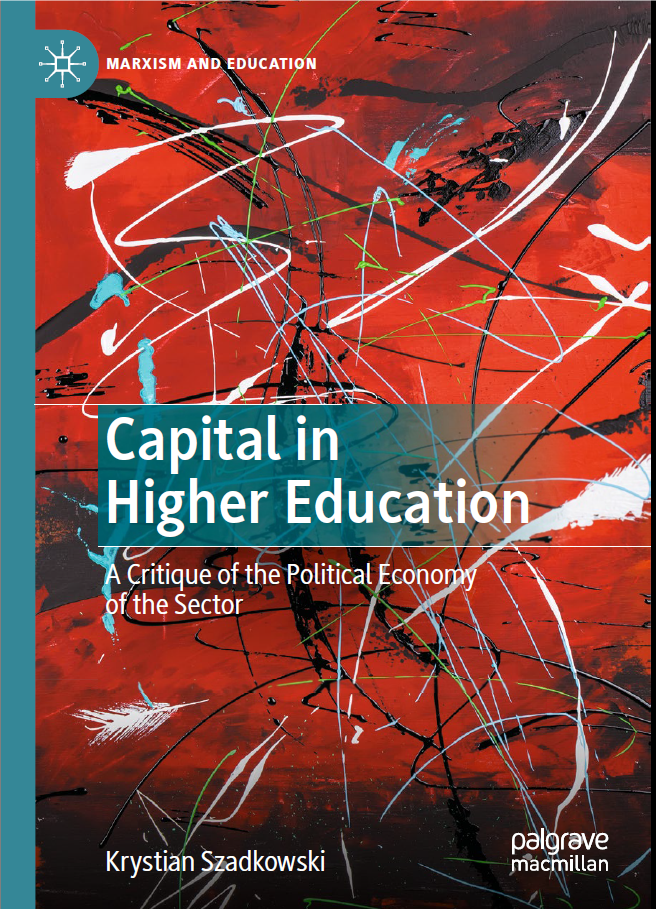





Scrivi un commento