Non si può tacere davanti a una guerra, a qualsiasi guerra, perché la pace, la libertà, l’uguaglianza non si raggiungono con gli eserciti, ma attraverso le piazze. Ritornare sui passi di Mussolini e prima ancora di Giolitti ha ben altre finalità: mettere le mani sui giacimenti energetici nel paese nordafricano e garantire l’attività di quelle compagnie petrolifere europee e americane che già operano sull’altra sponda del Mediterraneo. In questo contesto, il Daesh è solo l’ennesimo ‘nemico utile’ per fare quello che l’Europa ha sempre fatto: la guerra al resto del mondo.
Non si può tacere perché sotto quelle bombe moriranno soprattutto civili, uomini, donne e bambini sacrificati sull’altare della “democrazia” europea: quella che costruisce muri ai confini del Vecchio Continente, che richiude esseri umani in campi di concentramento, che espelle chi fugge dalle guerre e seleziona coloro che possono divenire materiale buono per lo sfruttamento del mercato.
L’Italia avrà un ruolo di primo piano nella guerra, inviando probabilmente anche truppe di terra. Potrebbe essere una guerra difficile, forse anche lunga, in cui la retorica del soldato caduto, e del sangue versato, resusciteranno il peggior patriottismo, con discorsi razzisti, xenofobi e islamofobi.
Nonostante tutto ciò, si va alla guerra nel silenzio quasi completo dell’opinione pubblica. Anzi c’è chi, come Panebianco, fa il Corradini di turno, chiedendo che l’Italia si armi di buoni soldati e di ottime penne. Mi chiedo, da storico, che utilità ha studiare il passato se poi, dinnanzi al baratro, si rimane muti, si nega l’importanza del ‘dire la verità’, si lascia spazio a polemiche sterili.
Ripenso alla mia generazione, cresciuta all’ombra di conflitti combattuti fuori dai confini dell’Europa: la prima guerra del golfo, la Somalia, l’intervento in Bosnia, poi il Kossovo, l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia. Per ogni guerra c’era un male da estirpare che talvolta veniva incarnato da un dittatore: Milosevic, Hussein, Gheddafi. La narrazione del male supremo fatto persona – eredità non ancora decostruita della seconda guerra mondiale – permetteva di offuscare le talvolta intricate vicende nazionali e regionali. In altri casi, invece, si ragionava per metonimia, confondendo il dittatore con il popolo. E allora, se il nemico era Milosevic, tutti i serbi avevano le mani sporche di sangue. Stesso dicasi per l’Iraq, per la Libia. La pioggia di fuoco scaricata dai mezzi militari, il più delle volte partiti da basi italiane, era raccontata dalla stampa, giorno per giorno, come il normale svolgersi degli eventi. Eppure, sotto quelle bombe, in quelle città in cui polvere e morte si mescolavano, qualcosa di tragico succedeva: oltre al terrore, ciò che rimaneva, ossia le macerie di una società in frantumi, riprendeva rapidamente forma. Non parlo delle sole persone, delle loro vicende individuali e collettive, ma anche dell’imponente sistema emotivo mobilitato che andava dalla rabbia al dolore, dalla paura al lutto. In questa mutazione, che coinvolgeva le vicende di milioni di persone – si pensi solo alle centinaia di migliaia di lutti di civili in Afghanistan e Iraq – bastava una esile fiamma per generare un incendio, ossia la voce di un leader, un gruzzolo di denaro e qualche arma per richiamare a una nuova mobilitazione contro coloro che avevano ancora le canne del fucile calde. Gli effetti sono stati e continuano ad essere dirompenti, come ben sappiamo.
Questo è solo uno dei livelli su cui articolare l’analisi: quello relativo alle guerre combattute per ‘esportare democrazia’ e contro un nemico assoluto dell’Europa e dell’Occidente. La teoria e la pratica della guerra umanitaria – fatta per il bene di un popolo, di una nazione, di un’area geografica – poggia sul ruolo egemonico di chi questa guerra l’ha voluta, l’ha combattuta e l’ha raccontata al mondo intero. Vi sono poi altri piani di questa intricata vicenda internazionale: quello di chi è cresciuto ai margini, nel cuore dell’Europa; quello relativo alla ridefinizione degli assetti geopolitici.
Da questo quadro, possiamo quindi desumere alcune riflessioni. La guerra in Libia non è un intervento clinico e mirato, ma una nuova tappa verso l’estensione di un conflitto precedente, internazionale e globale su scala locale. Non è una nuova guerra, ma è la continuazione di una guerra decennale il cui fine è il controllo delle risorse energetiche e degli snodi geopolitici. Assicurare la crescita, la continuazione di un sistema economico e politico è possibile solo con l’economia di guerra, solo depredando altri territori esterni al Vecchio Continente. I colonialismi lo hanno insegnato: schiacciare e impoverire popolazioni in Africa, in Asia, in Sud America ha come effetto indiretto rinsaldare le posizioni di comando all’interno delle società europee. Con le dovute differenze storiche rispetto all’esempio sopra, da ormai qualche decennio sta accadendo questo. Non è quindi un caso che la stampa ponga attenzione ai nemici fuori dai confini – e a coloro che i confini li hanno attraversati, arrivando in Europa – ma sia completamente silenziosa nei confronti delle azioni di neo-colonialismo, del privato o della singola nazione, in Africa, Asia e in America Latina.
Sappiamo bene quanto la situazione politica in Libia sia andata disintegrandosi: lo scontro tra due governi eletti, la nomina di un nuovo esecutivo che non controlla il paese, la presenza del Daesh alle porte della capitale, a Sabrata. A pochi chilometri dalla roccaforte degli islamisti, vi è il compound di Mellitah, dell’Eni. Ecco un’altra traccia: la costa libica è zeppa di impianti come questo. Pare non mancare nessuno, dalla tedesca Shell all’americana Waha Oil Company, dalla spagnola Repsol alla francese Total. L’intervento, programmato sotto la direzione di Washington, Londra e Parigi è imminente. Si va alla guerra senza che vi sia una strategia militare e un’alternativa politica credibile: quali saranno le strategie di ingaggio e quale, soprattutto, l’alternativa qualora si riuscisse a spuntarla contro gli islamisti. Proprio su questo punto va fatta una precisione: il caso di Sabrata rivela un altro elemento di primaria importanza. Il Daesh, in Libia, non è un esercito compatto, ma un insieme di gruppi e di fazioni, talvolta in competizione tra di loro per la gestione del territorio e delle risorse. A ciò si aggiunga che anche il fronte degli anti-islamisi libici è spaccato rispetto a un possibile intervento: non tutti, cioè, appoggiano l’attacco programmato da Usa, Gran Bretagna, Francia e Italia.
Col tempo, il concetto di guerra è profondamente cambiato: oggi non riguarda più solamente un nemico esterno, ma anche un fronte interno alle nazioni. Ciò significa che l’elmetto ce lo faranno indossare a tutti e a tutte, che la trincea potrebbe rivelarsi ben più vicina di quanto pensiamo, non oltre il Mediterraneo, ma sotto casa. Il tutto per una guerra che è combattuta per i controllo dei territori e delle relative risorse energetiche, degli assetti internazionali e geopolitici, per il dominio dei mercati finanziari. L’altro grande rischio, di cui vediamo i primi segnali, è la torsione islamofobica e xenofoba che già ha preso piede nel Paese contro persone che entrano (giustamente) in Europa fuggendo da quelle stesse guerre che l’Europa ha contribuito a generare nei decenni scorsi. Lo scontro riguarderà, però, anche gli italiani e le italiane, ossia coloro che sono nati in Italia: questione, questa, che tocca il nodo per nulla risolto della cittadinanza e della condizione sociale in Italia.
La guerra non è più un atto eccezionale, ma banalmente è in continuità con certe logiche economiche, politiche e sociali che creano povertà, migrazione e sfruttamento. La guerra, oggi, sta nel silenzio degli indifferenti. Vogliamo davvero la guerra? In caso contrario, la risposta, da dare nelle piazze, non deve riguardare solo il conflitto bellico che sarà in corso, ma l’intero sistema economico e politico, l’intelaiatura che regge, oggi, la nuova veste della Fortezza Europa. Oltrepassare quel confine significa ripensare il politico oltre la delega, il voto e la classe dirigenziale non solo dell’Italia ma dell’Europa tutta, ripensare l’agire sociale oltre l’impianto legislativo del Paese (dalla Costituzione ai dispositivi normativi in materia di immigrazione e cittadinanza). Guardando bene dentro il baratro che si è aperto, possiamo ancora scorgere la via delle piazze, di un’Europa che va ri-pensata e ri-costruita dal basso.
Immagine in apertura: artiglieria cammellata italiana, Libia 1912



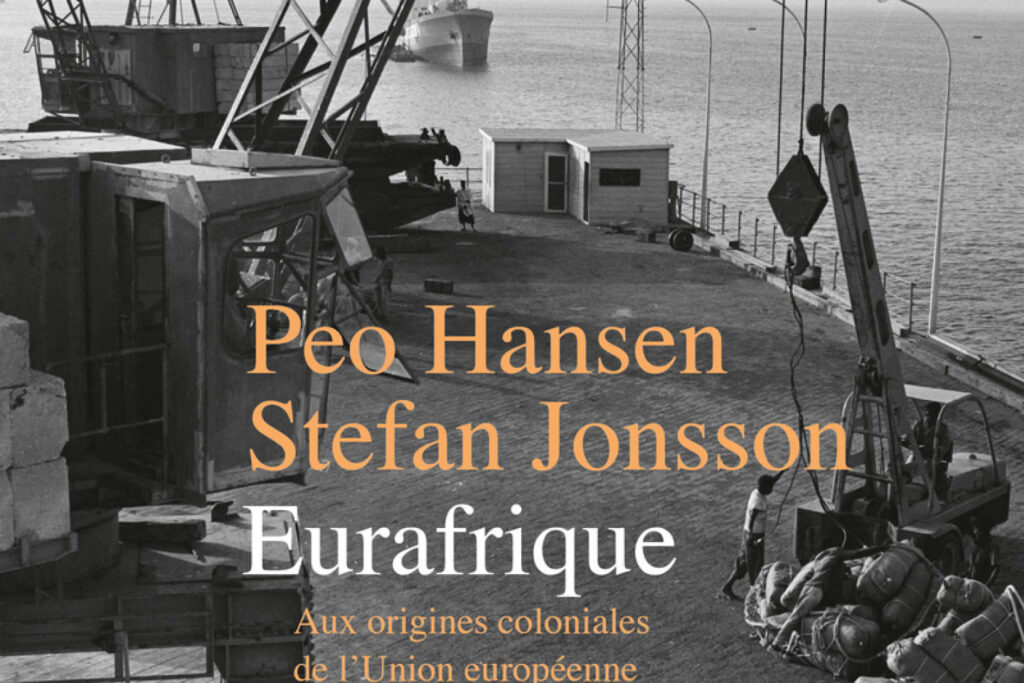




Scrivi un commento