Il codice penale come supplente della politica di fronte alla conflittualità sociale
Testo dell’intervento presentato al Convegno “Università neoliberale e libertà accademica: il pensiero critico è ancora possibile?” – Bologna, 14-15 ottobre 2016
*****
Il caso di Roberta Chiroli, la studentessa condannata nel giugno scorso a due mesi di reclusione per una tesi di laurea giudicata “moralmente complice” dei reati di “violenza aggravata e occupazione di terreni” legati alle mobilitazioni del Movimento No-TAV, si inscrive in un quadro repressivo che ha iniziato a colpire anche il diritto allo studio e alla ricerca. Si tratta di una vera e propria emergenza, una crescita esponenziale degli attacchi preventivi e repressivi contro ogni manifestazione di dissenso sociale che fa il paio con il progressivo svuotamento di qualsiasi sovranità degli istituti di rappresentanza politica, fenomeno questo non limitato solo all’Italia, ma caratteristico di tutto l’Occidente capitalistico. Superficialmente si può notare il tentativo di ricondurre questi casi di dissenso e insubordinazione sociale a meri casi di delinquenza comune. Tuttavia, se si va più a fondo, la caratteristica comune di questi provvedimenti restrittivi o sanzionatori è il loro carattere emergenziale, basato su teoremi e arsenali penali concepiti in altre epoche o rinnovati per fare fronte a ben altro tipo di problematiche.
Proprio il tema dell’emergenza è quello che ha contrassegnato l’azione della magistratura italiana (salvo qualche voce fuori dal coro), negli ultimi 40 anni: infatti, dalla fine degli anni 70 i governi e la gran parte delle forze politiche parlamentari che si sono avvicendate fra Prima e Seconda Repubblica hanno avuto in comune la “esternalizzazione” alla magistratura della gestione di una serie di “problemi” come la lotta armata, la corruzione della classe politica, le stragi e gli omicidi di mafia, importanti fenomeni sociali come la tossicodipendenza o l’immigrazione.
“Autonomia” dalla politica e abusi: il protagonismo dei giudici dal secondo dopoguerra
Nella storia della Repubblica il ruolo della magistratura si è via via rafforzato, diventando spesso – come scrive Ginsborg – «l’ultima trincea» dello Stato in assenza di una capacità (e spesso di una volontà) di controllare politicamente tanto i fenomeni di malcostume e di corruzione interni, quanto quelli legati alle contraddizioni sociali con i movimenti. Nonostante la Costituzione le garantisse una sostanziale autonomia dal potere esecutivo, ci vollero almeno una quindicina d’anni prima che almeno formalmente la magistratura si sganciasse dal rapporto “totalitario” di subordinazione che aveva avuto col potere politico durante il fascismo (la nascita del CSM avvenne infatti nel 1959). A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, si sviluppò l’affrancamento del potere giudiziario da quello esecutivo: le diverse Procure sul territorio cominciarono a godere di una sostanziale libertà di azione, in particolar modo attraverso la figura del Pubblico Ministero, la cui attività di preparazione delle inchieste e di direzione delle indagini di polizia è ancor oggi sovrintesa solo dal procuratore capo.
Se già di per sé poteri così vasti potevano di fatto portare ad abusi, in un contesto come quello della “perenne emergenza” italiana il rischio è diventato certezza. Il giudice delle indagini preliminari e quello dell’udienza preliminare spesso non si mostrano sufficientemente indipendenti dal pubblico ministero. La custodia cautelare, o la minaccia della stessa, viene spesso usata come strumento di pressione allo scopo di estorcere confessioni. Le ordinanze sanzionatorie o restrittive vengono spesso date in pasto alla stampa, in modo da preparare già nell’opinione pubblica il consenso verso la condanna del presunto colpevole. Inoltre, col loro dividersi in correnti politiche (Magistratura Democratica per la Sinistra, 1964; Unità per la Costituzione per il Centro, 1980; Magistratura Indipendente per la Destra, 1962-‘63), di fatto i giudici tornavano ad essere uno strumento di battaglia politica all’interno dello Stato (come dimostrano diverse importanti vicende giudiziarie nell’ultimo trentennio: dall’affaire Baffi-Sarcinelli nel 1979-’81, alle stesse vicende giudiziarie di “Tangentopoli”, fino a quelle più recenti legate alla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”).
Scopo di questo intervento, tuttavia, non è tanto quello di evidenziare l’utilizzo politico della magistratura nelle contraddizioni emerse all’interno del sistema di potere economico-politico italiano in questi ultimi trent’anni, quanto quello nei confronti del dissenso sociale e dei movimenti di lotta e antagonisti, soffermandosi in particolare sulla continuità “filosofica” (e spesso anche normativa o addirittura fisica) fra la legislazione d’emergenza di quarant’anni fa e la politica dell’emergenza attuale.
La legislazione d’emergenza: 1974 – 1982
Il periodo dell’emergenza fu inaugurato in Italia nel 1974, in tempi “non sospetti” dal punto di vista dell’allarme terroristico, col Decreto Legge n. 99 (11 aprile 1974), che raddoppiava i termini della carcerazione preventiva, e proseguì con la famigerata “Legge Reale”, un’autentica «licenza di uccidere» delegata alle forze dell’ordine (avrebbe provocato 350 vittime nei primi dieci anni di applicazione). Il 1977 sancì poi il salto di qualità, parallelo alla totale chiusura politica istituzionale alle istanze del movimento che esplose in quell’anno. La «legislazione d’emergenza» rappresentò nei fatti l’altra faccia della medaglia del compromesso storico e dei governi di solidarietà nazionale: tutto ciò che non era riconducibile al patto DC-PCI (o addirittura vi era irriducibile) diventava di fatto gestito come questione penale e giudiziaria, attraverso i divieti del ministro Cossiga, i carri armati e gli agenti in borghese dal grilletto facile nelle piazze, l’introduzione delle carceri speciali (peraltro mai oggetto di misura legislativa).
L’emergenza antiterrorismo, a partire dalla Legge Cossiga del 6 febbraio 1980 e poi con la legislazione sui pentiti, fu il primo contesto in cui si accrebbe e si rinnovò il protagonismo politico dei giudici, con un drastico ridimensionamento dei diritti individuali. Due eventi possono esserne portati ad esempio: il cosiddetto “Processo 7 aprile” e il fenomeno del pentitismo. Il 7 aprile 1979 una vastissima azione giudiziaria tentò di ricostruire anni di conflitto di classe in Italia, accusando decine di dirigenti e militanti dell’Autonomia Operaia di essere a capo di un’unica centrale che dirigeva tanto l’arcipelago della sovversione politica di sinistra, quanto l’insieme delle organizzazioni armate, in primis le Brigate. Nonostante l‘attivismo zelante dei magistrati, tutti i condannati dell’Autonomia Operaia subirono pene inferiori a quelle richieste da sostituto procuratore di Padova, Pietro Calogero (coadiuvato in differenti procedimenti da Gian Carlo Caselli, suo omologo a Torino, e dal Procuratore Capo a Roma Gallucci, titolare dell’inchiesta sull’uccisione di Aldo Moro).
Il “teorema Calogero” fu giudiziariamente (e anche in sede storica) sconfessato e la stragrande maggioranza di tutti gli arrestati e indagati vennero assolti per insufficienza di prove o con formula piena (per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato). Il “Processo 7 aprile” fu oggetto di aspre critiche non solo da parte del movimento (il che era scontato), ma anche di importanti associazioni per i diritti umani (come Amnesty International) e da vasti settori del mondo intellettuale e giuridico (come Gilles Deleuze e Luigi Ferrajoli). In buona sostanza, la crociata di Calogero e Caselli fu accusata di essersi basata su una grossolana manipolazione della realtà e di aver utilizzato in modo indiscriminato e fuori da ogni controllo (o per meglio dire a insindacabile discrezione del magistrato) la carcerazione preventiva, tanto che alcuni imputati passarono dai 36 a i 44 mesi in carcere prima del processo. Le procure interessate nell’inchiesta si avvalsero anche dell’uso di testimonianze di pentiti estranei all’area dell’Autonomia padovana (come Marco Barbone, leader della Brigata XXII Ottobre che uccise il giornalista Walter Tobagi, o come Patrizio Peci, capo della colonna torinese delle BR). Inoltre, in questo caso le leggi speciali antiterrorismo, entrate in vigore dopo gli arresti, furono però applicate retroattivamente per prolungare i termini della carcerazione preventiva. In alternativa, venivano spiccati nuovi mandati di cattura pochi giorni prima della scadenza della custodia cautelare. Infine, secondo quanto dichiarò Amnesty International, l’inizio del processo (già istruito) fu posticipato di quindici mesi per motivi “imprecisati”.
La legge n. 304 del 29 maggio 1982, meglio conosciuta come “legge sui pentiti”, se ebbe un’efficacia indiscutibile dal punto di vista della reazione dello Stato al fenomeno della lotta armata, allo stesso tempo danneggiò enormemente il cosiddetto “sistema delle garanzie”. Essa in realtà servì più per regolarizzare i “grandi pentimenti” sui quali erano stati imbastiti anche processi monstre (come li ha definiti la storica Monica Galfrè) come il “7 aprile” o il “processo Tobagi”, durante il quale, accanto agli esecutori materiali dell’omicidio erano stati messe decine di attivisti e/o militanti politici che con l’azione non c’entravano nulla, ma che rappresentavano l’area della sovversione milanese secondo il PM Spataro.
Politica giudiziaria emergenziale e pentitismo furono quindi le due facce atroci della stessa medaglia per centinaia, forse migliaia di attivisti politici e non solo: i casi drammatici di Giuliano Naria (l’ex militante di Lotta Continua che scontò dieci anni di carcerazione preventiva fra il 1976 e il 1986 accusato di essere l’esecutore dell’omicidio del giudice Coco a Genova, fino a quando, agli inizi degli anni ’90 fu completamente scagionato con formula piena) e di Enzo Tortora (accusato ingiustamente da un pentito di camorra di essere implicato in un traffico di droga, scontò sette mesi di carcerazione preventiva, prima di essere riconosciuto innocente) stanno lì a dimostrarlo. Peraltro entrambi finirono poi per morire di tumore (rispettivamente nel 1997 e nel 1988) ed è difficile pensare che il loro calvario non abbia influito nel tragico epilogo.
Un rinnovato protagonismo dei giudici fra “tradizione” e nuove sperimentazioni
Oggi, il “governo delle contraddizioni sociali e politiche” attraverso il codice penale si basa su articoli normative già preesistenti (alcuni risalenti al famigerato Codice Rocco), ma sul cui utilizzo i magistrati hanno completa mano libera, tentando anzi di inaugurare pericolose “tradizioni”. È questo il caso, da una quindicina d’anni a questa parte, dell’utilizzo sempre più frequente del reato di “devastazione e saccheggio” (art. 419 del codice penale). Mai utilizzato durante gli anni Sessanta e Settanta, se non in rarissimi casi e quasi tutti relativi a rivolte carcerarie, il reato di devastazione e saccheggio viene rispolverato nell’aprile del 1998, all’indomani degli scontri che a Torino seguirono la morte in carcere di Edoardo Massari, ingiustamente accusato di alcuni attentati ai primi cantieri del TAV. Fu poi massicciamente riutilizzato per i fatti del G8 di Genova (con 11 sentenze definitive di condanna), per poi diffondersi a macchia d’olio sia in relazione a scontri durante manifestazioni politiche (Roma, 2011, con 7 condanne in primo grado e 18 rinvii a giudizio; Cremona 2016; Milano 2006 e 2015) sia a carico di vari movimenti ultras nel mondo del calcio.
Secondo alcune ricostruzioni, dal luglio 2001 (G8 di Genova) al 2007 sono state circa 17.000 le persone mandate a processo per reati legati a lotte sociali (casa, precarietà, immigrazione, ecc.). Fra questi, gli abitanti della Val di Susa, protagonisti di una vertenza territoriale ultraventennale contro la costruzione del TAV, l’occupazione militare del territorio e la sperimentazione di nuove metodologie repressive. Proprio la Val di Susa e il Movimento No-TAV sono scenario e oggetto di una nuova sperimentazione della cultura politico-giudiziaria dell’emergenza, nella quale si rinnova il totale protagonismo da parte della magistratura inquirente, impegnata in una sequela di provvedimenti nei quali è possibile rinvenire quella stessa filosofia che ha animato gli anni dell’emergenza anti-terrorismo.
L’ex magistrato Livio Pepino, impegnato egli stesso nel movimento No-TAV, ne ha tracciato una illustrazione molto condivisibile: 1) Attribuzione di una corsia privilegiata ai processi nei confronti di esponenti No Tav; 2) l’estetica dei dibattimenti (spesso celebrati nell’aula bunker del carcere delle Vallette) tesa a creare un collegamento psicologico coi processi per terrorismo e mafia; 3) l’istituzione presso la Procura di un pool “anti NO-TAV” (ora sciolto); 4) la contestazione anche di piccoli reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria; 5) l’uso massiccio della carcerazione preventiva, delle misure cautelari alternative (come gli arresti domiciliari), degli obblighi o dei divieti di dimora (art. 283 del codice penale), provvedimenti questi storicamente utilizzati soprattutto nei confronti dei mafiosi, anche nei confronti di incensurati; 6) la flessibilità estrema nell’utilizzo dell’accusa di concorso nel reato per «responsabilità da contesto» (questo può essere il caso della Chiroli); 7) l’utilizzazione nelle motivazioni delle sentenze e delle ordinanze di terminologie forti o drammatiche (quasi che con queste si possano sostituire i riscontri fattuali); 8) la precisa organizzazione di campagne a mezzo stampa che sostengano e diffondano le ragioni degli inquirenti. L’elenco finisce con l’azione, se vogliamo, più grave: il tentativo di trasformare azioni sì violente, ma indirizzate con tutta evidenza contro cose e senza alcun rischio per la incolumità fisica delle persone, in attentati con finalità di terrorismo (art. 270 rivisitato dalla Legge 155 del 31 luglio 2005, la famosa “Legge Pisanu”). Tentativi finora fortunatamente falliti grazie a due sentenze rispettivamente della Corte d’Appello di Torino e della Cassazione, l’ultima quella del 21 dicembre 2015, contro la quali comunque la procura di Torino ha di nuovo ricorso in Cassazione.
Queste prassi sono, all’evidenza, frutto di scelte rispondenti alla concezione — propria dei poteri forti e assai diffusa nella politica — secondo cui le società si governano in modo centralizzato e autoritario e il confitto sociale è un elemento di disturbo praticato da «nemici» meritevoli di repressione esemplare. Una concezione e delle prassi che (sebbene con portata e intensità differenti rispetto al caso piemontese) vengono affermate e praticate nella gestione dell’intero microcosmo della conflittualità sociale, come evidenziano i dati sommariamente esposti.
Conclusioni
Ecco quindi il carattere perenne della legislazione d’emergenza in Italia, con tutto ciò che ne consegue sul piano della sospensione dei diritti (collettivi e individuali) e dell’involuzione autoritaria. Una specie di “Stato di eccezione a geometria variabile” da applicare non solo in contesti e in periodi diversi, ma ogni qual volta i governi e i partiti che li sostengono non siano in grado di gestire (o non vogliano risolvere) politicamente i conflitti. Il codice penale sembra rimanere lo strumento principale per gestire non solo i conflitti politici e sociali non riconducibili nelle stanze delle segreterie dei partiti o nelle aule parlamentari (sempre più svuotate di rappresentatività), ma anche il pensiero critico e la libera ricerca, nel nome del principio tecnocratico della governabilità dei centri di potere economico e politico.
Bibliografia
- Ginsborg, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato. 1980-1996, Einaudi, Torino, 2007
- Galfrè, La lotta armata. Forme, tempi, geografie, in S. Neri Serneri (a cura di), Verso la lotta armata. La violenza politica nella sinistra radicale degli anni ’70, pp. 63-91, Bologna, il Mulino,2012.
- Curcio, La mappa perduta, Dogliani, Sensibili alle foglie, 2007 (Prima edizione 1994).
- Galfrè, La guerra è finita. L’Italia e l’uscita dal terrorismo. 1980-1987, Laterza, Roma-Bari, 2014
- Bianchi e Caminiti, Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie, vol. I, DeriveApprodi, Roma, 2007.
Immagine in apertura: Rodney Smith, “Reed with a megaphone”







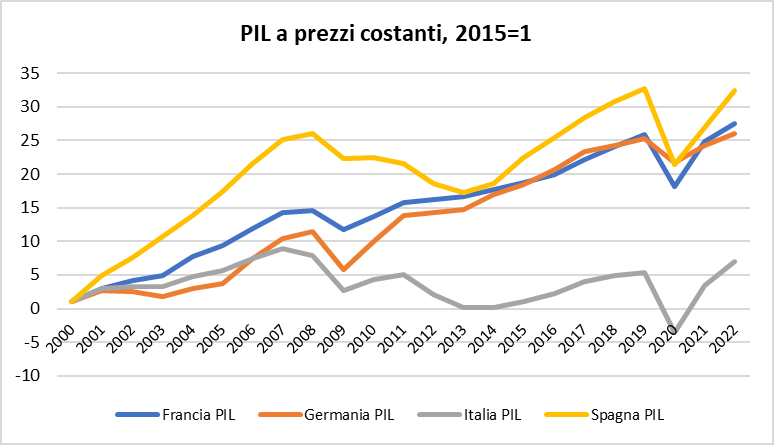
Scrivi un commento