«Non possiamo cambiar la patria. Allora cambiamo argomento», è la frase che Joyce consegnava al suo Stephen Dedalus e che Munir Hachemi sceglie in epigrafe al primo capitolo del suo Cose vive (limpida traduzione di Serena Bianchi per La Nuova Frontiera). La patria è dove puoi vivere bene, il senso è un po’ questo, se lavori – aveva poco prima detto, a Stephen, l’Ulisse Leopold Bloom.
Cose vive si apre, a tutti gli effetti, con un lavoro impossibile: la vendemmia nel Sud della Francia, promessa di qualche soldo e soprattutto di una qualche “esperienza” per Munir, G, Ernesto e Álex, quattro ragazzi spagnoli che avrebbero voluto impiegare così la loro estate. E procede con lavori via via sempre più impossibili con i quali il vivere bene si fa sempre più distante: incarichi precari e senza tutele che vanno dall’attrappage (infilare dei polli in strette gabbie, afferrandoli per le zampe, che spesso si spezzano per l’urto) alla vaccination (estrarre i polli da una gabbia, vaccinarli, ri-infilarli nella gabbia, inoculazione che andrà a informare corpi capaci di vivere, «ingozzati di luce e mais», «diversi giorni in un giorno e diverse vite in una vita», p. 70), dalla distruzione del fegato delle anatre per produrre il foie gras alla fecondazione di varietà di mais iperproduttive (che andranno a sfamare quegli stessi animali). Il lavoro vivo raccontato in Cose vive, insomma, coinvolge innumerevoli «povere bestie» (p. 51) prese nei dispositivi del lavoro morto, cose vive che vanno dai quattro protagonisti al lumpenprolëtariat impiegato negli allevamenti, ai polli, alle anatre, agli steli del mais e alle loro pannocchie e poi alle vacche e alle sementi – il capitale, nella sua estrazione di valore, non si è mai fatto scrupoli di specie e non ha mai riconosciuto nulla se non la proprietà. E sicuramente non consente alle «povere bestie» di vivere bene: bisogna quindi cambiare patria e, se questo non è possibile, cambiare argomenti.
Cose vive nasce per raccontare le vicissitudini (realmente accadute? Quale sia la dose di artificio che la narrazione impone al fatto avvenuto è un interrogativo che accompagna chi legge sino alla fine) di quattro amici che avrebbero volentieri dedicato l’estate alla vendemmia nelle campagne francesi («Era il 2012 o il 2013 e, dopo quell’intervallo, saremmo tornati a frequentare un master universitario a Granada», racconta l’autore in un’intervista) e che invece si ritrovano, loro malgrado, immersi in un concatenamento di corpi, lavoro sottopagato (per gli animali umani) o non retribuito affatto (per gli animali non-umani). «Ciò che abbiamo vissuto quell’estate ci ha segnato, tanto che prima di scrivere Cose vive sono passati alcuni anni, necessari a rielaborare l’esperienza», continua Hachemi. Cambiare patria, appunto, se il lavoro non consente di vivere bene, né di vivere tout court.
Come ha scritto Deleuze, chi sopravvive a questi eventi può farlo solo tagliando la corda, gesto dal quale non è possibile tornare indietro, gesto che è invocazione – che a quel passato non si possa più accedere, che quel passato possa addirittura cessare di esistere. Tagliare la corda è allora tornare a quegli eventi, sembra dirci Hachemi, togliendone via ogni orpello, sacrificando l’intrattenimento che la forma-romanzo sembra richiedere per arrivare al «grado zero dell’ornamento» (p. 10). Reciderne la componente di narrazione, cambiare argomento se non è possibile fare altro. Del resto, ci spiega l’autore / narratore / personaggio, non si sta certo cercando un dialogo con il mercato, bestia di cui ha imparato a diffidare, ma solo con un tu che non ha nemmeno forma umana, ma è un diario, sorta di deposito inorganico.
È forse questa l’unica forma possibile per rendere l’idea di quel che è accaduto, per darle corpo e restituirne la carne – non è certo possibile ricomporre le spoglie di quei tanti corpi sterminati che l’imperativo del profitto ha prima cresciuto a dismisura e poi smembrato –, per far sì che chi leggerà «“tutto è coperto di sangue”» possa intendere «solo questo: tutto è coperto di sangue […], neppure sangue fresco: è sangue secco, secchissimo» (p. 10). Una forma richiesta dalla gravità dei fatti e dalla lievità greve dei resti, forma necessaria (prima ancora che possibile) per raccontare quel ciclo di produzione che del maiale riesce a utilizzare perfino il grugnito e che crea sementi aberranti per nutrire le povere bestie (ma si può poi chiamare quella cosa nutrire?). Corpi fatti crescere a dismisura, i cui non scarti saranno dati da mangiare ad altri corpi smisurati, come polveri d’osso nella pastoia o come liquame a fertilizzare il vegetale da cui eravamo partiti…
Ma eravamo davvero partitə? O piuttosto, eravamo e siamo sempre presə da questa spirale che si morde la coda, come un serpente, come un cane, come le povere bestie che, costrette nelle gabbie, si mordono l’un l’altra per scaricare lo stress: la coda va allora tagliata – e tutto questo come si racconta? Da qualche parte si deve partire, si deve cambiar patria, e, se non è possibile, si deve cambiare argomento. Si deve allora scrivere, diceva ancora Deleuze, per divenire donna, frociə, nero o bestia, per divenire impercettibile. Si deve scrivere senza augurarsi di essere riconosciutə che sia dalle proprie parole o dal proprio stile: questa storia non è bella e restituisce morti bianche e reti para-legali di collocamento che stringono le loro vittime come può farlo la rete di un pescatore o quella di un bracconiere (o quella più grande degli algoritmi), ed è pertanto bene raccontarla in maniera clandestina. Perciò è necessario (prima che possibile) rendere questa storia poco bella, ossia spoglia, nuda d’ornamento e di retorica, come si diceva.
Non a caso la teoria del grado zero dell’ornamento è quella che il personaggio / narratore / autore Munir mette in atto nei confronti dell’amico G e della sua teoria del racconto. Il racconto, ripete G sin da ragazzino, nasce nel punto di tangenza fra una vita e la morte, è maniera (senza maniera) per dare ordine e forma a quel che è caotico (e su questo imperativo classificatorio e gerarchizzante s’è costruita tutta una civiltà, a ben vedere, una civiltà di animali che possiedono il linguaggio); il racconto, insomma, è un modo per distogliere lo sguardo davanti a qualcosa di altrimenti insostenibile, «per voltarsi dall’altra parte mentre la vita prosegue» (p. 9). E proprio dal prendere posizione davanti al punto di tangenza tra una vita e le morti ancora in vita nasce Cose vive nella sua forma di diario – un escamotage contro l’impossibilità dell’escamotage, perché quelle morti le si è vissute, se non già provocate, e non si è potuto distogliere lo sguardo, proseguire oltre, e quindi le si deve raccontare crudamente: si deve raccontare marginalità e marginalizzazione vissute mettendosi a margine dell’accaduto che nel frattempo continua, oltre misura, ad accadere.
Come afferma Hachemi nell’intervista citata, «a differenziare le rivendicazioni della sinistra da quelle della destra è, io credo, la sofferenza, è il fatto che le prime nascono dal dolore». E questo è un dolore, che non va ventriloquato né lenito per chi legge, ma solo lenito in quelle cose vive che soffrono in quanto cose vive – «La sofferenza è animale», diceva Nancy –, che sono messe a profitto e poi a morte – destino in qualche misura trasversale a tuttə ə viventi al tempo del capitale, il che significa «affrontare ciò che si è vissuto come una questione di classe». In questo senso, il diario riporta le diverse forme di sfruttamento e oppressione, ma soprattutto delinea la rete di relazioni che le costituiscono e che le puntellano l’una contro l’altra – si pensi, per esempio, alla scena in cui un operaio non può che sfogare la propria frustrazione e il proprio schifo per il trattamento riservato ai polli sui polli stessi –, che legano assieme i corpi, al di là della specie di appartenenza, in una presa sempre più stretta sino a renderli pastura informe e irriconoscibile, poltiglia rosa ed equivalente universale.
Se il lavoro è incapace di costituire una dimensione dell’abitare, del vivere bene – si deve cambiare patria. E se fuggire nello spazio non è possibile allora rimaniamo fermə; presə nella morsa di un lavoro che non è buona vita ma orrenda morte e, senza cambiare argomento, raccontiamone le mappe di sangue rappreso, come fa Munir Hachemi. Chi sta avvolto nelle braccia (non spire!) di questo potere ne conosce la topografia, le volute, le giunture. Se non può muoversi per colpire, perché schiacciato sotto il peso del suo stesso corpo o perché impeditə dalle sbarre della gabbia d’acciaio, può almeno indicare al altrə dove andrebbe inferto il colpo.
Questo è il grado zero dell’ornamento: testimonianza e passaggio di testimone, resoconto di una spia, voce infiltrata e ancora smisurata pro-vocazione – che quel passato possa cessare di esistere, che non lo debba più vivere alcunə. Queste, quando ci parlano e ci convocano davanti al loro incessante morire, sono le cose vive.
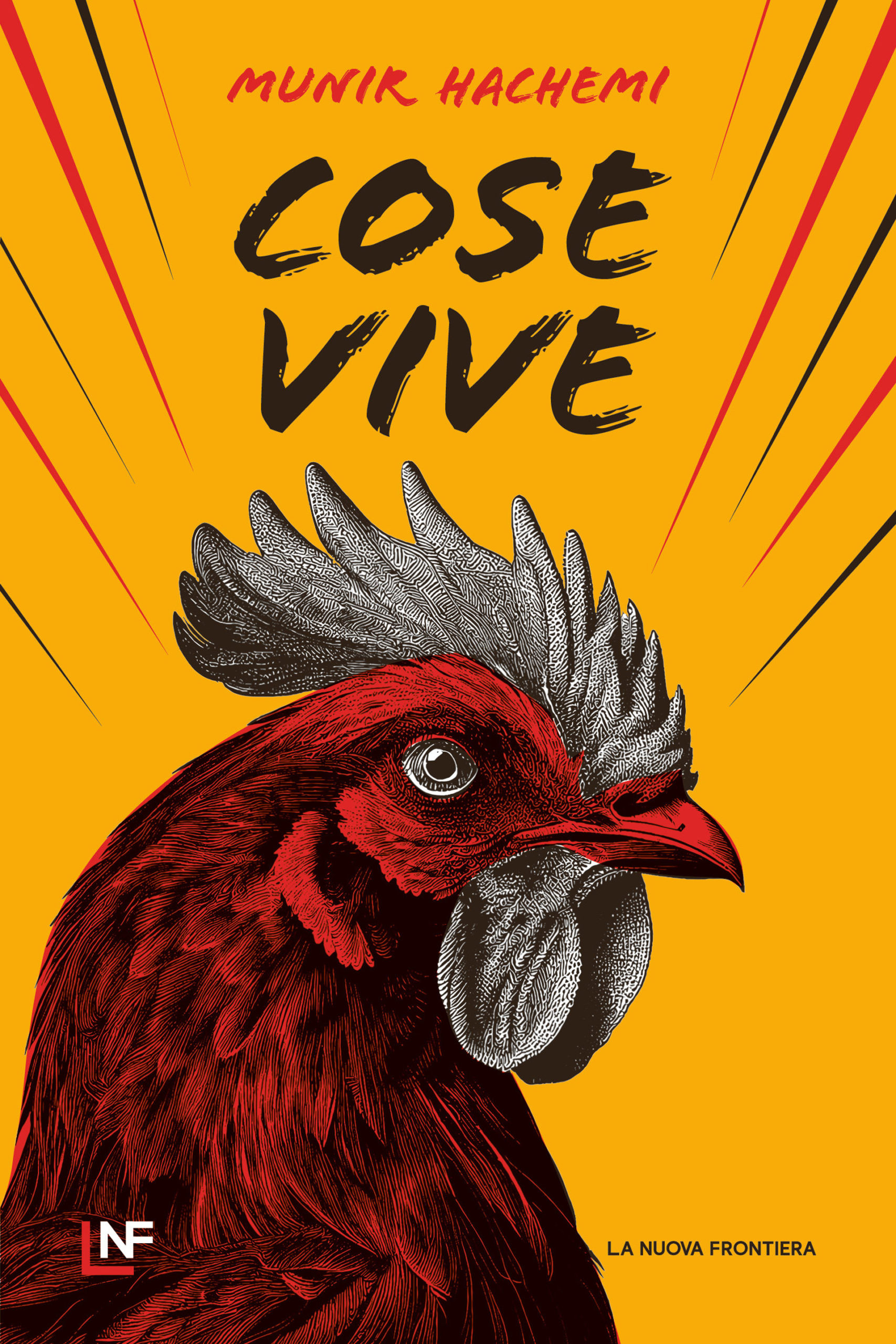






Scrivi un commento