Il week-end del 26-28 maggio 2017 si terrà a Taormina il vertice G7, in Italia a 16 anni da Genova 2001 e a otto anni da quello di Aquila nel 2009. È il turno dell’Italia, come vuole la rotazione. Nel frattempo dal 2014, il G8, con l’esclusione della Russia di Putin, è diventato G7. Di che cosa si discuterà a Taormina? Diversi potrebbero essere i temi all’ordine del giorno, a partire dal tema ecologico. Il nuovo presidente americano Trump ha dichiarato che in quell’occasione prenderà posizione sui risultati del vertice di Parigi del 2016. Sicuramente, all’indomani dell’attentato di Manchester, si parlerà anche di terrorismo e di lotta all’Isis, con l’intento di far dipendere da questa emergenza, qualsiasi proposta (in senso restrittivo) di governance dei flussi migratori. Sulle questioni socio-economiche, a parte il comunicato standard finale di parole vuote, non ci sarà praticamente di nulla. Il che non può sorprendere.
Non c’è infatti bisogno di affrontare tematiche economiche, se non alcuni aspetti di natura geo-politica (principalmente legati al rapporto con la Cina). Tematiche, che, in ogni caso, non potranno trapelare nelle dichiarazioni ufficiali, anche se è facile immaginare che terranno banco nel backstage.
Il motivo è tanto semplice quanto banale. L’attuale capitalismo gode di ottima salute e il processo di valorizzazione è tutt’altro che in fase di declino. A conferma di ciò, prendiamo alcuni indicatori:
1. L’indice borsistico S&P500, che raccoglie le 500 imprese americane a maggior capitalizzazione, tocca il valore più basso il 6 marzo 2009 con 638 punti. Tocca un primo massimo il 4 luglio 2011 con 1344 punti. Dopo una piccola flessione raggiunge un nuovo massimo il 15 maggio 2015 (2122,7 punti), all’inizio dello scoppio della bolla immobiliare cinese per poi riprendere la corsa verso l’alto, a partire da febbraio 2016 (1864 punti) per poi risalire sino ad oggi (24 maggio 2017), toccando il massimo storico di 2404,4 punti (+374% nel periodo 2009-2017) Nello stesso periodo, l’indice Nasdaq, che raccoglie le quotazioni dei principali titoli tecnologici, evidenzia un andamento analogo, seppur più marcato. Dopo aver raggiunto il massimo di 5132 punti il 10 marzo 2000, in pieno boom della New economy prima del successivo scoppio della bolla speculativa delle Dot-com, durante la crisi dei subprime del 2008, tocca il minimo nel febbraio 2009 con 1377,8 punti per poi risalire a fase alterne sino al massimo storico attuale di oggi (24 maggio 2017) di 6.163,0 (+427% nello stesso periodo).
Le borse europee seguono lo stesso andamento, seppur in modo meno marcato, a causa della maggior instabilità dell’economia europea e il perpetuarsi di una situazione di stagnazione economica indotta dalle politiche d’austerity. La Borsa di Milano si conferma un’eccezione, soprattutto negli ultimi mesi. Dopo aver raggiunto un valore massimo di 23.840 nell’aprile 2015, in linea con le altre borse e aver recuperato da un minimo toccato nel febbraio 2009 (15.282 punti) con un incremento comunque di gran lunga inferiore a quello delle altre borse (+56%), dopo lo scoppio della bolla immobiliare cinese, la borsa di Milano, a causa delle tensioni sul mercato bancario italiano, non riesce a riprendersi come le altre e al momento (24 maggio 2017) chiude con una quotazione inferiore al massimo di due anni fa (21.267 punti).
2. L’andamento dei profitti delle imprese americane, dopo aver toccato il minimo nel 2009, con un valore complessivo di poco inferiore agli 800 miliardi di dollari, raggiungono il massimo a metà 2015 per poi calare a fine dello stesso anno e chiudere il 2016 con un valore pari al doppio di quello ottenuto all’apice della crisi. Il medesimo andamento è riscontrabile per i profitti delle imprese tedesche
Diversa invece appare la dinamica per l’economia cinese. I profitti industriali evidenziano un andamento tendenzialmente ciclico con l’andamento delle borse cinesi e anticiclico con i paesi occidentali, con un trend che vede un calo nel 2015 e una ripresa nel 2016, in un contesto generale che presenta un rallentamento nella crescita, seppur ragguardevole, dell’economia cinese. Ricordiamo che nella seconda parte del 2015, la borsa cinese ha registrato un vero e proprio tracollo con un calo dal maggio a luglio di oltre il 50% delle quotazioni.
Nell’arco di un anno, da giugno 2014 a giugno 2015, le borse cinesi avevano creato 6.5 mila miliardi di dollari, abbastanza da dare almeno 900 dollari ad ogni persona sulla faccia della Terra, un valore pari a circa il 70% del PIL cinese nel 2013, circa il 40% della capitalizzazione del Dow Jones e circa 20 volte il debito pubblico della Grecia in quel periodo. Mai, in soli 12 mesi di tempo, un mercato azionario aveva creato un simile ammontare di denaro in termini di dollari.
Da fine 2014 fino a giugno 2015, la borsa cinese era cresciuta del 40% a Shanghai e ben del 90% a Shenzhen, raggiungendo livelli record di capitalizzazione nella storia del mercato azionario del paese;
Nello stesso periodo la crescita dell’economia reale era ai livelli più bassi da 25 anni (quando il tasso di crescita precipitò al 3,9% in seguito alla crisi politica di Tienanmen): la crescita del Pil è stata del 7,3% per il 2014 e del 6,9% per il 2015 e del 6,4 per il 2016, il che fa supporre già di per sé che la corsa dei prezzi azionari non potesse in alcun modo essere basata sui fondamentali: investimenti, vendite al dettaglio, transazioni con l’estero erano e sono tutti fattori in diminuzione, insieme ai prezzi sul mercato immobiliare, settore fondamentale per l’economia e considerato, dalla creazione di diritti privati sulle proprietà residenziali, porto sicuro e affidabile per gli investimenti dei cittadini.
Il divenire rendita del profitto nel capitaismo bio-cogniitivo
Da queste osservazioni statistiche, si evince che il meccanismo di valorizzazione del capitalismo contemporaneo è ben funzionante, e contrariamente a quanto si possa pensare, più nei paesi occidentali che in quelli orientali e che non sembrano esserci al momento tendenze di una crisi di profittabilità.
Inoltre il legame tra profitti imprenditoriali e borse finanziarie appare sempre più stretto, favorito anche da operazioni finanziarie che – come nel caso del “buy-back” – legano in modo sempre più indissolubile i profitti delle imprese shareholder con la capitalizzazione finanziaria Analizzando i bilanci delle società quotate americane, William Lazonick[2] ha appurato che nei 10 anni tra il 2006 e il 2015 la parte di gran lunga maggiore del pacchetto retributivo complessivo di un top manager, la cui media annuale è passata dai 25,6 milioni dl primo anno ai 32,6 dell’ultimo, è quella collegata ai titoli. Nel 2006 rappresentava circa il 73% del totale. Nel 2015 è arrivata all’82 per cento. Ne consegue che gli interessi dei manager e degli azionisti tendono a convergere E ciò traccia una differenza sostanziale con la grande impressa fordista. Come ben mostrato da Lazonick, la realtà è che a partire dagli anni ’80 negli Usa sono state le aziende a fornire fondi al mercato azionario e non viceversa. È la conferma del divenir rendita del profitto. A fronte di questa situazione, possiamo ancora parlare di crisi del meccanismo di valorizzazione? Ciò che gli anni post 2008 hanno evidenziato è piuttosto la crisi della governance politica del processo di globalizzazione più che della sua regolazione economica. Anzi sul piano economico, dal punto di vista del capitale, la globalizzazione ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, al punto che non pare più possibile oggi un ulteriore suo incremento. I recenti fatti politici – Brexit e l’elezione di Donal Trump su una piattaforma di politica economica che vorrebbe riscoprire il protezionismo nazionalista – non devono ingannare. Tali accadimenti, infatti, non possono mettere in discussione il principale pilastro su cui, grazie alla globalizzazione – congiuntamente alla finanziarizzazione – si fondano gli attuali processi di valorizzazione: la centralità della produzione immateriale a più alto valore aggiunto (i settori bioeconomici) con il proprio indotto logistico e la natura modulare per flussi transnazionali (network) che li caratterizza e il ruolo della finanza nella governance dei frutti di tali produzioni ad alto valore aggiunto.. L’intersezione inscindibile con la dinamica dei mercati finanziari è un antidoto a qualsiasi processo di de-globalizzazione economica, sia per la natura stessa dei flussi finanziari e tecnologici che sfuggono a qualsiasi recinzione nazionale sia per l’elevato grado di interdipendenza transnazionale nella generazione di plus-valore. Si stima infatti che più del 40% dei profitti delle principali corporations americane derivino da attività produttive delocalizzate e siano parcheggiati al di fuori dei confini Usa[3]. Se la globalizzazione economica ha raggiunto i suoi limiti, anche in termini di redistribuzione del reddito sia intra-nazionali che tra paesi, è invece in fase di profonda ridefinizione la globalizzazione politica. È solo a questo livello che si può forse parlare di un processo in fieri di de-globalizzazione politica, da non confondersi con quella economica. Diciamo “forse”, non solo perché è ancora troppo presto per definire con sicurezza le tendenze dominanti in corso, ma anche e soprattutto, perché ciò che appare profilarsi all’orizzonte più che un tradizionale ritorno alle sovranità nazionale (processo oramai non più possibile, proprio per l’elevata interdipendenza sul piano economico e finanziario) è una ridefinizione degli assetti geo-politici a livello internazionale. La decisione di Trump di uscire dal trattato di libero trans-pacifico (TTP, che non contemplava tra i suoi membri la Cina) può favorire la costituzione di un nuovo asse geo-politico che vede il rafforzamento di accordi commerciali tra la Cina stessa, l’Australia e il Giappone (ora orfano degli Usa) lungo un asse australe del Tropico del Capricorno che vede come protagonisti oltre la Cina, il Sud Africa, parte dell’Africa Australe e i paesi del continente sudamericano (Brasile in testa). Viceversa, gli ammiccamenti tra la nuova amministrazione Usa, la Gran Bretagna, e la Russia di Putin possono costituire un asse geo-economico lungo l’asse nord del Globo[4]. In tal modo, la configurazione geo-politica potrebbe assumere sembianze del tutto nuovo: non più la classica divisione tra Est e Ovest, retaggio della guerra fredda e del secolo corso, ma tra Nord e Sud del mondo, in un modo del tutto nuovo: non più tra un Nord sviluppato e un Sud sottosviluppo, ma tra aree pienamente sviluppate con interessi conflittuali. La conseguente instabilità politica, unitamente ai teatri bellici in corso, si aggiunge all’instabilità strutturale sul piano economico. Si tratta di un’instabilità economica che, lungi dall’avere effetti negativi sulla valorizzazione capitalista, ne consente il perpetuarsi. La crisi del lavoro È invece sul versante del lavoro e della distribuzione del reddito, quindi delle condizioni di vita, che si può parlare a tutti gli effetti di crisi reale. Numerosi sono gli studi che mostrano il poderoso processo di concentrazione delle ricchezze. Un processo di concentrazione che, non a caso, è andato di pari passo con quello dei mercati finanziari e dei flussi tecnologici. Infatti, il controllo dei flussi finanziari in sempre minor mani e la gestione dell’innovazione tecnologica e dei brevetti in sempre minor corporation, nei diversi settori, non è altro che la ridefinizione di un assetto proprietario che oggi non si fonda più sulla solo proprietà privata degli stock fattori produttivi, in primis, le macchine, ma riguarda in misura crescente il controllo dei flussi sia tecnologici che finanziari. Parliamo di controllo e non di proprietà in senso classico. Ciò che viene controllato non implica che sia anche detenuto in forma privata. La crescita della concentrazione della ricchezza e dei redditi non è altro che il risultato del passaggio dalla proprietà al controllo. Ne discende una unica struttura di potere che è pervasiva su tutta la società sino a interessare anche la vita umana stessa. Come sappiamo, tale nuova struttura di potere non è altro che il biopotere. L’esercizio di tale biopotere, che trova la sua massima espressione nell’oligarchia finanziaria, si perpetua anche e sempre più nei meandri della vita quotidiana, nella formazione, nelle relazioni e nella riproduzione sociale, è pervasivo. La precarietà esistenziale e la continua ricattabilità ne sono la conseguenza. Ma tutto ciò non sarà sicuramente oggetto di discussione a Taormina. Note [1] Il buy-back (o riacquisto di azioni proprie) è l’operazione di acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni. Tale operazione è finalizzato a massimizzare l’incremento di valore del capitale sociale piuttosto che a aumentare i ricavi e le quote di mercato. Nel primo caso, paliamo di imprese shareholder, nel secondo caso di imprese stakeholder. [2] William Lazonick, “Profits Without Prosperity: How Stock Buybacks Manipulate the Market, and Leave Most Americans Worse Off”, Institute for New Economic Thinking (Inet), New York, aprile 2014 [3] Un’analisi del Wall Street Journal di qualche anno fa (2014) su 60 grandi aziende statunitensi ha scoperto che hanno parcheggiato un ammontare di 160 miliardi di dollari di profitto nei paradisi off-shore a partire dal 2013 per una quota di oltre il 40% dei loro profitti annuali: . [4] Mentre scriviamo le relazioni politiche tra Usa e Russia sono sottopose a forti tensioni, a partire dal bombardamento americano contro una base aerea della Siria, controllata da Assad, sostenuto anche dalla forza bellica russa. Nonostante molti commentatori parlino di un possibile ritorno alla guerra fredda del secondo dopoguerra, riteniamo che tali tensioni siano più finalizzate a definire le gerarchie interne al nuovo asse geo-politico a nord del globo. Il cd. Russian gate sembra confemarlo.


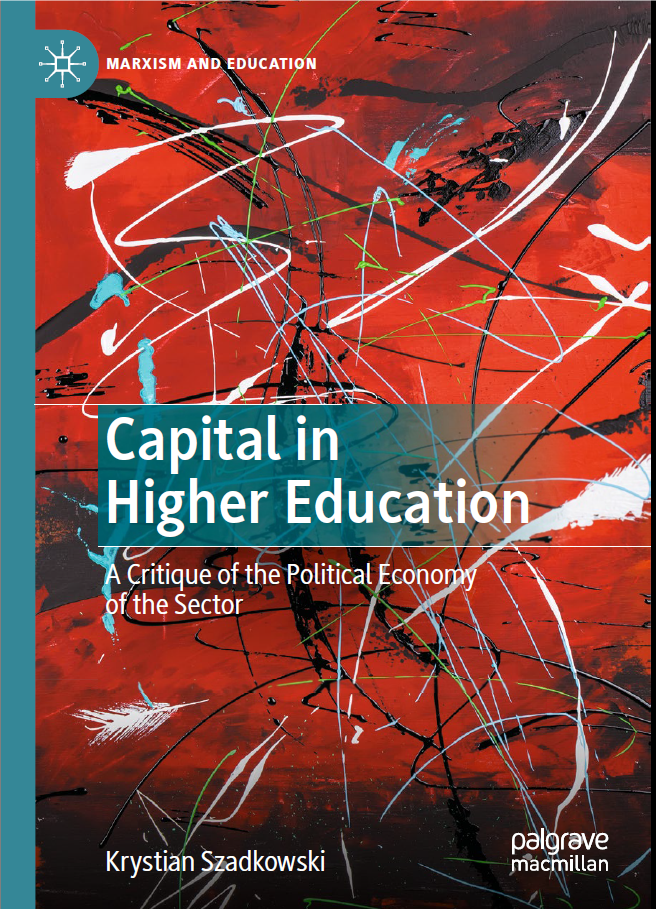





Scrivi un commento