Come le piazze e le flotille stanno riconfigurando lo spazio politico creando alleanze globali «dal fiume al mare»
Non si può comprendere quanto sta avvenendo in Palestina considerandolo come fenomeno isolato: essa riflette una crisi ecopolitica globale, dove guerre, logiche di profitto e meccanismi di controllo si intrecciano in un unico conflitto mondiale. Bisogna riconoscere e svelare i legami nascosti tra conflitti militari e strategie interne agli Stati occidentali: mentre a Gaza si moltiplicano i bombardamenti, nei Parlamenti e nelle piazze d’Europa serpeggiano nuove misure repressive che privilegiano la guerra a ogni discussione.
La guerra perpetrata da Israele è, tra le altre cose, una guerra delle immagini e dei discorsi. Oggi i media globali incanalano l’attenzione quasi unicamente sul lato israeliano e giocano sullo scandalo, mentre il vero massacro di Gaza rimane silenziosamente invisibile agli occhi di una parte del mondo. Questa disparità mediatica rivela una società del comando cognitiva: privilegia il dramma degli ebrei occidentali e marginalizza le vittime palestinesi. In tal modo si stabilisce una narrativa unilaterale, che legittima il genocidio e normalizza l’occupazione della Palestina.
I legami di “parentela” e solidarietà vengono deliberatamente erosi: in questi contesti le comunità vivono un progressivo deterioramento dei modi di vivere, con reti sociali ridotte al minimo. In un tale deserto umano, la complessità delle relazioni e della diversità viene appiattita, come se l’occupante volesse trasformare il mosaico delle culture in una superficie piatta e uniforme.
Intanto i governi occidentali semplificano tutto: l’emergenza è globale, ma le regole sono riservate a pochi. In Italia, il senatore Gasparri ha proposto un ddl che recepisce la definizione IHRA di antisemitismo includendo esplicitamente le critiche allo Stato di Israele. Il risultato è una legge di stampo fascistoide: anche un hashtag critico o un poster di solidarietà a Gaza possono diventare reati d’opinione. Il ddl introduce di fatto «l’intoccabilità di Israele», trasformando il dissenso in reato politico. Lo scudo ideologico serve solo a proteggere l’impunità del massacro in corso. In pratica, chi denuncia l’occupazione israeliana rischia grosso, piegando di fatto il diritto fondamentale alla libertà di espressione ai voleri di un regime nazistoide. È la manifestazione di una società del comando avanzata, dove persino la parola «apartheid» diventa tabù.
In Italia, nell’Unione Europea e negli USA si ripete la stessa logica securitaria. Negli Stati Uniti la retorica dell’“America forgiata da Lincoln” serve a coprire un accordo che consegna Gaza a supervisori stranieri, senza alcun riconoscimento dei diritti palestinesi. La giurista Shahd Hammouri ne spiega la nullità legale: «secondo il diritto internazionale, un accordo raggiunto sotto coercizione è nullo: il diritto palestinese all’autodeterminazione è inalienabile». Inoltre il piano «non fa alcun riferimento a questioni centrali, come il diritto al ritorno dei profughi»[1], e assegna la ricostruzione di Gaza a un organismo controllato da potenze occidentali. In pratica, cambia il nome ma non la natura del dominio: quello che si spaccia per pace è in realtà una nuova occupazione indiretta. Il progetto di Trump viene da lei definito come una «nuova forma di occupazione, diversa da quella israeliana ma pur sempre occupazione». In questo scenario la promozione del mito americano serve a occultare le vere intenzioni. Questa alleanza fra mito e potere trasforma la pace in un inganno: dietro la retorica del continente illuminato spunta sempre l’ombra del colonialismo.
Non è un caso che in Italia si cristallizzi l’intangibilità di Israele mediante leggi speciali, mentre negli USA la retorica della pace nasconde un’occupazione di fatto. Entrambi i casi sottolineano che la democrazia liberale si inchina al metodo autoritario quando è in gioco il tabù del colonialismo.
Nel modello dominante, le città sono reificate dall’urbanistica tecnocratica: lo spazio è trattato come “topologia astratta” da controllare attraverso piani e algoritmi. La visione urbana dei governi neoliberali – ma anche occupanti militari – tende a interpretare ogni problema sociale come un guasto spaziale da correggere. Lefebvre critica quest’“urbanistica come ideologia” che traduce tutto in termini spaziali: la povertà diventa emergenza abitativa, la contestazione diventa «tensione di un territorio», la presenza palestinese nelle strade è vista come disordine da normalizzare. Dall’Apartheid di Gerusalemme Est all’agglomerato della Striscia di Gaza, i piani spaziali dell’occupazione israeliana moltiplicano muri, checkpoint, buchi neri urbani, confinando i palestinesi in enclavi. Analogamente, nelle metropoli occidentali si diffondono zone rosse e politiche “di sicurezza urbana” (cancelli elettrici, polizia in tenuta antisommossa, videosorveglianza) che riconfigurano la città come spazio di separazione. Ma ogni città contiene anche un ordine prossimo «basato sulle relazioni immediate» che sfugge al potere centralizzato. Sono le reti informali di solidarietà, i comitati di base e i cortei spontanei a produrre quotidianamente un altro spazio. Questo spazio vivo è ciò che gli occupati e gli attivisti reclamano come “diritto alla città”: la possibilità di abitare e attraversare i luoghi senza permessi né paura.
La reazione statale a queste derive è feroce: le città occidentali si blindano con retate senza precedenti. A New York sono state arrestate centinaia di persone con l’accusa di ostruire il traffico. A Londra la polizia ha incriminato oltre 500 manifestanti che esponevano simboli di solidarietà palestinese, trattandoli come terroristi. Il tentativo di criminalizzare la solidarietà – bollandola come «estremismo» – tradisce la paura della forza che emergono dagli spazi popolari. In Europa e USA le leggi anti-protesta (dai decreti sicurezza allo spionaggio digitale degli attivisti) vanno di pari passo con la militarizzazione urbana: nei campus come nelle periferie si formano zone di esclusione, filtraggi di presenze indesiderate, pacchetti sicurezza che limitano la libertà di attraversare la città. Queste misure ribadiscono il concetto dominante: lo spazio urbano in rivolta deve essere catturato e normalizzato. Ma, come ammonisce Lefebvre, uno spazio si può dominare solo riducendolo al quantitativo – e da qui deriva la logica di “piani-scala” e modelli standardizzati che il militare e l’urbanista applicano sulle città ribelli. Ecco perché la strategia della repressione è in fondo la stessa: modellare il dissenso in gabbie concettuali (“terrorismo”, “illegalità”, “sovversione”), per poi confinare i corpi in celle di contenimento spaziale.
L’apparato mediatico e legislativo funziona come una strategia di cattura cognitiva: quando l’istituzione proclama “libertà”, in realtà definisce chi può davvero godere di quella parola. In tale cornice ogni protesta diventa sospetta, ogni mobilitazione solidale viene etichettata come estremismo. Da queste “leggi speciali” prende forma una dimensione di società del comando reale, dove l’illegalità è legittimata dal potere: come si intromette nelle nostre città la nuova guerra, così nelle nostre teste si infittisce la censura.
Il massacro in corso non è solo politico, è anche ecologico. Gaza è città di rovine, cimitero in terra viva. La nozione di Gaia, introdotta da Stengers, ci spiega che non si tratta solo di eroi o martiri: ogni forma di vita conta e reagisce. In questa visione, la tragedia di Gaza diventa una ferita planetaria, un crimine contro la biosfera stessa. Rodrigo Karmy Bolton la chiama mondocidio[2]: non è solo lo sterminio di un popolo, ma anche la distruzione di un intero ecosistema culturale, sociale e naturale. Ciò si coglie nella ferocia con cui il territorio è devastato: ogni albero e ogni pozzo raso al suolo diventa parte di un progetto di catastrofe.
Tale distruzione non è casuale, ma voluta dall’economia di guerra. A Gaza vi sono giacimenti di gas che potrebbero rimpiazzare quelli russi sul mercato europeo. Questa geoeconomia fa della pulizia etnica un affare di Stato. La crisi globale «coinvolge il tessuto sociale»: se Gaza muore, ne risente tutto il pianeta. Distruggere l’ambiente di Gaza significa intossicare il Mediterraneo e accelerare la catastrofe climatica, minando la stessa vita futura dell’umanità. La liberazione di una nazione si lega inevitabilmente alla riconquista del pianeta.
Gilles Deleuze ha messo in luce il cuore della questione: «Israele non ha mai nascosto il suo obiettivo, fin da principio: fare il vuoto nel territorio palestinese. Anzi, fare come se il territorio palestinese fosse vuoto, destinato da sempre ai sionisti»[3]. La pulizia etnica e la rimozione del popolo palestinese non sono episodi separati, ma parte integrante di questo piano. Il celebre slogan novecentesco – “una terra senza popolo per un popolo senza terra” – non è mai stato innocente: è la motivazione ideologica che si cerca di realizzare con ogni mezzo. Ogni villaggio raso al suolo conferma però un paradosso: un territorio non potrà mai essere «senza popolo», perché chi lo ha abitato continua a reclamarne la storia e i diritti.
Lo dimostra anche il caso di Marwan Barghouti, che, se fosse libero, riuscirebbe a mettere assieme i palestinesi di Gaza e quelli di Ramallah. Ed è per questo Israele lo considera un pericolo mortale. Tel Aviv sa che la vera minaccia non è la sua carcerazione, ma il suo rilascio: un fronte unito sotto Barghouti significherebbe affrontare un popolo che saprà come riconnettersi con l’ambiente politico ed ecologico oppresso. Questa paura dimostra proprio l’alleanza delle potenze in azione: meglio mille prigionieri divisi che un leader che ricolleghi le esistenze.
Negli scenari internazionali recenti, analoghe dinamiche si osservano al di fuori dell’area mediorientale. Ad esempio, il Premio Nobel per la Pace è stato conferito a María Corina Machado, venezuelana, filo-americana,di destra, oppositrice di Maduro. Già si fa notare che questo Nobel non è tanto un riconoscimento di pace, quanto un «investimento simbolico» volto a creare un volto presentabile per un cambio di regime[4]. Dietro l’apparenza moralistica si celano logiche geopolitiche ben note: si promuovono figure “rispettabili” per legittimare operazioni di sovversione (privatizzazioni, sanzioni, ingerenza militare) nei loro paesi. In sostanza, non si premia la pace ma l’imposizione di una nuova governance filo-occidentale. Questo caso mostra ancora una volta come alleanze ideologiche e poteri materiali si fondano: alle parole di pace occidentali vengono intessuti sottofondi economici (come il petrolio venezuelano) per consolidare il dominio. Qualsiasi ideale liberale può essere catturato dalla rete del capitalismo: l’importante è collocare ogni azione locale nel quadro di una resistenza globale e non cadere nelle trappole retoriche del “buonismo” politicamente orientato.
Di fronte a questo scenario, come possiamo rispondere? Facendo alleanza, cioè tessendo connessioni pratiche e teoriche inedite. La costruzione di un tessuto di solidarietà globale richiede innanzitutto di continuare a pensare e mettere in pratica azioni concrete. La chiave per far ciò è invertire la logica stessa della sottomissione.
Ecologie mentali, sociali e ambientali devono agire all’unisono. Non basta proclamare che «la vita è sacra»: bisogna proteggere attivamente l’acqua di Gaza, rigenerare i suoli avvelenati dai bombardamenti, restaurare quel che il capitalismo militare ha avvelenato: «lottare contro la stregoneria capitalista» vuol dire «lottare contro la barbarie a venire» e per farlo bisogna «comporre con Gaia». In altri termini, la crisi chiama a costruire alleanze che recuperino quel tutto di cui siamo parte. Non esiste salvezza parziale: riconquistare i diritti palestinesi significa anche resistere all’intero regime politico-economico che li ha calpestati.
Contro questa desolazione si sono prodotte e si continuano a produrre delle sacche di resistenza: ragazzi ebrei che manifestano per la fine delle guerre, migranti che vedono nella causa palestinese un nodo della propria lotta contro il razzismo europeo e le politiche imperialiste. Si tratta alleanze sociali “anomale” che costituiscono l’anticorpo alla narrativa dominante: sono esempi di ecologie di solidarietà in atto, oltre gli schemi imposti dai media: ogni nodo inatteso di solidarietà è un seme di potenza mutante.
Ogni situazione porta in sé dei «possibili possibili» direbbe Tarde. Ogni corpo sociale possiede una «potenza variabile» di agire, capace di fare certe cose anziché altre. Questo significa che la sconfitta non è predeterminata: ci sono sempre margini per cambiare il corso degli eventi. Se la macchina di guerra mostra il suo volto più feroce, la potenza di chi resiste non va data per spenta. Anzi, ogni ingiustizia può essere rovesciata in occasione di nuova liberazione, se la resistenza crea alleanze trasversali.
Nella pratica, si parla di cattura: i corpi, le idee e i territori si «compenetrano a vicenda, catturandosi reciprocamente». L’occupante cerca di interrompere ogni connessione tra Gaza e il resto del mondo – confinando e uccidendo i corpi e le menti – ma la resistenza reagisce incanalando quelle stesse connessioni altrove. Le reti di solidarietà sono catene di potenza, e le varie flotte partite verso la Palestina ce l’hanno dimostrato. Per esempio, gli appelli dei prigionieri palestinesi giunti fin qui in Italia, gli scioperi della fame globali per Marwan Barghouti, le manifestazioni in centinaia di città, la partecipazione di milioni di persone: tutti questi sono eventi in cui la potenza oppressa si libera di colpo. Ogni ferita inflitta, infatti, riemerge come impulso di lotta. La tortura, i bombardamenti e gli arresti diventano materiali di rivolta: il fuoco con cui Gaza accende la rabbia dei morti. Così agisce la cattura reciproca: l’oppressione tenta di privatizzare la realtà, ma le persone trasformano la violenza in comunità ampliata, risignificando l’odio in nuovi legami.
La crisi palestinese ha riportato alla ribalta la questione dello spazio urbano come luogo di lotta e di dominio. Le città sono ecologie urbane dove concetti quali eterotopia, produzione dello spazio e psicogeografia assumono un rilievo cruciale. Lefebvre ci ricorda che lo spazio sociale non è semplice contenitore geografico, ma un prodotto dei rapporti di produzione: ogni modo di produzione genera uno spazio configurato in modo specifico. In questo senso, la città riflette le tensioni del capitale e del potere, ma può anche divenire terreno di sperimentazione politica. Ne consegue che ogni mobilitazione urbana pro-Palestina mette in gioco non solo persone e slogan, ma l’intero regime spaziale costruito dalle classi dominanti.
Le manifestazioni per la Palestina trasformano le piazze in eterotopie temporanee: spazi di sogno concreto che contestano l’ordine esistente. Paradossalmente, lo stesso Foucault considerava la nave «eterotopia per eccellenza» perché apre l’immaginazione oltre i confini imposti. Le recenti flotte (Freedom Flotilla, Global Sumud Flotilla, ecc.) che hanno solcato il Mediterraneo, intrecciando tante parti del mondo, incarnano proprio questo spirito: navi cariche di solidarietà che sfidano il blocco navale di Gaza. La loro “traversata” crea un corridoio eterotopico via mare, dimostrando che il mare non è mai neutro ma teatro politico. Questi atti di resistenza marittima mostrano come i movimenti possano creare alleanze globali e legami – flussi di presenza nel deserto della repressione – esortandoci a immaginare e co-costruire altre ecologie dello spazio. In altre parole, anche attraverso l’acqua la resistenza traccia spazi di liberazione, portando oltre le mura dell’occupazione la lotta palestinese.
Le lotte via mare incarnano una trasformazione radicale del concetto di spazio di lotta. Le flotille si muovono in uno spazio liquido oltre ogni confine, fondendo ecologia e resistenza. Si potrebbe dire che viaggiare in mare induce ritmi d’onda in cui il dominio dell’identico viene sovvertito. Le imbarcazioni raccontano che il mare non è prigione, ma sede di alleanze internazionali umane e non-umane (l’alleanza col mare, col vento, con la musica, la bellissima immagine delle imbarcazioni seguite dai delfini). Viene ribadito il significato politico del mare aperto.
In termini spaziotemporali, le navi solidali creano paesaggi alternativi in cui popoli, oggetti, relazioni, affetti, solidarietà, fluttuano in una comunità di destino globale. Ogni rotta intrapresa sulle acque diventa un atto di sogno concreto: un’eterotopia nomade dove “esistere ancora” significa resistere alla cancellazione di un popolo.
Si tratta di fare una duplice critica: la teoria si fa battaglia e la battaglia non perde rigore concettuale. André Gorz sosteneva che ogni critica ha senso solo se inserita «nel contesto delle battaglie in corso». Allo stesso modo, possiamo vedere la nostra solidarietà come pratica intellettuale e militante insieme. Le manifestazioni in piazza, i blocchi stradali e le reti di informazione alternativa non sono più solo reazioni emotive: diventano esperimenti teorici/politici/pratici/rivoluzionari concreti. In essi si addensano nuove categorie politiche: la sfida è dire senza reticenze quello che la narrazione convenzionale vorrebbe sopprimere. Non basta ripudiare la guerra: bisogna agire perché sia ripudio di un sistema che su quella guerra si regge. Così le azioni quotidiane di giustizia – dall’occupazione delle ambasciate israeliane in Europa alla solidarietà diretta sul campo – diventano esse stesse forme di pensiero politico. La potenza risiede nel collegare il globale con il locale, il quotidiano con il cosmico.
Queste iniziative incarnano un nomadismo dell’agire: reti transnazionali che scavalcano muri e armamenti, mescolando energie resistenti. Lo sforzo di alleanza è urgente e radicale: la crisi ci obbliga a ripensare «il modo in cui la società è organizzata, su come si sta assieme e si fa alleanza». Non si tratta di trattati diplomatici tra Stati (che hanno tradito troppe volte), bensì di intese vive tra gli oppressi del mondo. La sfida è duplice: il pensiero deve essere all’altezza e l’azione deve essere radicale. Ogni riflessione acquista senso solo se ancorata alla lotta in corso. In questo modo possiamo costruire movimenti che siano anche scuole di pensiero: piazze dove si formino idee concretamente liberatorie.
Un approccio ecosofico ci permette di vedere ogni atto quotidiano come produzione di spazio e ogni gesto di dissenso come un contributo a “immaginare e co–costruire altre ecologie dello spazio”. Di fronte al corpo-carne del mio avversario, non dobbiamo evocare soltanto fantasmi insurrezionali, ma riconoscerlo parte di un tessuto sociale plurale. In questo senso l’ultimo progetto di un “futuro ecosofico” non può che essere nomade e generativo: costruire alleanze non gerarchiche nell’orizzonte diffuso.
Guy Debord insegnava che bisogna fare dell’esperienza urbana un’ecologia psichica, percorrendo la città con la tecnica della drift, abbandonando le mappe imposte e ri-scoprendo i territori nascosti. Paul Virilio rilancia: invita a smarrirsi apposta nella metropoli, a praticare una «sorta di libera fuga». E chi sta scendendo in piazza sembra proprio cogliere quest’invito. In un mondo governato dai flussi elettronici, Virilio denuncia come la vicinanza virtuale renda «meno significativo lo spazio fisico e l’incontro tra i corpi». Contro questa deriva tecnocratica, l’evento – l’incidente – può interrompere la routine quotidiana e far esplodere nuove percezioni dello spazio. I cortei e le manifestazioni per Gaza incarnano questa strategia: occupano piazze e ponti, creano “incidenti” urbani che scuotono la stasi sociale. Come osserva Virilio, smarrirsi in città è un’arte: imparare a perdersi insegnando a non essere meri passeggeri. Queste derive militanti rivelano nel tessuto urbano segni di trasformazione: ogni striscione rivoluzionario, ogni graffito di resistenza è una piega nel pavimento liscio dello spazio urbano. Nomadi dei nostri quartieri, gli agitatori intravedono «segni impercettibili di possibilità dell’esistere» dove altri vedono routine.
La vera alternativa alla cattura spaziale è una politica delle città che promuova alleanze trasversali, tenendo insieme dimensioni sociali, ecologiche e di liberazione collettiva. Qui si innesta l’approccio nomadico proposto da Guattari e Stengers: non dobbiamo seguire tracciati predefiniti, ma muoverci in “una rete di relazioni” che sottragga terre e corpi alle logiche del capitale. La solidarietà urbana pro-Palestina esprime un tentativo di “comporre insieme” differenze e traumi, tessendo una nuova cartografia politica. Riprendendo Deleuze si può imparare a pensare la città come “società di corpi differenziati”, in continua negoziazione, dove ogni marciapiede occupato diventa prologo di rivoluzione. Sebbene il quadro attuale sembri segnato dalla repressione (con la leva della tecnologia e della legge), la risignificazione del nostro spazio può essere pratica quotidiana di resistenza. Seguendo Debord, basta riprendere il possesso delle strade per ricreare continuamente spazi di libertà.
In questo spirito bisogna insistere: non avallare nessuna “pace” che resta reclusione, e aprire invece spazi utopici concreti. Gli spazi (e le pratiche) liberati dalla paura sono tanto una eterotopia politica quanto un laboratorio ecologico della resistenza nomade. Lì dove lo Stato teme l’alterità, va coltivata l’alleanza di tutte quelle differenze che rivendicano il diritto a un mondo altro – «dal fiume al mare», su ogni strada che attraversiamo – fino a rigenerare nuovi possibili.
Il sacrificio dei caduti palestinesi ha consacrato questo suolo con la loro forza di vivere; tocca a noi onorarli rendendo concrete le nostre parole. La retorica di pace senza giustizia non basta: Stengers direbbe che dobbiamo «comporre con Gaia, inventando collettivamente quello che sarà il collettivo e definendo la nostra ecologia in modo politico»[5]. In altri termini, non basta indignarsi: bisogna costruire un altro modo di stare assieme. Se continueremo a rimanere spettatori, il confine dell’apartheid diventerà definitivo. Non attendere la carità dei governi, ma sostituirla con la complicità fra i popoli. Solo così potremo inventare collettivamente nuove forme di comunità che sfidino il vecchio ordine. Questo è il compito che abbiamo: comporre un’alleanza ecopolitica globale, intrecciando ogni lotta in un unico grande movimento di liberazione.
E per inciso, casomai non si fosse capito, noi non solo rifiutiamo la «pace» imperialista imposta da Trump — esigiamo anche un cessate il fuoco immediato e incondizionato. Il cessate il fuoco non è una concessione diplomatica: è la condizione minima per ricominciare a vivere, curare i feriti e ricostruire relazioni spezzate. Senza lo stop alle bombe, alla produzione e vendita di armi, ogni discorso su ricostruzione, diritti o giustizia resta vuoto. Lo diciamo in memoria di chi è stato ucciso dalle bombe e per chi ancora resiste sotto le macerie: cessate il fuoco, ora. Noi continueremo a chiedere, a manifestare e a tessere alleanze finché il telo della morte non sarà sollevato — cessate il fuoco subito.
NOTE
[1] https://ilmanifesto.it/e-un-progetto-di-dominio-travestito-da-soluzione-politica
[2] https://www.dinamopress.it/news/il-mondocidio-della-palestina/
[3] Gilles Deleuze. “Grandezza di Yasser Arafat», ora in *Due regime di folli*, pubblicato in Revue d’etudes palestiniennes, 1984, n.10.
[4] https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/10/11/un-premio-nobel-senza-pace-0187556
[5] I. Stengers, Cosmopolitiche, pp. 654-655.





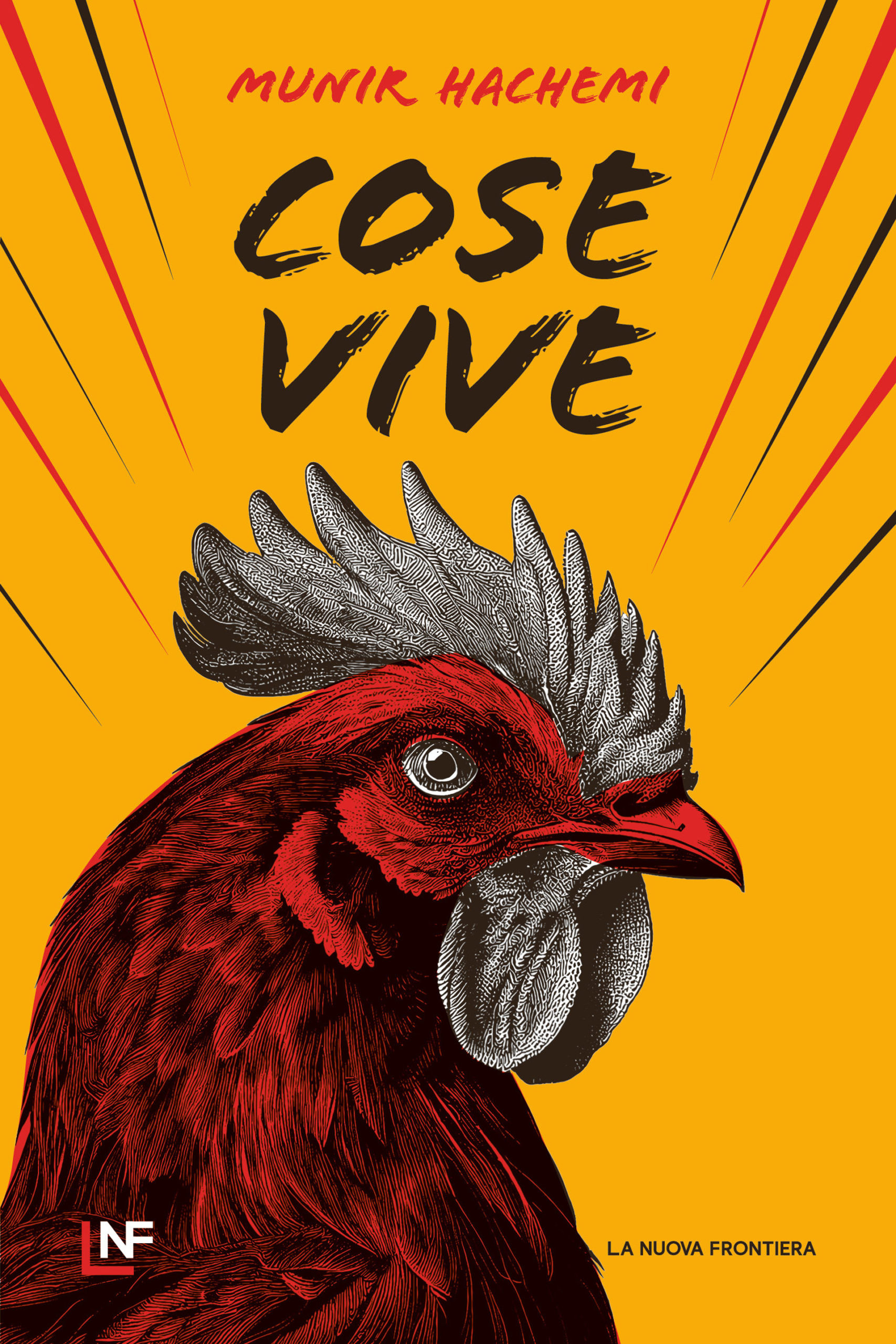

Scrivi un commento