“Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre …
Abbatti il futuro, se non ti appartiene”[1]
0. Ci sono parole che richiamano dei precisi stati d’animo estremamente duri da sopportare. Parole che investono l’esistenza sebbene la nostra mente sia propensa a metterle in disparte, abile come è a imporsi compiti apparentemente più urgenti, guidata dall’esigenza della razionalità, dalle necessità del momento o assuefatta dalla stanchezza. Eppure quegli stati d’animo stanno là, inamovibili, come inamovibili sono le condizioni che li determinano e che ci spingono verso un futuro che tendiamo ad accettare in modo inesorabile. I contenuti di alcuni libri usciti negli ultimi tempi, tra l’agosto 2018 e il gennaio 2020, offrono l’opportunità di una riflessione attorno a quattro parole pesanti – austerity, sfruttamento, alienazione, suicidio. Parole che possono gettare una luce sui nostri stati d’animo più reconditi.
1. Why auserity persists? Questa domanda sfiancante, che può suscitare noia o disperazione, a seconda della condizione delle nostre esistenze, è il titolo di un recente libro di Jon Shefner e Cory Blad (Polity Press, 2020). Shefner e Blad, sociologi impegnati rispettivamente nella University of Tennessee e al Manhattan College, analizzano diversi casi studio nel corso degli ultimi 45 anni, proponendoci una storia dell’austerity, intendendola – qui sta il punto di massimo interesse – come vero e proprio modo di regolazione, un insieme di politiche volte a governare diverse tipologie di crisi realizzando, o meglio imponendo, delle nuove strutture istituzionali.
Certo sono molte le strade che conducono all’austerity, ma gli autori sottolineano che lungo questi sentieri si incontrano prima o poi “tagli o congelamenti dei salari, specialmente per i lavoratori del settore pubblico; l’imposizione di nuove imposte, solitamente regressive; tagli alle spese sociali per il welfare; privatizzazioni degli asset nazionali. Il risultato coerente è l’immiserimento crescente di gran parte della popolazione, accompagnato dalla crescita della diseguaglianza in cui i redditi più alti aumentano e i redditi medio-bassi ristagnano oppure cadono” (p. 149, traduzione mia).
Pertanto con austerity dobbiamo intendere “un insieme veramente globale di politiche che sono state messe in pratica in risposta a diversi mali economici negli ultimi 45 anni” (p. 155, traduzione mia). Sui mali economici che avrebbero creato le condizioni per un’affermazione dell’austerity gli autori indagano in modo parziale. Si tratta chiaramente di un compito estremamente complesso, soprattutto se si vuole proporre una storia globale di un concetto operativo così ricco di sfaccettature; tuttavia, fra le tante domande legittime che questo libro invita a porsi ce n’è una che appare più rilevante delle altre: l’affermazione dell’austerity si deve o no ai limiti intrinseci del modello di crescita fordista e del modo di regolazione di ispirazione keynesiana che lo caratterizzava? Su questo terreno Shefner e Blad tacciono.
2. Risalendo indietro nel tempo per tornare agli anni in cui queste politiche vennero incubate, ci si può imbattere in una riflessione scomoda che venne proposta nell’ultimo libro di un economista italiano sui generis: Claudio Napoleoni. Il libro in questione è Discorso sull’economia politica, riproposto oggi in una nuova edizione nella collana Ecologia Politica dall’editore Orthotes (con un saggio introduttivo di Massimo Amato e Stefano Lucarelli e una postfazione di Dominique Saatdjan). Napoleoni nel 1985 è impegnato a riflettere non solo e non tanto sull’avanzata delle politiche neoliberali, ma sui limiti del riformismo: “il keynesismo è stata l’ossatura del riformismo. Il welfare state, infatti, ha acquistato la sua valenza politica specifica dal fatto che esso si poneva non solo come fornitore di servizi a una popolazione che ne aveva bisogno, ma anche come elemento di propulsione e stabilizzazione di un mercato privo, di per sé, delle forze occorrenti a conseguire e mantenere la piena occupazione. In una visione ‘ideale’ della politica economica, questi due aspetti avrebbero dovuto appoggiarsi e rafforzarsi a vicenda; la cerniera, per così dire, di questo reciproco rafforzamento sarebbe stata una [specifica] politica della distribuzione […] Al movimento dei lavoratori questo punto non è stato mai chiaro in quasi nessun paese del mondo. Quella condizione non è mai stata realizzata soprattutto perché le forze sociali e politiche interessate direttamente al riformismo non hanno saputo, o voluto, o potuto realizzarla: il welfare state e la politica, specificamente keynesiana della propulsione e stabilizzazione del mercato sono così entrati in crisi contemporaneamente, con una contemporaneità che è l’immagine di ciò che sarebbe dovuta essere la loro solidarietà” (p. 179). Nel Discorso Napoleoni sostiene che la forzatura della particolare condizione distributiva che poteva garantire la stabilità del modo di regolazione keynesiano è un risultato inevitabile delle stesse politiche riformiste: “non si tratta tanto, a proposito di fallimento del riformismo, né di idee confuse né di insufficiente volontà: si tratta piuttosto del fatto che né la piena occupazione né le provvigioni del welfare state (anche preso nelle sue forme migliori) sono in condizione di compensare i soggetti del fatto che essi, come soggetti produttori, sono totalmente assimilati a ciò che producono, cioè sono essi stessi prodotti; e del fatto, d’altra parte, che questa mancanza di compensazione si è finora espressa al più basso livello possibile, cioè come rivendicazione della massimizzazione dei consumi individuali, privati intesi come acquisizione di libertà indipendentemente dai risultati che la politica economica andava conseguendo su altri terreni. Si è trattato di un tentativo di sfuggire alla logica della produzione totalizzante […] Ma tuttavia un tentativo è stato. Il quale dunque si presenta in un duplice senso. Da un lato stabilisce l’origine del fallimento del riformismo in una zona più profonda di quella alla quale normalmente si pensa, e, appunto perciò, costituisce un ostacolo molto serio alle prospettive ‘illuministiche’ di ricominciare tutto da capo, come se non fosse successo niente. Dall’altro lato, può forse dare una conferma alla tesi […] che […] l’uomo e la società non sono riducibili senza residui (non si lasciano ridurre) alla pura produzione, che l’uomo sfugge alla pura identificazione con il Bestand, con il ‘fondo’. Alla tesi, in altri termini, che l’assolutizzazione del soggetto può portare alla sua catastrofe ma non al suo annullamento” (pp. 180-181). Come scrive Saatdijan nella sua postfazione al Discorso sull’economia politica: “Napoleoni si spinge fino a leggere il consumo non come il compimento, ma come un momento di una produzione che regge e ingloba tutto. Se di conseguenza, consumare è ancora produrre, allora l’essere umano è un lavoratore, cioè un produttore, anche quando consuma. In altri termini: nell’epoca della tecnica, il ‘lavoro’ assume un carattere totale e assoluto” (p. 190).
Perché allora l’austerity persiste? Non solo e non tanto perché non esistono forze sufficienti a contrastare l’iniqua distribuzione delle ricchezze, ma anche e soprattutto perché l’umanità non è capace di ripensare il senso del lavoro e della produzione fuori da una prospettiva alienante.
3. Ne La grande alienazione Lelio Demichelis (Jaca Book, 2018) mette fra loro in dialogo diversi autori di ieri e di oggi accomunati dall’attenzione rivolta ad un concetto solo apparentemente scomparso dalla scena: nessuno sembra alienato e nessuno si percepisce tale, sebbene l’alienazione sia sempre più pervasiva. Ma cosa è l’alienazione? Filosofi, sociologi, psicologi e persino esperti di organizzazione aziendale si imbattono in un concetto la cui complessità aumenta con il passare del tempo. Questo mi pare che emerga soprattutto dal testo laborioso di Demichelis: l’alienazione assume la fattispecie di un intralcio inaggirabile ogni qual volta si cerchi di affrontare il nesso problematico che lega tecnica e capitalismo. Un nesso incerto che non può risolversi – seguendo il Napoleoni del Discorso sull’economia politica – senza ridiscutere il rapporto di sfruttamento. Marx ricorre proprio allo sfruttamento per spiegare la dinamica propria del capitalismo. Ma quando – nell’epoca della tecnica – il lavoro assume un carattere totale e assoluto fuori dai luoghi tradizionali della produzione, fuori cioè dalla giornata lavorativa misurata attraverso un orario di lavoro e soprattutto fuori da una relazione salariale classicamente intesa, cosa ne è dello sfruttamento?
Questa domanda non è considerata tanto rilevante da coloro che ritengono che il saggio di sfruttamento sia riducibile al rapporto fra profitti e salari e che sia dunque possibile ridurre il grado di sfruttamento presente nella società attraverso una correzione nella distribuzione dei redditi. Per esempio in Revolution. Un mondo diverso è possibile (ombre corte, 2019) – pamphlet pensato come opportuno invito alla ripresa di un dibattito fra realtà politiche di base che pure, quasi venti anni fa nella stagione centrata su Genova 2001, avevano cominciato un confronto costruttivo – Pietro Vertova propone di coniugare una teoria dello sfruttamento ricavata da un Marx depurato dalla “linearità storica” hegeliana con la teoria della domanda effettiva di Keynes: “Il nocciolo della rivoluzione è il seguente: occorre ridurre progressivamente il saggio di sfruttamento inteso, marxianamente, come rapporto tra profitti e salari, in modo da allargare la domanda effettiva (in quanto la propensione al consumo dei salari è mediamente più alta della propensione al consumo dei profitti). Tramite questa costante redistribuzione, poiché dal punto di vista macroeconomico è la domanda che genera l’offerta, il PIL aumenta (…) Ci saranno evidentemente i cosiddetti ‘padroni’ e le forze politiche a cui essi si riferiscono che contrasteranno questa politica per mantenere la rendita di posizione minacciata dagli aumenti della domanda che genera più concorrenzialità sul mercato dei beni e sul mercato politico. Con la rivoluzione intrapresa si dovrebbe creare una sorta di selezione tra i capitalisti, a vantaggio degli imprenditori che si assumono il rischio di impresa e a svantaggio dei padroni che vivono con la loro rendita di posizione e che sono destinati all’eutanasia” (pp. 34-35). Lo scritto di Pietro Vertova mostra di per sé quanto al giorno d’oggi, in una situazione di ristagno successivo a un crollo della quota salari sul PIL (figura 1), possa apparire rivoluzionaria una proposta che in passato sarebbe stata definita riformista.
FIGURA 1- Quota percentuale dei salari sul PIL in Italia
Fonte: AMECO
Il nucleo analitico di Revolution – su cui Vertova, consapevole della rilevanza che in un mondo globalizzato assume il vincolo estero nella lotta distributiva, innesta la teoria dell’imperialismo di Hobson – ricorda molto lo schema concettuale sviluppato soprattutto nella seconda metà degli Settanta dagli economisti neoricardiani (si vedano innanzitutto gli interventi di Andrea Ginzburg & Ferdinando Vianello e di Pierangelo Garegnani apparsi su “Rinascita” rispettivamente nel 1973 e nel 1979).
Mi pare che la critica che Claudio Napoleoni rivolse agli economisti neoricardiani conservi una sua problematicità che anche Vertova farebbe bene a considerare: “Una definizione di sfruttamento comporta necessariamente l’identificazione di un nemico, lo sfruttatore appunto, dalla cui abolizione si ottiene una liberazione. Nelle condizioni del capitalismo, sembra evidente che il nemico non è il capitalista, e che anzi, se a nemico viene assunto il capitalista, si dà luogo (se si dà luogo) a un processo il cui termine abolito viene riprodotto sotto altra forma, per giunta assai più simile allo sfruttatore ‘signorile’ che non al capitalista […] l’inclusione di lavoratori e capitalisti entro la figura generale dell’assolutizzazione della produzione, o del dominio della cosa (si indichi o no tale inclusione col termine ‘sfruttamento’) serve a mettere in evidenza che il problema essenziale posto dal capitalismo non è un problema di espropriazione dei proprietari, e neppure quello dell’ ‘allargamento’ della proprietà del capitale a ‘soggetti’ che se siano stati finora esclusi, ma è quello della messa in questione del posto e del ruolo della produzione, al punto culminante di un processo storico che nella produzione, ossia nell’oggettivazione, ha ricondotto lo stesso soggetto produttore. Il mutamento del peso relativo, o del rapporto di forza, tra le due classi sociali, fino eventualmente all’abolizione di quella che si presenta come titolare della proprietà privata del capitale, non sono affatto, di per sé, cause sufficienti di un superamento dell’esito specifico determinato dal capitale nella storia, cioè la riduzione di ogni realtà, ‘soggettiva’ e ‘oggettiva’, a elemento di una disponibilità generale alla manipolazione tecnologica di una produzione in cui mezzo e fine coincidono. Il che non significa che mutamenti nei rapporti di classe, anche sotto il profilo della proprietà, non possano rivelarsi funzionali alla messa in questione della figura assunta oggi dalla produzione; ma significa che è solo in rapporto a questa funzionalità che quei mutamenti possono acquistare rilevanza teorica e pratica” (Critica ai critici, “La Rivista Trimestrale”, n. 3, 1986, oggi in C. Napoleoni, “Dalla scienza all’utopia”, a cura di G.L. Vaccarino, Bollati Boringhieri, 1992, pp. 199-200).
4. Da un’interpretazione dello sfruttamento inteso come miseria della quota salari prende le distanze Federico Chicchi che, nel suo Karl Marx (Feltrinelli, 2019), cerca di ripensare il concetto privilegiando un’analisi qualitativa che vuole fare innanzitutto i conti con la crisi della soggettività (ponendosi dunque sin da subito oltre Marx). Un libro agile e lineare nonostante l’autore ricorra a concetti psicanalitici che possono spiazzare il lettore. Da persona per bene, Chicchi avverte subito che il testo non ambisce “alla ricostruzione o all’interpretazione esaustiva del pensiero di Marx” ma offre un’“analisi di alcuni concetti marxiani che pensiamo essere indispensabili per la comprensione dei processi di trasformazione sociale del contemporaneo” (p. 9). Ne deriva innanzitutto una rappresentazione del capitale come “un organismo in continua trasformazione che risponde però ad alcuni presupposti (o assiomi) che non possono non ripetersi continuamente e che restano distanti dalla polemica contingente dei rapporti di forza storico-sociali che di volta in volta si producono al di sopra delle sue stratificazioni” (p. 12). Il percorso di riflessione proposto da Chicchi suggerisce che la crisi della soggettività non può risolversi senza assumere a fondo l’immagine dell’immane raccolta di merci. “E fin qui, però, niente di originale. Noi intendiamo aggiungere come la merce, in quanto si presenta come una fantasmagoria, un feticcio, un capriccio teologico, in altre parole in virtù della sua intrinseca spettralità, svolga l’irrinunciabile funzione di rendere articolabile e territorializzabile nel socius la pulsione fondamentale del capitalismo, pulsione che si produce, e quindi riproduce, attraverso l’estrazione di un plusvalore dal bios” (p. 99). Chicchi sembra voler risolvere il problema del valore a partire dalla comprensione della merce come feticcio e implicitamente suggerisce di esaminare il segreto del plusvalore (e dello sfruttamento) sostituendo al tempo di lavoro il concetto di godimento. Marx viene allora riletto usando innanzitutto il Lacan del seminario D’un Autre à l’autre (1968-1969) e giungendo ad una proposta originale: “Potremmo dire che la promessa di libertà che la merce contiene sia il suo fantasma fondamentale. È questo che, in effetti, la rende così ‘subdola’ ed efficace nell’impressionare i processi di soggettivazione del moderno (via forza-lavoro) e del contemporaneo (via denaro). Essa, infatti, implica nella sua fruizione/consumazione una falsa promessa: la possibilità di una tanto illusoria quanto concreta e paradossale traiettoria (per lo più inconscia) di soggettivazione, da un lato, ed emancipazione dal legame, dall’altro” (p. 103).
Chicchi, collocando la teoria del feticismo al centro del tema dello sfruttamento, cerca di mostrare come “lo sfruttamento sia sempre e comunque anche un metodo qualitativo di impressionare la vita in un certo modo” (p. 133). L’imprinting – concetto già introdotto in Logiche dello sfruttamento (ombre corte, 2016) – è un processo che contribuisce a produrre soggettività fuori dalla forma sociale del lavoro salariato sfruttando le componenti riproduttive della vita per generare plusvalore. Ma se ci chiediamo quali esempli eclatanti di imprinting reggono il processo di valorizzazione, che fattispecie concrete incontriamo? E cosa accomuna le soggettività distinte che agiscono secondo questa logica?
5. Già qualche anno fa, in Heroes. Suicidio e omicidi di massa (Baldini e Castoldi, 2015) – un libro dedicato all’instaurazione del regno del nichilismo e alla tendenza suicidaria che permea la cultura contemporanea – Bifo aveva fatto emergere la centralità dello sfruttamento delle energie mentali per spiegare la trasformazione essenziale prodotta dalla digitalizzazione del processo lavorativo: “il capitale non recluta più persone, ma compra pacchetti di tempo, separati dai loro portatori, che sono intercambiabili e occasionali… Il tempo necessario per produrre semio-merce è reso liquido dalla macchina ricombinante digitale. La macchina umana è lì, pulsante e disponibile, come una distesa cerebrale in attesa” (pp. 149-150). In questa narrazione il suicidio veniva spiegato come un effetto dello stress condiviso e dell’impoverimento emozionale. Carmelo Buscema si avventura lungo lo stesso crinale percorso da Bifo in modo autonomo, guadagnando una prospettiva inattesa. In Contro il suicidio contro il terrore. Saggio sul neoliberalismo letale (Mimesis, 2019) Buscema propone oggi una tesi scandalosa: il fenomeno contemporaneo di profusione globale del suicidio rappresenta la forma specificamente negativa del conflitto sociale. Il conflitto sociale “che ha attraversato la fase di ascesa, affermazione ed espansione mondiale del neoliberismo” sarebbe pertanto stato violentissimo ed esteso ma “proprio in ragione delle caratteristiche storiche in cui consiste la nuova irragionevole ragione del mondo, [ha] assunto principalmente la forma del gesto suicidale profuso su scala globale”, contribuendo decisamente “alla determinazione dei concreti rapporti di forza e potere che hanno caratterizzato la storia politica di questo periodo” (p. 79). Si avvista così una centralità politico-internazionale del suicidio che ha senz’altro a che fare con le modalità di sfruttamento e alienazione che si diffondono man mano che l’austerity si afferma come modo di regolazione, nel senso di Shefner e Blad, ma che rappresenterebbe l’altra faccia della repressione della conflittualità sociale; infatti l’insieme di politiche che caratterizzano l’austerity produce caos sistemico dal punto di vista geopolitico. Qui non possiamo entrare nei dettagli di questa originalissima ricerca interdisciplinare rafforzata anche da un’operazione critica di grande intelligenza. Buscema infatti utilizza politicamente le statistiche ricavabili dal Global Terrorism Database per mostrare due precisi cicli temporali nello sviluppo delle forme di lotta politica (dal 1970 al 1998 e dal 2005 ad oggi), svelare la faccia nascosta dei gesti suicidi concentrati nel secondo ciclo e leggere le implicazioni politiche dell’evoluzione storica che conduce dalla lotta armata al terrorismo suicida: “come nel caso del suicidio … la lotta armata divenuta terrorismo propriamente detto, finisce solo con il sortirne gli stessi fatali e fatui effetti dal punto di vista delle relazioni di potere – corrispondenti con il massimo di oggettivazione e di alienazione dei soggetti che lo compiono –, ma anche a produrre il massimo di beneficio per quelli che sui loro atti attivano la complessa teoria diffusa delle pratiche governamentali di evocazione e significazione più opportune, per poi farle valere soprattutto al fine di contrastare, con rinnovata forza e più efficaci strumenti, le istanze più sane e radicali del conflitto sociale” (p. 151).
Forse la propensione suicida è l’elemento che pericolosamente accomuna ed esalta le fragilità umane su scala globale in questi tempi in cui le nostre intelligenze corrono il pericolo di essere messe forzosamente a riposo. La lettura dei libri che qui abbiamo passato in rassegna può contribuire a mantenere viva la nostra attenzione, a tenere in esercizio il nostro pensare, ad abbattere le prospettive future che non ci appartengono. Sembra poco, ma non lo è.
NOTE
[1] Diaframma, Libra, “Tre volte lacrime”, IRA 1986.
Immagine in apertura, Alberto Burri, Rosso plastica, 1963




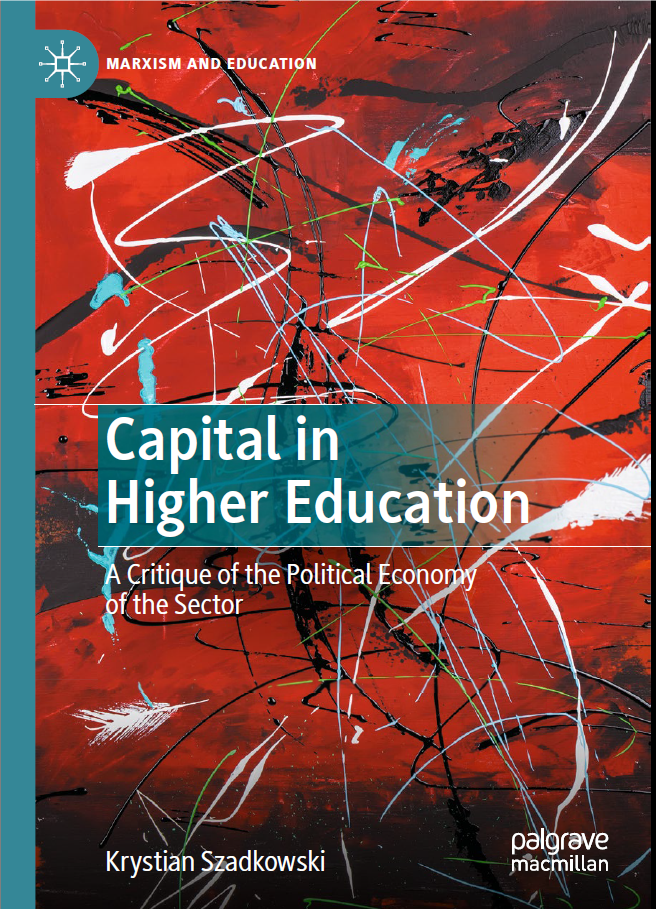




Scrivi un commento