Questo articolo traccia un’analisi genealogica degli eventi di Grenfell Tower, volta a rintracciarne il retroterra storico-politico ed ideologico. Il primo paragrafo fornisce una panoramica dettagliata degli eventi, mentre il secondo disegna in modo sommario la parabola della gentrificazione e dell’edilizia popolare nella Londra contemporaneo. La terza sezione, infine, tenta di portare alla luce i presupposti biopolitici di quanto accaduto prendendo spunto dall’eredità rimossa delle rivolte inglesi del 2011.
I
Due sterline. Pochi giorni dopo il rogo che il 14 giugno ha sfigurato Grenfell Tower, un edificio di edilizia popolare di 24 piani e 120 appartamenti situato a North Kensington, Londra, causando la morte di almeno 80 persone, sulla stampa britannica inizia a rimbalzare questa cifra. Due sterline. Questa la differenza di prezzo tra uno dei pannelli esterni infiammabili applicati nell’edificio durante la grande ristrutturazione della zona avvenuta lo scorso anno e la sua versione ignifuga, realizzata dalla stessa azienda. Di fronte all’enormità di una circostanza del genere passa in secondo piano anche il fatto che in verità il progetto iniziale approvato dai residenti prevedeva un rivestimento molto più costoso e sicuro di entrambi i prodotti, che sarebbe venuto a costare 293000 sterline in più nell’ambito di lavori dal valore complessivo di 8,7 milioni.
I pannelli esterni possono sembrare un dettaglio minore, ma già nelle ore interminabili in cui la London Fire Brigade tentava invano di estinguere le fiamme venivano chiamati in causa da tutti, costantemente. Testimoni oculari e vigili del fuoco descrivevano come il rivestimento della facciata sembrasse prendere fuoco ad una velocità impressionante, trasformando un incendio partito da un singolo appartamento in una trappola senza vie di fuga. Anche l’attenzione degli esperti è stata catturata da quell’immagine (e.g. Fu 2017).
Con i riflettori dei media arriva pure il ping pong delle responsabilità: gli architetti di Studio E, che hanno pianificato la ristrutturazione, si affrettano a dichiarare che i loro disegni includevano fasce tagliafuoco tra un pannello e l’altro. La ditta che vinto l’appalto, la Rydon, tiene a precisare che l’installazione dei pannelli è stata subappaltata alla Harley Facades, pur ammettendo sul proprio sito internet che il materiale che compone i pannelli, il Celotex RS5000, realizzato a partire da una lega di alluminio, “brucerebbe se esposto ad un fuoco di sufficiente calore ed intensità…rilasciando gas tossici durante la combustione”. Il 19 giugno il cancelliere dello scacchiere, Philiph Hammond, prova ad incanalare la vicenda sul binario morto della semplice negligenza di un contractor, dichiarando alla BBC che, alla luce degli elementi in suo possesso, quel materiale sarebbe illegale nel Regno Unito. Evidenze successive paiono averlo smentito: il composto è ancora certificato come sicuro dal British Board of Agrément e la società che lo produce, la Saint Gobain UK, ha interrotto la produzione di propria sponte soltanto dopo il rogo. Il suo direttore tecnico, Mark Allen, è addirittura membro del Building Regulations Advisory Committee, un ente pubblico incaricato di fornire consulenze in materia immobiliare al ministro per gli enti locali.
La vicenda dei pannelli è solo la punta di un iceberg. Insieme alle immagini dell’esterno di Grenfell Tower che brucia come un’enorme torcia nonostante l’arrivo pressoché immediato dei pompieri, le televisioni iniziano a riportare che un’associazione di residenti della zona, il Grenfell Action Group, tiene da anni un blog pieno di allarmi e ammonimenti sul mancato rispetto degli standard di sicurezza nell’edificio. Colpisce particolarmente un post datato 20 Novembre 2016, che comincia così:
«È un pensiero davvero terrificante, ma crediamo fermamente che solo un evento catastrofico porterà alla luce l’inettitudine e l’ incompetenza del nostro locatore, la KCTMO
Appena un mese prima della catastrofe, i residenti avevano espresso le proprie perplessità a KCTMO, che gestisce il complesso per conto della municipalità (local council), in riferimento alla presenza di un’unica uscita di emergenza in caso di incendio, all’assenza sia di un sistema di allarme unificato in tutto lo stabile che di un impianto di estintori a pioggia (sprinklers), al posizionamento inopportuno delle condutture del gas ed allo stazionamento di pile di immondizia potenzialmente infiammabile appena fuori la torre. Judith Blakeman, un membro del local council, aveva richiesto senza successo nei mesi precedenti delle ispezioni indipendenti in materia di sicurezza, presentando 19 reclami a nome di singoli inquilini. Il board della Tenant Organization – la stessa che lo scorso anno ha avuto un richiamo formale dai vigili del fuoco per un’altra proprietà sotto la sua giurisdizione, Lonsdale House – si era sempre opposto a queste richieste, dichiarandosi soddisfatto del livello di sicurezza esistente.
Nello stesso periodo due donne morte nella strage, Mariem Elgwahry e Nadia Choucair, avevano organizzato una grigliata condominiale per coinvolgere gli inquilini nelle loro campagna per migliori standard antincendio. Secondo diverse testimonianze, il tasso di adesione alla petizione immediatamente successiva sarebbe stato intorno al 90%. Neanche le minacce di azioni legali da parte di KCTMO – che non ha voluto rilasciare commenti in merito – e la mancanza di risultati tangibili le avevano fatte desistere.
Eppure siamo ancora ai fatti recenti. La storia di Grenfell Tower, esempio di social housing risalente ad un’epoca (1974) in cui lo stato ancora si impegnava nell’edificazione di alloggi ad affitto controllato, potrebbe essere fatta partire da molto prima. Magari dal report pubblicato nel 1999 dall’ Environment, Transport, and the Regions Committee che metteva in guardia contro i rischi di rivestimenti simili a quelli adoperati nella torre. O da quel maledetto 3 Luglio 2009 in cui 3 donne e altrettanti bambini persero la vita nell’incendio di un’altra casa popolare londinese, Lakanal House, e per il quale lo scorso febbraio il Southwark Council ha patteggiato una multa da 270000 sterline per violazioni del Regulatory Reform Safety Order. E perché non dal 2012, quando l’incaricato della sicurezza antincendio a Grenfell consigliava a KCTMO di seppellire il proprio rapporto tra le scartoffie, per evitare che le mancanze rilevate risultassero in un’indagine della London Fire Brigade? Un altro punto di partenza potrebbe essere il 2013, l’anno da cui i ministri competenti hanno avuto sul proprio tavolo documentazione necessaria a dimostrare l’urgenza di una riforma degli standard antincendio (ancora nell’Ottobre 2016 il ministro uscente all’edilizia, Gavin Barwell, ribadiva la volontà dell’esecutivo di intervenire sulle Bulding Regulations varate nel 2010 – dichiarazione a cui non hanno fatto seguito riscontri).
Ma nemmeno tutti questi episodi sono abbastanza. Non restituiscono il contesto che ha reso possibile quanto accaduto, non ne illuminano il significato. Non si tratta di andare alla ricerca di strampalate teorie del complotto, tutt’altro – cos’è il complottismo se non un dispositivo per la riduzione della complessità, la volontà geometrizzante di smussare gli angoli più acuti della realtà? Non è nemmeno il caso di contrapporre il presunto rigore asettico dell’analisi all’approssimazione ritenuta propria dell’emozione. Il rogo del 14 giugno deve suscitare emozioni – e forse una su tutte: rabbia.
Se focalizzata con precisione la rabbia, scriveva Audre Lorde in The Uses of Anger (1981), può diventare una fonte di energia in vista del cambiamento – e non un cambiamento dato da qualche sorriso o dalla capacità di sentirsi bene, aggiungeva, ma “una radicale alterazione di tutti gli assunti di fondo delle nostre vite”. Occorre forse, allora, una balistica della rabbia, una riflessione che non rinneghi lo sdegno per ciò che è successo ma anzi lo abbracci, facendone uno strumento ottico anziché una cortina fumogena.
Da dove iniziare? Forse proprio dai nomi delle persone scomparse. Un elenco provvisorio e ancora drammaticamente parziale, certo, ma capace di rappresentare un semplice fatto: molte delle vittime appartenevano a minoranze etniche. A questo si aggiunga un altro elemento, relativo alla natura popolare dell’edificio: i suoi abitanti non avrebbero potuto permettersi di vivere in nessun altro luogo in quella zona. Due circostanze da tenere a mente.
II
Nel comunicato diramato dalla Rydon a seguito della ristrutturazione di Grenfell Tower una funzione dei nuovi pannelli esterni viene particolarmente sottolineata, e non è l’isolamento termico che pure (ironia della sorte) avrebbero dovuto svolgere a detta dei progettisti. Si tratta di un rilievo estetico rispetto al miglioramento della vista dalle aree limitrofe. Un’osservazione analoga è rinvenibile in un documento relativo alla pianificazione dei lavori ottenuto dall’Independent, dove si osserva che “I cambiamenti […] miglioreranno l’apparenza della torre e specialmente la sua vista dall’area circostante”. La scelta dei materiali, in questo senso, era stata improntata all’armonizzazione “del carattere e dell’apparenza” dell’area ed alla preservazione “delle condizioni di vita di coloro che vivono vicino il sito”. Le persone in questione sono le proprietarie di alcune degli alloggi più costosi di Londra, le stesse che in alcuni casi nei giorni successivi dichiaravano alla stampa di non volere che gli sfollati della torre venissero provvisoriamente ricollocati nei pressi delle proprie lussuose aree residenziali. Il Washington Post ha definito la torre “una contraddizione del quartiere”, simbolo di un sistema di welfare tramontato da decenni nel neighbourhood più costoso della città (cfr. London’s Poverty Profile 2015), in cui una casa arriva facilmente a costare svariati milioni. All’interno della stessa Kensington si avverte una divisione crescente tra la zona nord (dove sorge Grenfell Tower) e quella posta a sud, tra le più prestigiose della capitale. Non si tratta di un dinamica di vicinato, ma di fenomeni che da decenni interessano l’intera città – e, in una certa misura, il paese.
È riferendosi a Londra che Ruth Glass (1964: xviii) coniò, ormai mezzo secolo fa, il termine gentrificazione – che stava ad indicare come nelle zone centrali molti quartieri in precedenza abitati dalla working class venissero rapidamente ripopolati e trasformati dalla upper e lower middle class. Le spiegazioni classiche della gentrification, tra loro parzialmente compatibili, sono due. Una si concentra soprattutto sulle opportunità per l’accumulazione di capitale (Smith 1979): in determinate zone di una città viene a crearsi un gap tra il valore basso degli immobili e quello più alto e potenzialmente crescente del terreno su cui essi sorgono, principalmente grazie alla sua posizione nel tessuto urbano. Di qui una spinta ad investire nel rinnovamento edilizio che conduce alla conversione degli alloggi o alla loro demolizione per far posto ad altri. In entrambi i casi, i residenti originari faticheranno a potersi permettere di rimanere nella zona a fronte dell’aumento dei prezzi.
La seconda lettura, più incentrata sulle trasformazioni interne alle diverse classi sociali, concepisce la gentrificazione come il corrispettivo urbano del passaggio da un’economia industriale ad una postindustriale, che determina un aumento nella domanda di alloggi da parte della classe media in espansione (Hamnett 2003) – alla fine degli anni ’90 a Londra solo l’8% della popolazione era impiegato nella manifattura, mentre il 32% lavorava nella finanza o nei business services, uno scenario molto diverso rispetto a solo due decenni prima (Ivi: 2404-2405).
La conseguenze della gentrification sulla città sono state molteplici, su tutte il trasferimento più o meno forzato di quote non indifferenti della popolazione al di fuori di aree diventate rapidamente al di sopra delle proprie possibilità (e.g. Atkinson 2000), con la rottura di reti di vicinato spesso pluridecennali e le relative difficoltà di reinserimento soprattutto per alcuni gruppi – ad esempio gli anziani (Ivi: 314). La mutata estrazione sociale dei residenti di un quartiere stimola poi un riassetto della sue economia, portando talvolta ad una diminuzione sia quantitativa che qualitativa di quei servizi pubblici (trasporti, biblioteche…) utilizzati prevalentemente da persone a basso reddito (Ivi: 320-321). In modo analogo, si sono osservati casi di isolamento sociale dei gentrifiers, che a volte vivono quasi separati dalla popolazione non appartenente alla classe media – ad esempio iscrivendo i propri figli in scuole più quotate situate al di fuori del quartiere (Butler 2003). (Un discorso a parte meriterebbe il tema della speculazione edilizia, troppo vasto per essere affrontato in questa sede, che fa sì che oggi molti spazi nel centro città siano tenuti forzatamente disabitati).
Kensington è stato un apripista di queste tendenze, vivendo già nel decennio 1981-1991 un significativo calo nella percentuale di residenti appartenenti alla working class, nonché un netto aumento dei proprietari rispetto agli affittuari (Atkinson: 312). Con molto anticipo rispetto ad altre aree, il quartiere vive già da tempo gli effetti di quella supergentrificazione divenuta recentemente osservabile in ambito cittadino: in alcune parti di Inner London ormai nemmeno la classe media può più permettersi di vivere (Economist 2013). Londra è oggi una citta in piena emergenza abitativa, dove può succedere che il prezzo dell’alloggio medio cresca di 50000 sterline da un anno all’altro (Dorling 2014: 102), nonché la più diseguale del Regno Unito, con il 40% di bambini che vivono in famiglie sotto la soglia di povertà – contro il 20% della media nazionale (Ivi: 107).
Se questi dati forniscono una ricostruzione più ampia, l’immagine che restituiscono è ancora straordinariamente priva di attrito, quasi che la realtà urbana sia il mero risultato di fluttuazioni nell’offerta e nella domanda di alloggi, o di ingovernabili ed endemici cambiamenti nella struttura socioeconomica di un paese. Per avere un quadro più realistico occorre aggiungere il ruolo delle politiche pubbliche intervenute nel corso dei decenni, in particolare sul fronte di quell’edilizia popolare che pochi anni fa l’Economist descriveva come il bersaglio di una nuova fase di gentrificazione e del cui fallimento Grenfell Tower è divenuta, suo malgrado, un simbolo.
Nel 1979 il 42% dei britannici viveva in case di proprietà dei local councils, oggi meno dell’8 (cf. Woodward 2010: 10). Nel secondo dopoguerra il Regno Unito è stato uno dei paesi europei che più convintamente hanno puntato sull’edilizia popolare e per decenni governi di entrambe le maggioranze hanno costruito centinaia di migliaia di abitazioni l’anno (elaborazione BBC 2015 su dati ministeriali). La fine degli anni ’70 segna anche il principio di una brusca inversione di tendenza con l’avvento della serie di esecutivi conservatori guidati da Margaret Thatcher prima e John Major poi. Nel corso dei diciotto anni di egemonia dei tories, la costruzione di alloggi popolari fu virtualmente azzerata, mentre il numero di famiglie ‘involontariamente senza fissa dimora’ passò da 53000 a 149000 durante il solo periodo di Thatcher (Hodkinson e Robbins 2013: 62) – e l’idea stessa che esista una categoria statisticamente significativa di homeless volontari (i cui confini definitori furono peraltro allargarti dall’Housing Act del 1996) riassume in una singola aberrazione l’enorme smottamento ideologico che i conservatori furono in grado di imprimere in tempi relativamente brevi.
Con la politica del Right to Buy venne effettuata una colossale operazione di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Circa un quarto dell’intero stock venne venduto a condizioni agevolate ai precedenti affittuari, ma per molti anche i prezzi d’occasione rimasero inaccessibili. Se nell’immediato una misura di questo tipo favorì alcuni settori della working class, il combinato disposto di privatizzazione e blocco della realizzazione di nuove strutture destinate al social housing, per giunta in un contesto di crescenti disuguaglianze sociali, costituiva una bomba ad orologeria destinata ad esplodere nel giro di una o due generazioni. Anche le analisi più prudenti riconoscono oggi gli effetti collaterali del Right to Buy, come ad esempio la polarizzazione tra aree residenziali più e meno benestanti e l’impulso alla gentrificazione laddove non tutti gli abitanti del luogo riuscivano a comprare la casa popolare che avevano preso in affitto (e.g. Kleinhans a Van Ham 2013: 112-113).
La tendenza non venne invertita dal New Labour. All’indomani della vittoria elettorale del 1997, Tony Blair si recò all’Aylesbury Estate, nella zona meridionale di Londra, uno dei più grandi complessi di edilizia popolare costruiti negli anni ’60, dipingendo la sua popolazione come tra le più povere d’Inghilterra, senza un vero ruolo nell’economia formale e dipendente dai sussidi. Negli anni successivi
Aylesbury divenne l’emblema dello spostamento a destra dei laburisti (Lees 2013): il New Labour’s 2000 Decent Homes Standard stabiliva requisiti qualitativi più elevati per il social housing, ma senza stanziare i fondi necessari; nel 2001 i residenti, pur insoddisfatti per il crescente degrado di edifici bisognosi di ristrutturazioni e ammodernamenti, si opponevano nettamente con un referendum locale all’ipotesi di privatizzazione; è il 2005 quando il Southwark Council (lo stesso di Lakanal House) decide che il complesso è troppo vasto per far fronte ai costi di ristrutturazione, optando per la demolizione e l’edificazione di un nuovo sito nel quale solo il 40% delle case sarebbero state popolari. Nonostante i tentativi di opposizione locale, che hanno cercato di contrastare alla meglio anche l’immagine apocalittica del vicinato frutto di alcune esagerazioni mediatiche cavalcate dalla politica, al giro di boa del decennio la zona era già di fatto condannata, con un destino analogo rispetto al vicino ed altrettanto celebre Heygate Estate (cf. Lees e Ferreri 2015).
Tra il 2008 e il 2010 sia Londra che il Regno Unito hanno visto il ritorno dei conservatori, con conseguenze visibili a tutti i livelli. Nel 2011 l’allora sindaco Boris Johnson elimina anche la quota minima di alloggi popolari ad Aylesbury, rimettendola al council, mentre in ambito nazionale il recente Housing and Planning Act obbliga le autorità locali a vendere gli edifici situati in zone ad “alto valore” per incrementare il numero delle abitazioni di proprietà.
Con David Cameron al governo è possibile dare l’ultimo colpo di spugna: da vanto dello stato sociale il social housing è ormai rappresentato o come un ricettacolo residuale di derelitti, l’ultima spiaggia di coloro che non hanno altra possibilità se non di gravare sulla collettività, o in quanto rendita di posizione di ‘truffatori’ del welfare ormai non più bisognosi di assistenza. Inutile dire che entrambi i capi della narrazione non reggono il confronto con l’evidenza, visto che le dimensioni del secondo gruppo sono al più assai modeste ed il primo non svolge un ruolo parassitario, che l’edilizia popolare è solo uno dei molti ambiti di politica immobiliare a ricevere sussidi e che le liste di attesa sono enormemente cresciute, con circa 4 milioni e mezzo di persone che hanno fatto richiesta di un alloggio ad affitto controllato (Hodkinson e Robbins: 69). Tra il 2011 ed il 2015 la già martoriata voce di bilancio corrispondente è quasi dimezzata rispetto al quadriennio precedente, passando da 8,4 a 4,5 bilioni di sterline. Oltre all’importo dei sussidi (-20% dello stesso frangente) si riduce anche la loro durata: un tempo potenzialmente vita natural durante, ora garantiscono diritto ad un alloggio per soli due anni in un sistema ormai basato prevalentemente su modesti benefit concessi per l’affitto di edifici privati.
Non c’è forse ambito nel quale la spettacolare ipocrisia di un celebre slogan elettorale dei tories, “We are all in this togheter” (Ci siamo dentro tutte/i insieme), sia più manifesta di quello delle politiche urbane. Le cifre impietose non sono il portato di un qualche destino cosmico, ma l’esito di precise scelte compiute negli ultimi decenni. Non è un caso che gli inquilini di Grenfell Tower provenissero dalle categorie più vulnerabili della popolazione, quelle costrette ad aggrapparsi ai brandelli di servizi pubblici ormai drammaticamente insufficienti. Il tutto in un contesto divenuto ostile, dove la vecchia facciata di un edificio pubblico va opportunamente rivestita per non offendere il senso estetico di chi può permettersi un’altra vita.
Questo excursus aggiunge parti importanti al contesto del rogo del mese scorso, ma dice ancora troppo poco rispetto alla resistenza contro le ripercussioni urbane di una diseguaglianza sempre più stridente. In tal senso, c’è un grande rimosso nella storia britannica recente, che molti sembrano aver paura anche solo di menzionare.
III
Ogni dramma, si sa, ha bisogno del suo eroe. David Lammy sembra la figura perfetta. Giovane parlamentare di colore eletto nelle file del Labour di Jeremy Corbyn, nell’incendio della torre ha perso un’amica, l’artista Khadija Saye. Sono trascorsi pochi giorni dalla catastrofe quando Lammy fa appello al primo ministro May affinché requisisca tutti i documenti che potrebbero risultare rilevanti per il lavoro degli inquirenti sulle cause del rogo e le responsabilità in gioco. Sostenendo di parlare a nome dei superstiti di Grenfell, Lammy ha espresso il timore che le ditte subappaltatrici della ristrutturazione possano insabbiare le indagini.
Per chi ha una qualche familiarità con i conflitti urbani nel Regno Unito, il nome di David Lammy non è nuovo, ma legato a doppio filo ad uno degli eventi più fraintesi degli ultimi anni, vale a dire le rivolte dell’agosto 2011. Quando la notte del 6 agosto, un sabato, si creano dei disordini fuori da una caserma della polizia a Tottenham, un quartiere di Londra, l’opinione pubblica non si aspetta nulla di quanto seguirà. I giornali dell’indomani menzionano appena l’accaduto, l’Observer contiene un articolo a pagina 11. Nell’afa un po’ soporifera di un weekend estivo, tocca ad un politico locale rilasciare le prime dichiarazioni alle televisioni. Lammy non ha dubbi: i rivoltosi sono persone irrazionali (mindless), dei criminali non provenienti dal quartiere ma da zone più lontane, spinti dal consumismo e dalla cultura delle gang. Quei primi commenti verranno fatti propri in modo bipartisan dall’establishment, ma non graffiano nemmeno la superficie della realtà.
Il 4 di quel mese la polizia aveva ucciso nella stessa zona un ventinovenne nero, Mark Duggan, in circostanze poco chiare. Nei due giorni seguenti le forze dell’ordine non trasmettono nessuna informazione alla famiglia, nonostante ripetute richieste. Fuori dal commissariato più vicino viene quindi organizzata una protesta pacifica. Gli agenti chiedono ai manifestanti di attendere l’arrivo di un ufficiale perché in quel momento nessuno può fornire loro chiarimenti sull’accaduto. Le ore passano, non arriva nessun funzionario ad intavolare il dialogo, la piccola folla radunatasi non demorde e intona dei cori. Una situazione tesa, ma non particolarmente preoccupante. Poi accade l’imprevedibile, qualcosa che comincia a far scorrere il film degli eventi ad una velocità doppia rispetto al normale: la polizia prova a disperdere i manifestanti con la forza, colpendo tra l’altro due donne disarmate, e la folla reagisce. Spinte reciproche, lancio di oggetti, non passa molto che alcune vetture di servizio siano bruciate. Nei successi tre giorni le rivolte, i saccheggi, gli incendi si diffondono prima in altre aree di Londra (come Hackney, Croydon, Ealing), poi in alcune città inglesi.
Il bilancio è pesante: 5 morti, numerosi feriti e centinaia di milioni di danni sono il risultato di sommosse improvvise, apparentemente scoordinate fra loro, che di solito non durano più di qualche ora. Le autorità devono fornire spiegazioni, il paese intero cerca modi per razionalizzare l’accaduto. Iniziano così a fare breccia nell’immaginario collettivo, sin dalla prima presa di posizione di David Lammy, tre interpretazioni mitiche: i protagonisti dei disordini sono criminali puri e semplici, persone che delinquono per il gusto di farlo; la folla è intrinsecamente irrazionale; un manipolo di infiltrati ha manovrato a piacimento la massa inebetita (Richer e Scott 2011: cap. 3).
La gran parte degli studi realizzati ad oggi su quelle giornate di agosto ne sottolinea invece le radici urbane lungo due principali direttrici già operanti nell’area da cui tutto partì, quel borough di Haringey all’interno del quale sorge Tottenham. Haringey è la tredicesima zona più povera d’Inghilterra, con una forte presenza di minoranze etniche. Nel Gennaio del 2011 il local council annuncia, a seguito di un taglio di 41 milioni, una diminuzione del 75% nella spesa per servizi rivolti ai giovani (doposcuola, centri ricreativi, assistenza alla ricerca di lavoro). Durante i mesi più caldi la popolazione giovanile si riversa in strada per mancanza di alternative. La polizia vede nel fenomeno la fonte di un possibile aumento della criminalità ed esegue 6894 fermi tra aprile e giugno – in 6807 casi senza alcun esito penale. Nel Regno Unito la probabilità che una persona di colore sia oggetto di una operazione di questo tipo è 26 volte maggiore rispetto a quella di un individuo bianco (Richer e Scott: cap.4 per gli ultimi dati). Ecco che le due dinamiche iniziano a divenire chiare: l’insieme di tagli e metodi polizieschi percepiti come fortemente discriminatori attua quella che Wacquant (2009: 6) definirebbe la simbiosi neoliberista tra la mano invisibile del mercato e il pugno di ferro dello stato. La morte di Mark Duggan non è che la goccia che fa traboccare il vaso.
Lampi di violenza a prima vista sconnessi incominciano così a restituire un senso all’agire apparentemente casuale dei manifestanti: chi partecipa alle rivolte proviene di solito da aree urbane economicamente svantaggiate ed in cui il comportamento della polizia è ritenuto vessatorio (Kawalerowicz e Biggs 2015) – il che spiega perché forze dell’ordine ed edifici pubblici siano stati tra i principali bersagli delle violenze (cfr. Richer e Scott; Sutterlüty 2014).
La città assume in questo contesto il ruolo di spazio in cui le politiche pubbliche decise a livello nazionale impattano in modo abrasivo sulla pelle di alcuni settori della popolazione, nonché di luogo dove il potere poliziesco viene sempre più utilizzato come strumento di repressione del malcontento sociale. La risposta ai fatti del 2011 è in tal senso da manuale. Da un lato, una reazione spropositata sul piano criminale: 3100 persone portate a processo in un anno, con una condanna media di 17 mesi per reati per i quali solitamente se ne comminano meno di 4 e sentenze volutamente esemplari (6 mesi di reclusione per aver rubato bottiglie d’acqua per un valore di 3 sterline e mezza; 16 mesi per un furto di ciambelle) (Lamble 2013). Dall’altro, un’ulteriore esasperazione degli inneschi materiali dei disordini: nel 2014 l’Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act consente di espellere dal sistema di social housing coloro che abbiano commesso reati nell’ambito delle rivolte. Si tratta di una misura fortemente discriminatoria (si applica solo agli atti compiuti durante una rivolta ed a nessun altro crimine), che fa a pugni con i fondamenti del diritto penale (è sufficiente che un solo componente di un nucleo familiare, anche minorenne, si sia macchiato di una delle infrazioni di cui sopra per far sì che tutta la famiglia possa essere sfrattata) (Young 2016).
Se non si può negare che i riots del 2011 abbiano costituito un modo tutt’altro che proficuo di indirizzare la rabbia politica, con degli esiti in termini di vite umane che non possono essere ignorati, la miopia delle reazioni tanto dei conservatori quanto dei laburisti – compreso chi oggi prova, magari in buona fede, ad ergersi a paladino delle vittime di Grenfell – resta stupefacente.
E dire che sarebbe bastato prestare attenzione alle numerose dichiarazioni raccolte tra i rivoltosi: come evidenzia Sutterlüty, tra le autorappresentazioni più ricorrenti c’è quella che concepisce i riots sotto forma di rivalsa nei confronti di uno stato giudicato come traditore della supposta eguaglianza tra i cittadini – quando invece certi quartieri sono allo sbando, mancano i servizi e la polizia sembra talora fare di un razzismo strisciante il proprio modus operandi. La stessa nozione di cittadinanza che opera nel Regno Unito odierno, in cui ormai da trent’anni non esiste più lo ius soli e le leggi anti-immigrazione volute dal New Labour lasciano circa 250000 residenti stranieri in un limbo dal quale non si può accedere né ad un impiego regolare né ad un welfare minimamente degno del nome, agisce ormai come un dispositivo biopolitico del quale l’esclusione di determinate categorie di soggetti è un elemento portante (Tyler 2010).
Forse senza accorgercene, siamo tornati a Grenfell Tower: è notizia recente che i sopravvissuti alla strage potranno restare nel paese per altri 12 mesi, dopodiché i non cittadini saranno normalmente vincolati dalla legge ordinaria – il che implica che in molti casi rischieranno l’espulsione. L’umanità minore che abita le spoglie delle case popolari, fatta di richiedenti asilo, immigrati, poveri, consumatori falliti, anziani con poche risorse, talmente abbandonata a se stessa da risultare inintelligibile anche quando si ribella, è, al di là delle singole tragedie, un fenomeno nazionale ed internazionale. In ultima analisi, la maggiore esposizione alla mortalità non è che una conseguenza dell’appartenenza ad un tale gruppo.
Nel commentare la legge che nel 1981 escluse della possibilità di ottenere la cittadinanza britannica le popolazioni delle ex colonie facenti parte del Commonwealth, Salman Rushdie (1982) osservava come il ritrarsi dei confini dell’impero avesse come corrispettivo il tracciato di nuove distinzioni al suo interno. Modi di lasciar morire, forme di biopotere o addirittura necropotere che avevano fino a tempi recenti trovato nel dominio coloniale il principale ambito di applicazione, guadagnano oggi sempre più spesso cogenza dentro lo stato stesso. Non è retorico affermare che se quella torre non fosse stata una costruzione di edilizia sociale abitata da determinate persone oggi probabilmente non ci sarebbero dei morti da piangere, e il fatto che 800 famiglie siano state evacuate da alloggi popolari con rivestimenti simili a Grenfell Tower nei giorni seguenti al rogo ne è la triste conferma. Che alcune esistenze siano meno degne di protezione di altre sembra far parte dell’ordine delle cose e del discorso, improntato ad un razzismo basilare che poi è la stessa condizione che rende arbitrariamente accettabile una morte rispetto ad un’altra (cfr. Foucault 1975-1976, §11). La dinamica, sia pure intensificatasi in anni recenti, non è inedita: che lo stato neoliberale rinunci in modo programmatico a preservare equamente la propria popolazione, lasciandone intere fasce in balia del destino, era evidente già all’indomani dell’uragano Katrina – un altro caso in cui la coscienza dell’opinione pubblica era troppo sporca per comprendere le cause dei saccheggi e dei disordini (Giroux 2006: 174-178).
Al netto di quelle che saranno le conclusioni dell’inchiesta sui fatti di Grenfell e le responsabilità individuali da accertare, quanto avvenuto il 14 giugno affonda le radici nell’idea che ci siano delle vite di scarto, che la metropoli sia una giungla dove, come in una sorta di western distopico, soltanto alcuni possono star certi di sopravvivere. È questa la giuntura ideologica sulla quale focalizzare la rabbia, il postulato da mettere incessantemente in discussione per ripensare le implicazioni politiche della dimensione urbana. Tornano alla mente le parole di Henri Lefebvre: «‘Cambiamo la vita!’ ‘Cambiamo la società!’ Questi precetti non significano niente senza la produzione di uno spazio appropriato…nuove relazioni sociali richiedono un nuovo spazio, e viceversa».


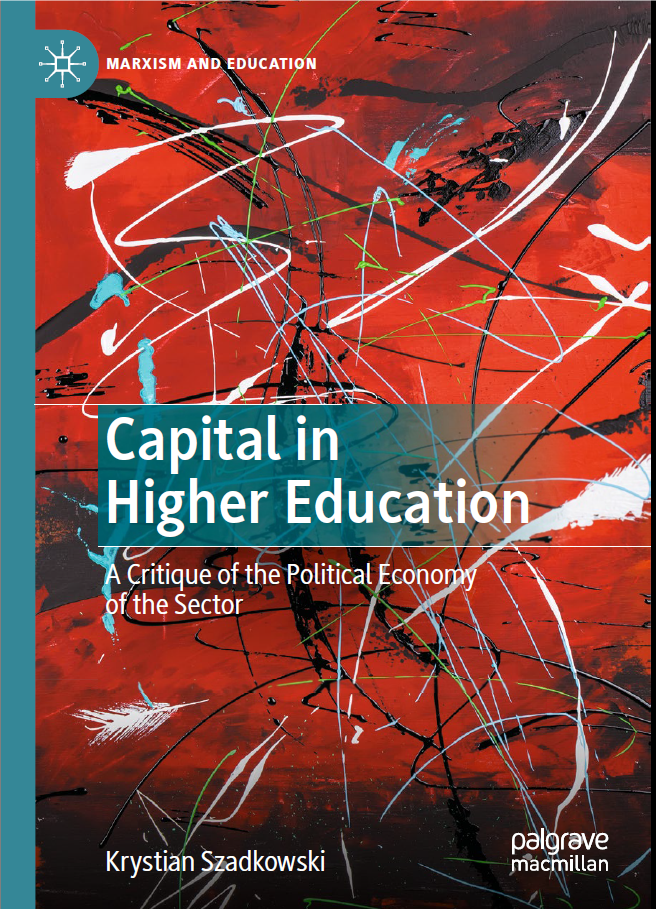





[…] – lo dimostra ad esempio il caso dei cosiddetti riots del 2011 nel Regno Unito, su cui ho scritto diffusamente altrove. Si può dire già da ora, invece, che le ipotesi di Saviano (perché di […]