Federica aveva trovato lavoro in un ristorante di Roma, a tempo indeterminato. Pochi soldi, necessari per vivere. Il suo contratto, però, lo aveva firmato dopo l’approvazione del Jobs Act e per lei non c’era più la protezione dell’art. 18. Era uno dei posti di lavoro contrabbandati come definitivi dal governo delle larghe intese. Il licenziamento non ha valida giustificazione, questo appare chiaro. Tuttavia, con la nuova legge, Federica non poteva riavere il suo posto, le spettava soltanto l’indennità di quattro mesi. Il Giudice del lavoro, Maria Giulia, ha mandato gli atti alla Corte Costituzionale, chiedendo di cancellare dall’ordinamento il Jobs Act (in gergo giuridico: contratto a tutele crescenti) perché in contrasto con la nostra Carta. Verso l’estate arriverà la decisione. La scadenza è di notevole importanza: ove mai Federica la spuntasse la decisione si estenderebbe, automaticamente, a tutti i licenziamenti. Le imprese sono in allarme e hanno subito allertato i loro giuslavoristi; a Milano si è tenuto venerdì 23 febbraio un affollato convegno nazionale degli altri giuslavoristi, quelli che stanno dalla parte dei lavoratori, al fine di preparare il terreno anche politico di sostegno a Federica. E all’impostazione di Maria Giulia.Pubblichiamo di seguito il testo completo su cui l’avvocato Piero Panici, di Roma, ha poi basato la sua relazione agli intervenuti.
Considerazioni preliminari
Tanti facili profeti avevano previsto la remissione alla Corte Costituzionale del D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015, così evidente era apparso il frontale contrasto delle «tutele crescenti», sia con i principi fondamentali della nostra Costituzione sia con i limiti posti dall’Ordinamento Comunitario e dai Trattati internazionali al potere di licenziamento e con le previsioni di tutela adeguata per i prestatori di lavoro a fronte del suo esercizio arbitrario.
Innanzitutto un chiarimento per i non giuristi.
Il D.Lgs 23/2015 nonostante la ambigua rubrica di «Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti»:
- non istituisce una nuova tipologia contrattuale: quello a tempo indeterminato è un contratto tipico previsto dal codice civile del 1942, destinatario poi di garanzie costituzionali nel 1948 e di leggi ordinarie di attuazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro (l. 604/66, 300/70, 223/91 e altre specifiche per divieto di discriminazione, tutela della maternità, ecc.); insomma il contratto a tempo indeterminato esisteva già prima della nascita degli autori della riforma;
- si limita a regolare le conseguenze del licenziamento illegittimo per tutti gli assunti dopo il 7.03.2015, in modo diverso dai lavoratori assunti prima di tale data: in particolare, per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo (l’ipotesi che qui ci occupa) viene eliminata sia la «tutela forte» di cui all’art. 18 l. 300/70, come novellato dalla l. 92/2012 (reintegrazione, pagamento retribuzioni perdute, versamento contributi) sia quella «debole» (indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità).
Le cd «tutele crescenti» si esauriscono tutte nella previsione di una «indennità» pari a due mensilità per ogni anno di servizio «in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 24 mensilità».
Dunque a partire dal 2027 i lavoratori che avranno avuto la fortuna di lavorare continuativamente per 12 anni presso lo stesso datore di lavoro potranno accedere alla stessa «tutela debole» oggi prevista per gli assunti prima del 7.03.2015.
Fortuna che, come vedremo, non ha avuto la lavoratrice nel caso rimesso alla Corte Costituzionale (al pari delle molte centinaia di migliaia di licenziati ogni anno e dei molti milioni sino al 2027).
* * * *
L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale è solida, molto articolata e chiara non solo nell’accurata disamina delle fonti normative nazionali, comunitarie e dei Trattati internazionali rispetto alle quali è prospettata la questione di costituzionalità ma anche della impraticabilità della cd «interpretazione conforme»: si argomenta in modo persuasivo come il Giudice non possa determinare una sanzione diversa – in aderenza ai suddetti principi dell’Ordinamento – nel caso di licenziamento illegittimo, non essendo consentito per via interpretativa «abrogare» il D.Lgs 23/2015.
E’ altresì argomentato come gli stessi principi ispiratori del «contratto a tutele crescenti», pure richiamati “… nella prima versione della legge delega …… proprio per renderlo compatibile con il principio di uguaglianza e reale disincentivo alla precarizzazione …”, vengono poi disattesi nel testo normativo.
Merita quindi una lettura ed un approfondimento più accurato di quello possibile in questo breve intervento e probabilmente un convegno specifico, con trattazione: a) delle singole norme richiamate; b) dei principi ispiratori della riforma e delle modalità della sua attuazione (delega sostanzialmente in bianco e successivo voto di fiducia, che hanno impedito un reale confronto e approfondimento parlamentare); c) delle conseguenze della riforma non solo sull’Ordinamento giuridico ma anche su quelle sociali e addirittura sul contrasto alla criminalità organizzata: farò un cenno più avanti alla Relazione del Procuratore Generale di Palermo dr. Scarpinato del 27.01.2018 alla inaugurazione dell’anno giudiziario ove è indicato il nesso diretto tra precarizzazione del lavoro, eliminazione delle tutele, aumento delle disuguaglianze, frantumazione sociale e crescita dell’area della illegalità e della impunità.
Non si ipotizza certo un patto Renzi/Poletti–Mafia dopo quello Stato-Mafia per cui è in corso il processo a Palermo, ma viene effettuata una accurata disamina di come le disuguaglianze sociali ed il «tradimento» dei principi costituzionali determinino «la disaffezione di larghe componenti popolari non solo nei confronti della politica ma anche nei confronti dello Stato» e crea una vasta area di disagio sociale che costituisce un humus fertile per lo sviluppo della criminalità organizzata.
Merita poi una riflessione il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale in questi ultimi anni, nuovo ed esorbitante rispetto alle sue tradizionali attribuzioni e che, nel caso di sentenze con efficacia «ex nunc» e addirittura solo «pro futuro», costituiscono «un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale» (Puggiotto).
Come insegna la psicanalisi la «rimozione è sempre il sintomo di un problema».
E qui il problema c’è, è serio e va affrontato (ne parleremo più avanti).
* * * *
E’ dunque necessaria una riflessione approfondita, vasta, e complessiva perché le «tutele crescenti» costituiscono la riforma fondamentale, il «cuore del Jobs act», la conclusione della guerra trentennale alla «tutela reale» introdotta con l’art. 18 l. 300/70 oramai sostanzialmente abrogato (con le residuali ipotesi, solo accademiche, di licenziamento intimato per motivi di discriminazione razziale, politica, sessuale, religiosa: per questi licenziamenti nemmeno serve l’art. 18 essendo sufficiente la radicale nullità di diritto comune sempre esistita sin dall’emanazione del codice civile del 1942 e ora rafforzata dalle norme costituzionali).
* * * *
Intanto un curioso destino: quella stessa Corte che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo delle «tutele crescenti», impedendo così alla sovranità popolare di esprimersi, ora è chiamata direttamente ad occuparsi della sua possibile eliminazione dal nostro Ordinamento.
La sentenza di inammissibilità desta notevoli perplessità (e non è l’unica discutibile della Corte Costituzionale di questi anni, come vedremo in seguito) e sollecita anche qui un approfondimento dei giuristi visto che attiene alle funzioni fondamentali dello stato di diritto.
Certo che il «quesito multiplo» non poteva essere ammesso: è dal 1978 che la Corte lo afferma e subito avevamo rilevato l’errore.
Ma trattandosi di un quesito complesso ma «univoco ed omogeneo» nel chiedere la eliminazione dei limiti che varie leggi ordinarie pongono alla applicazione della tutela reale nei licenziamenti, doveva e poteva essere rimesso all’Ufficio Centrale del Referendum presso la Cassazione perché provvedesse alla separazione dei quesiti: ciò rientra nelle attribuzioni della Cassazione. Probabilmente, ancora sbagliando, non è stato richiesto dai promotori ma poteva – ripeto – essere rimesso dalla Corte Costituzionale all’Ufficio Centrale e così consentire alla Sovranità popolare di esprimersi in una materia così rilevante – nell’unica reale forma di democrazia diretta (l’altra, i disegni di legge di iniziativa popolare, non giunge mai all’esame delle aule parlamentari).
C’è anche un drammatico paradosso storico.
La peggiore legislatura della Repubblica, con un Parlamento costituito in base ad una legge elettorale incostituzionale (c.d. «Porcellum») ha realizzato la distruzione dei diritti dei lavoratori, affermati con le leggi degli anni 60 e 70 (causale nel contratto a termine per contrastare la precarietà e Statuto dei lavoratori) con la sinistra al governo.
L’erede dell’allora PCI, che si astenne sulla l. 300/70 proprio perché non condivideva la limitazione dell’art. 18 ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti (un diritto è di tutti altrimenti può diventare un privilegio), oggi si chiama P.D., e prima ha ridotto le ipotesi di applicazione dell’art. 18, ora – con le «tutele crescenti» – lo ha eliminato per tutti gli assunti dopo il 7.03.2015! (Quando si scriverà la storia del fallimento della sinistra in Europa e del suicidio delle sue classi dirigenti, questa vicenda sarà uno spunto per il caso Italia).
La questione sottoposta alla Corte Costituzionale
La vicenda processuale della lavoratrice licenziata ci introduce bene nel «meraviglioso mondo delle tutele crescenti», secondo la favola della narrazione renziana rilanciata continuamente dai mass-media in servizio permanente ed effettivo dei venditori di miracoli.
Viene assunta nel maggio 2015, portando con sé la bella dote di risorse economiche fornita dalla collettività alle imprese.
Per essere più precisi: 8.060 euro all’anno di sgravi contributivi senza alcuna condizione.
Ed infatti mentre gli 80 euro ai lavoratori subordinati si perdono se si scende sotto la soglia di circa 8 mila euro di reddito annuo (assurdo: se diventi più povero sei più bisognoso) e se si superano i circa 24 mila euro, il datore di lavoro non li perde mai, nemmeno a fronte del più ingiustificato ed arbitrario dei licenziamenti vengono revocati i benefici contributivi.
Si è trattato, sempre per essere ancora più precisi, del più grande trasferimento di risorse della storia della Repubblica (circa 40.000 miliardi di vecchie lire) dai lavoratori dipendenti e dai pensionati (che si sobbarcano oltre l’80 percento dell’Irpef) ai proprietari delle aziende (che, secondo la CGIA di Mestre, solo l’anno scorso hanno sottratto al fisco circa 93 miliardi di euro).
Insomma un gigantesco «welfare per i ricchi» pagato dai poveri, che è una delle cause delle disuguaglianze cresciute a dismisura in questi ultimi anni. Una riforma che per un verso supera quelle di Trump, il quale ha ridotto sì le tasse per i ricchi ma non ha mai trasferito loro risorse tolte ai lavoratori e pensionati!
* * * *
Il Giudice si è trovato di fronte ad un licenziamento con il vizio più grave la «non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» (secondo il D.Lgs 23/15) ovvero «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» (secondo la previsione dell’art. 18 l. 300/70 come novellato dalla l. 92/2012).
Se assunta prima del 7.03.2015 la lavoratrice avrebbe avuto diritto:
- alla reintegrazione nel posto di lavoro;
- alla indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni globali di fatto perdute;
- al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Nulla di tutto questo, e solo perché assunta dopo il 7.03.2015.
E cosa accade con le «tutele crescenti»?
Intanto, ai sensi dell’art. 3, a fronte del licenziamento illegittimo:
- «il Giudice dichiara estinto il rapporto». Una novità – aberrante – in uno Stato di diritto: il Giudice accerta la illegittima risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive di durata (quello di lavoro) disposto dal contraente «forte», e lo estingue lui!
A proposito della «supplenza» dei Giudici tanto avversata in questi anni: qui, per condannare alla disoccupazione e miseria il lavoratore licenziato ingiustamente viene chiamato il Giudice del lavoro, per dare concreta attuazione – premiandolo – all’illecito contrattuale. Insomma il «Giudice della privazione del lavoro» all’esito dell’accertamento di un recesso illegittimo.
Se una simile normativa fosse stata prevista per tutti gli altri contratti a prestazioni corrispettive di durata – tipici e non – previsti dal codice civile, tutti i giuristi sarebbero insorti a tutela della «libertà contrattuale» e della «autonomia delle parti» garantite come sacre e inviolabili dal codice civile!
Codice che, come è noto, prevede all’art. 1453 c.c. sia l’azione di adempimento nei contratti con prestazioni corrispettive di durata, oltre a quella di risarcimento danni; ed inoltre consente la «reintegrazione in forma specifica» ove possibile, ai sensi dell’art. 2058 c.c., per il «danno ingiusto» da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
(A proposito di coloro che da sempre sostengono che la «reintegrazione» c’è solo nella l. 300/70: c’è da millenni, è stata creata dal diritto romano ove il «Praetor» disponeva la «restitutio in integrum» per coloro che avevano subito una arbitraria privazione di un bene o di un servizio: «reintegrazione» significa esattamente «restitutio in integrum»; ora è rimasta intatta nel diritto comune).
Quando fu approvato lo «Statuto dei diritti dei lavoratori» lo rivendicarono con orgoglio i giuristi che lo avevano elaborato: Giugni, Federico Mancini, Ghezzi, Romagnoli.
Per gli otto decreti legislativi attuativi del «Jobs Act» nessun giurista «ci mette la faccia».
La firma ce l’hanno messa il perito agrario Poletti ed il dr. Renzi (noto conoscitore della materia avendo lavorato nella intera sua vita, sinora, un paio di settimane, come dirigente nella aziendina familiare, giusto il tempo per un «distacco» a Presidente della Provincia di Firenze che ha posto a carico della collettività contributi previdenziali per centinaia di migliaia di euro) ma tutti sanno che è stato predisposto dai legali di Confindustria e così come è uscito dallo studio di un avvocato fiorentino è finito sulla Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento non ha toccato palla, prima con una legge delega assai vaga (con violazione dell’art. 76 Cost. che impone una precisa «determinazione di principi e criteri direttivi») poi approvando il D.Lgs 23/2015, senza modifiche, con il voto di fiducia.
* * * *
Una rapida disamina dei punti cardine della Ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma del 26.07.2017.
a) Il contrasto con l’art. 3 Costituzione
L’art. 3 del D.Lgs 23/2015 prevede il pagamento di una indennità – senza contributi previdenziali – pari a due mensilità di retribuzione, per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 (nel caso di specie) per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo.
I dubbi di costituzionalità vengono dunque in evidenza in quanto la nuova normativa priva la lavoratrice ingiustamente licenziata di «gran parte delle tutele tutt’ora vigenti per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato prima del 7.03.2015».
La non manifesta infondatezza «emerge pienamente» dal contrasto con le normative seguenti:
- art. 3 della Costituzione in quanto la indennità così modesta per gli assunti dopo il 7.03.2015 ingiustamente licenziati «viola il principio di uguaglianza». Il regresso di tutela appare «irragionevole e sproporzionato, viola l’art. 3 Cost. differenziando fra vecchi e nuovi assunti, pertanto non soddisfa il test del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco imposto dal giudizio di ragionevolezza».
Elenca quindi la mancanza del «carattere compensativo» della indennità. Nella ordinanza si sviluppa un ragionamento molto efficace sia sul beneficio dello sgravio contributivo per 36 mesi, molto più consistente della condanna in sede giudiziaria per l’illegittimo licenziamento, sia sulla circostanza che il legislatore incoraggia, con tali misure, comportamenti di «dumping sociale».
E, aggiungiamo noi, discrimina per sempre gli assunti dopo il 7.03.2015 perché saranno «i prescelti» nel licenziamento visto che con essi, diversamente dagli altri dipendenti, il datore rischia davvero poco.
Ma la normativa tradisce le stesse intenzioni dei riformatori.
La proposta originaria (Boeri) che aveva avuto il sostanziale consenso delle parti sociali e di quasi tutte le forze politiche, prevedeva per un certo periodo un salario d’ingresso e un inquadramento inferiore rispetto al CCNL, la tutela solo obbligatoria nei licenziamenti illegittimi con un risarcimento che aumentava nel tempo, con l’approdo finale alle tutele piene, al pari degli altri dipendenti già occupati: alla fine tutti uguali nelle tutele.
Ciò è sparito nel «contratto a tutele crescenti» che cristallizza, contrariamente alle premesse, il «dualismo» delle tutele tra vecchi e nuovi assunti, penalizzando i giovani che entrano nel mondo del lavoro (e non conosceranno mai l’art. 18 che rimane solo come privilegio per i genitori o i fratelli e le sorelle maggiori).
Osserva al riguardo il prof. Umberto Romagnoli – uno degli Autori dello Statuto del 1970 – («Renzismo al lavoro» in Sinistra Lavoro n. 13).
“… candido come una colomba e astuto come un serpente, il legislatore delegato ha chiarito che la sola forma di tutela destinata a crescere è l’indennità corrisposta in caso di licenziamento ingiustificato; un’indennità che, con la serenità di un tagliatore di teste aziendale, qualcuno si è già affrettato a ridefinire asetticamente «costo della separazione», scolorendone così la natura di risarcimento forfettario del danno causato da un illecito civile. Insomma, il trattamento degli occupati attuali non sarà mai acquisito dai nuovi assunti…”.
E lo rileva lo stesso Tribunale di Roma nella ordinanza:
“… Nell’intenzione dei teorici ispiratori della normativa all’esame nonché nella prima versione della delega, infatti, il contratto «a tutele crescenti», proprio per renderlo compatibile con il principio di uguaglianza e reale disincentivo alla precarizzazione, avrebbe dovuto favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro attraverso una attenuazione della tutela contro i licenziamenti di carattere meramente temporaneo, e dunque fatta salva l’applicazione della ordinaria tutela ex art. 18 al termine di una prima fase (per quanto lunga) del rapporto; le tutele del D.Lgs. n. 23/2015, invece, non sono affatto «crescenti», giacché con lo scorrere del tempo non aumentano le garanzie ma soltanto l’indennizzo in proporzione alla maggiore anzianità del lavoratore, che non può più, permanentemente, accedere alle tutele standard degli assunti anteriormente al 7.03.2015; e che anzi incontra un tetto massimo indennitario dopo dodici anni di servizio …”.
Fu Massimo D’Antona, ispiratore della legge di cd. «privatizzazione del pubblico impiego», ad indicare la strada della uguaglianza nelle tutele a fronte del licenziamento illegittimo, così unificando il mondo del lavoro in una grande comunità di uguali nei diritti e nei doveri. Anche dopo la eliminazione delle «tutele crescenti» dal nostro Ordinamento giuridico sarà necessario un intervento legislativo di «ricostruzione».
Oggi, a fronte della finalità di unificazione delle tutele proclamate dai venditori di miracoli, abbiamo le seguenti conseguenze a fronte di un licenziamento illegittimo:
- nel pubblico impiego, sempre la reintegrazione ed il risarcimento integrale dei danni patrimoniali, con copertura previdenziale, senza alcun limite numerico di dipendenti per la sua di applicazione e per ogni tipologia di licenziamento invalido (illegittimo, nullo, inefficace) ed anche per i dirigenti;
- nel settore privato, per gli assunti prima del 7.03.2015:
- la tutela solo risarcitoria – modesta – di cui alla l. 604/66 per i dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti;
- sopra i 15 dipendenti si applica il novellato art. 18 l. 300/70 che prevede una impressionante pluralità di ipotesi di invalidità del recesso cui sono collegate le diverse conseguenze sanzionatorie:
- nullità, nelle tre previsioni di discriminazione, per matrimonio e gravidanza, motivo illecito;
- illegittimità, nelle due ipotesi di insussistenza – e manifesta insussistenza – del giustificato motivo oggettivo; nelle tre ipotesi di inesistenza del fatto contestato, o perché il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa, ai sensi del CCNL, per la giusta causa; infine per inidoneità fisica;
- inefficacia, per altre due fattispecie: violazione del requisito di motivazione (art. 2 l. 604/66) e della procedura disciplinare (art. 7 l. 300/70).
Per queste ipotesi sono poi previste quattro diverse tutele: quella cd. forte con la reintegrazione e tutte le retribuzioni perdute, quella attenuata con la reintegrazione ed il limite massimo di 12 mensilità per il danno patito, quella solo economica tra 12 e 24 mensilità, quella infine solo economica, ma ridotta, da 6 a 12 mensilità; per i dirigenti infine è prevista una tutela contrattuale solo economica ma forte (tranne rari casi di nullità ove è prevista la reintegrazione).
* * * *
Vi è un ulteriore argomento. La discriminazione nel risarcimento irrisorio delle «tutele crescenti» non è solo con dipendenti assunti prima del 7.03.2015 – e, per sempre, con i dirigenti – ma anche tra gli assunti dopo il fatidico 7.03.2015 e la generalità degli altri cittadini titolari di un contratto a prestazioni corrispettive di durata, i quali possono, nel caso di una sua risoluzione illegittima, ottenere l’integrale risarcimento danni (così come per ogni fatto illecito anche extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed anche la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., come già rilevato).
Ma, limitandoci ora al danno, i titolari di un contratto diverso dal lavoro nel caso della sua risoluzione illegittima hanno diritto al ristoro integrale per lucro cessante e danno emergente, oltre al danno biologico, esistenziale, sociale, morale.
Invece alla lavoratrice licenziata ingiustamente spetta solo la misera indennità, delle «tutele crescenti» predeterminata nell’ammontare e che prescinde totalmente dal danno effettivo causato dall’illegittimo recesso.
Tant’è che il legislatore nemmeno osa definirlo «danno» bensì «indennità», nella consapevolezza che il nostro Ordinamento consente a qualunque cittadino di ottenere l’integrale risarcimento danni per ogni illecito, anche extracontrattuale.
* * * *
Il Tribunale sviluppa poi ulteriore ed efficaci argomenti sulla mancanza del «carattere dissuasivo» della sanzione che incentiva, anziché scoraggiare, comportamenti di «danno» di «free riding» per concludere così:
“… Se dunque non solo di una compensazione ma anche di una sanzione si tratta, il giudizio di adeguatezza si impone perché una quantificazione irrisoria, come nel caso che ci occupa, si risolve in un incentivo all’inadempimento, anziché il suo opposto.
La disciplina scrutinata, in altre parole, non induce le imprese alla adozione di condotte virtuose, laddove codifica che un atto contrario alla legge e di inadempimento dell’impegno alla stabilità assunto con la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (unica fattispecie incentivata sul versante contributivo) è soggetto ad una sanzione indennitaria di importo contenuto, scisso dall’effettivo pregiudizio provocato, sottratto, nella sua quantificazione, alla valutazione del giudice, che pure continua a valutarne i presupposti, e addirittura inferiore al correlato beneficio contributivo …”.
* * * *
b) Il contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione
Anche riguardo a tali norme le argomentazioni del Tribunale sono ineccepibili.
“… L’art. 4 della Costituzione («la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto») e l’art. 35, comma 1 («la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni») non possono dirsi inverati in una normativa come quella all’esame, che sostanzialmente «valuta» il diritto al lavoro, come strumento di realizzazione della persona e mezzo di emancipazione sociale ed economico, con una quantificazione tanto modesta ed evanescente, …… quasi un ripristino di fatto della libertà assoluta di licenziamento (la cui contrarietà alla Costituzione è espressamente affermata nella sentenza n. 36/2000 della Corte Costituzionale) che annulla l’effetto «vincolistico» derivante dall’esistenza di fattispecie autorizzatorie inderogabile (giusta causa e giustificato motivo).
Le tutele dei licenziamenti, inoltre, hanno una rilevanza che va ben oltre la specifica vicenda del recesso e la tutela della stabilità di reddito e occupazione, poiché sostengono la forza contrattuale del lavoratore nella relazione quotidiana sul luogo di lavoro. Di più: una tutela efficace nei confronti di un licenziamento ipoteticamente ingiustificato – diritto non a caso espressamente sancito a livello internazionale, come meglio si dirà – protegge le libertà fondamentali di lavoratrici e lavoratori, nei luoghi di lavoro: la libertà di espressione e di dissenso, la difesa della dignità quando questa sia minacciata da superiori o colleghi, la difesa e pretesa dei propri diritti; la possibilità di attivarsi sindacalmente se lo si desidera, ecc..
Il sistema del Jobs Act ed in particolare, per quanto qui interessa, la quantificazione dell’indennità in discorso, è all’opposto costruito, su una consapevole rottura del principio di uguaglianza e solidarietà nei luoghi di lavoro che non può non spiegare i propri effetti anche sugli altri diritti dei lavoratori costituzionalmente tutelati (libertà sindacale, libertà di espressione eccetera)…”
Una limpida argomentazione in sintonia con la nozione – elaborata da Nanni Alleva – della tutela reale come «diritto stipite» che tutti gli altri garantisce e rende effettivi e con la altrettanto efficace considerazione di Giorgio Ghezzi, secondo il quale senza la tutela reale «tutti gli altri diritti sono scritti sulla sabbia».
Per concludere sul punto: è di solare evidenza che il riconoscimento del diritto al lavoro e del dovere della Repubblica «di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto» impongono al legislatore, innanzitutto, di predisporre una normativa che vieti la privazione arbitraria del lavoro e non certo la agevoli.
* * * *
c) Il contrasto con gli artt. 76 e 117 della Costituzione. Una tutela adeguata e congrua: ce la chiede l’Europa
Alle pagine 8, 9 e 10 della Ordinanza vi è un accurata disamina dei profili di costituzionalità del D.Lgs 23/2015:
- rispetto alle previsioni dell’art. 117 Cost. che pone dei vincoli all’esercizio della potestà legislativa della Repubblica, derivanti dall’Ordinamento Comunitario e dai Trattati internazionali;
- rispetto alle stesse previsioni della legge delega n. 183/2014 la quale al comma 7 dell’art. 1 indica quale criterio generale la «coerenza con la regolazione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali».
Nella ordinanza sono sviluppati i vari motivi di non conformità delle «tutele crescenti»:
- con l’art. 30 della Carta di Nizza (la c.d. “Costituzione Europea”), oramai definitivamente inserita nel nostro Ordinamento Comunitario;
- con la Convenzione ILO n. 158/1982 sui licenziamenti;
- con l’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Le normative vengono sottoposte ad una accurata disamina, anche con richiamo alla giurisprudenza della CESD (Comitato Europeo dei Diritti Sociali).
In particolare la Carta Europea dei diritti fondamentali impone agli stati nazionali la adozione di specifiche norme di «Tutela in caso di licenziamento ingiustificato».
L’art. 30 in modo sintetico e limpido così recita: «Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato…».
Al successivo art. 52 (“Portata dei diritti garantiti”) si chiarisce che le regolamentazioni nazionali dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta «…devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti…».
Insomma la tutela dal licenziamento ingiustificato non può essere inadeguata e irrisoria tale da negare il «contenuto essenziale» del diritto.
La Carta sociale Europea prevede espressamente all’art. 24, lettera a) «il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo…»; alla lettera b) «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione».
Come si vede le norme comunitarie lasciano libertà agli Stati nazionali di regolare la materia ma fissano i principi essenziali e non derogabili per la tutela contro i licenziamenti arbitrari.
Stavolta, ben a ragione, si può dire: «ce lo chiede l’Europa».
La Corte Costituzionale non ha equiparato le pronunce della CESD a quella della CEDU quanto ai suoi effetti giuridici nell’Ordinamento nazionale.
La decisione ha valore di indirizzo politico, ma è assai utile per attivare un dialogo tra le Corti, da tanti auspicato, per garantire effettività ai diritti sanciti dalla Carta Sociale Europea e quindi rafforzare i principi giuridici che tengono insieme l’Unione Europea: che è il vero antidoto a chi ne propone la sua dissoluzione.
Il licenziamento come diritto da proteggere e sostenere anche con le risorse della collettività
Completa il D.Lgs 23/2015 la previsione di cui all’art. 6, assai significativa (sfuggita a molti commentatori): al 1° comma dispone che ove il datore di lavoro, per evitare il giudizio, offra al lavoratore «un importo» esso «non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione».
Insomma il datore versa il lordo per il netto.
E chi si fa carico delle mancate imposte? Di nuovo la collettività! Al comma 2, per far fronte alle «minori entrate derivanti dal comma 1» sono stati stanziati 216,4 milioni di euro dal 2015 al 2023.
E dal 2024 “… si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, legge 23 dicembre 2014 n. 190…”.
E cosa riguarda questo stanziamento? Il finanziamento degli ammortizzatori sociali e le «politiche attive del lavoro»!
Proprio così: l’incentivo e sostegno economico ai licenziamenti, anche illegittimi, è considerato politica attiva del lavoro.
Ecco dunque non il semplice contrasto con la Costituzione, ma il suo esatto rovesciamento: “… secondo il legislatore quello di licenziare non è più un potere da limitare; tutt’altro, al contrario, è un diritto da proteggere nell’interesse della collettività. Tant’è che essa è pronta persino a farsi carico delle conseguenze del suo esercizio abusivo …” (Umberto Romagnoli «Renzismo al lavoro» in Sinistra lavoro n. 13).
Condivisibilmente l’Autore propone anche di cambiare denominazione alla materia: «del lavoro il diritto ha preso il nome non le ragioni»
Il comma n. 100 dell’art. 1, l. 205 del 29.12.2017: la ferocia sociale
Con la legge finanziaria approvata a fine legislatura è previsto – al comma 100, art. 1 – un ulteriore esonero del 50% dei contributi previdenziali per 36 mesi al fine di promuovere l’occupazione giovanile.
Il beneficio è previsto per «i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23».
Al successivo comma 108 viene previsto «l’esonero totale» per ulteriori ipotesi ma sempre per «i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs 4 marzo 2015».
Al comma 106, invece, è previsto l’esonero di cui al comma 100 per la prosecuzione di un contratto di apprendistato in «rapporto a tempo indeterminato».
Stessa previsione al comma 107 nel caso di conversione di un contratto a termine «in contratto a tempo indeterminato».
Il legislatore dimostra di conoscere bene il significato delle «tutele crescenti» e opera distinzioni: nello stesso articolo di legge, ai diversi commi, prevede sgravi contributivi in alcune ipotesi con rinvio espresso «tutele crescenti» in altre no, limitandosi a richiamare l’assunzione «con contratto a tempo indeterminato».
Perché questa norma?
L’ha chiesta, al solito, Confindustria che infatti ne ha dato notizia, con enfasi, sul «Sole 24 ore», altrimenti sarebbe sfuggita ai più.
Si è infatti diffusa, sia nella contrattazione individuale che collettiva, la previsione di una clausola, in caso di nuova assunzione, che richiama la disciplina dei licenziamenti previgente al 7.03.2015 (in sostanza l’applicazione dell’art. 18 così come modificato dalla l. 92/2012).
Il padronato ha voluto un intervento legislativo per avere un comodo alibi per respingere ora tali clausole contrattuali (la perdita delle agevolazioni contributive), ed il governo ha esaudito la richiesta.
E’ di questi giorni l’accordo AMA/CGIL-CISL-UIL che prevede l’applicazione dell’art. 18 l. 300/70 anche per i nuovi assunti: vi sono state furiose reazioni della Unione Industriali del Lazio («proditorio attacco alle corrette relazioni sindacali») con minaccia di espulsione della azienda dalla associazione datoriale.
La norma appare di una inaudita ferocia sociale: si autorizzano gli sgravi contributivi – con le risorse della collettività – solo a fronte della eliminazione delle tutele di cui all’art. 18 l. 300/70 per i nuovi assunti.
Incredibile.
E’ questa la norma «manifesto» di fine legislatura, viatico verso le elezioni del 4.03.2018 della sedicente «sinistra di governo» che ben evidenzia la sua bancarotta morale e sociale, prima ancora di quella politico/ elettorale.
Ammettiamolo onestamente: nessun avrebbe mai immaginato una tale devastazione dei diritti dei lavoratori, e della stessa Costituzione, con il maggior partito di sinistra in posizione dominante nel governo!
Ed infatti il fallimentare esito del contrasto alla disoccupazione delle numerose contro-riforme del mercato del lavoro realizzate prevalentemente dai governi di centro – destra negli ultimi 20 anni, tutte improntate alla riduzione delle tutele e dei diritti dei lavoratori, non faceva in alcun modo presagire ulteriori interventi di tale portata.
Il livello di disoccupazione è drammatico, la precarietà è dilagata divenendo ormai fenomeno strutturale nei rapporti di lavoro.
Il fallimento è certificato da tutti gli economisti, (anche quelli “mainstream”) che imputano alla austerità, alla precarietà nel lavoro e alla drastica riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni non la soluzione della crisi economica, bensì la sua causa principale, originata dal crollo della domanda conseguente l’impoverimento dei ceti popolari e dello stesso ceto medio.
Eppure i governanti falliti, colgono adesso il loro più grande e “storico” risultato: la eliminazione della reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento individuale e collettivo illegittimo, oltre alla abrogazione dei divieti di dequalificazione e di controllo a distanza a fini disciplinari della attività lavorativa: insomma i pilastri della legislazione del lavoro.
* * * * *
Dalle favole del rottamatore alla dura realtà dei provvedimenti di legge che generalizzano la precarietà e ristabiliscono la sovranità assoluta del datore di lavoro nella gestione del rapporto di stampo ottocentesco. Altro che “rivoluzione copernicana”! Copernico ci introdusse nella modernità ma il Jobs Act ci riporta indietro nei secoli, al sistema tolemaico «…dove i profitti ed il potere assoluto dell’impresa sono al centro dell’universo renziano e tutt’intorno orbitano poveri che lavorano in totale soggezione…» (U. Romagnoli).
La cifra del giovane rottamatore ha assunto, dal 2014, contorni ogni giorno più chiari. Un agire politico in due fasi, prima le immagini semplici ed evocative, che promettono che tutto andrà bene, poi l’azione di governo che nulla ha a che fare con le favole. Il parto finale: una normativa del lavoro che divora diritti soggettivi e dignità riportando il mercato del lavoro alla condizione ottocentesca.
All’ingresso del luogo di lavoro può essere affisso il cartello che potrebbe riassumere il Jobs Act: «Il lavoro rende liberi» (arbeit macht frei) secondo la favola del rottamatore; nella realtà: perdete ogni speranza di riscatto, obbedite e non disturbate chi vi dà l’opportunità di lavorare, qui si ferma la costituzione.
«Nel regime giuridico duale, cioè con la competizione innestata dalla norma diseguale che differenzia tra vecchi e nuovi assunti servendosi di profili discriminatori l’impresa spera di ottenere maggiori potenziali di ricatto sul lavoro, diviso e sotto minaccia in virtù di nuovi poteri dispositivi e sanzionatori. Con il suo Pier delle Vigne, la comandante dei vigili urbani di Firenze nominata sul campo capo dell’Ufficio legislativo di palazzo Chigi, Renzi ha davvero posto fine al costituzionalismo della Repubblica…E’ cominciata un’altra epoca nel segno della destra economica, cioè con lo sfacciato potere dell’impresa, con la sua giurisdizione privata spietata e senza contropartite. Il lavoro è sconfitto ma non vinto» (Michele Prospero, “Jobs Act: si spengono i diritti. Un premier che marcia spedito verso l’800”, Il Manifesto 10.03.2015).
La Costituzione rovesciata: la tutela del contraente forte nel rapporto di lavoro
Davvero gli otto decreti legislativi di attuazione del Jobs Act, pongono fine al costituzionalismo della Repubblica (per ora).
La sua riforma più rilevante ed emblematica, le “tutele crescenti”, rovescia il diritto fondamentale (il lavoro e la sua tutela) nel suo contrario: nella vicenda più drammatica per le persone che lavorano (oggi il licenziamento non è più solo espulsione dalla azienda ma dal mondo del lavoro per anni, a volte per sempre) è eliminata la tutela reale a fronte del licenziamento illegittimo.
La Costituzione rovesciata dalle «tutele crescenti» si può leggere così:
Art. 1. «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sull’impresa» (è la modifica che proponeva Romiti trenta anni fa e che i riformatori di oggi realizzano nella sostanza).
Art. 3. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge ad eccezione dei lavoratori subordinati assunti dopo il 7.03.2015».
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli …… che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini – con esclusione di quelli titolari di un contratto a tutele crescenti – impediscono il pieno sviluppo della persona umana ……».
Art. 4. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al licenziamento e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto».
La Costituzione tradita, più poveri, più delitti e impunità per tutti: precarietà ed eliminazione di tutele, terreno fertile per lo sviluppo della criminalità
Nella Relazione del 28.01.2018 per la inaugurazione dell’anno giudiziario il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo dr. Roberto Scarpinato ha lanciato un allarme sul pericolo di una «decostituzionalizzazione strisciante» che «passa da politiche che hanno determinato una ascesa vertiginosa delle diseguaglianze sociali».
Dopo aver riferito che l’area della illegalità registra, nel distretto palermitano, una crescita tale da neutralizzare l’efficacia delle politiche criminali deflattive precisa che “… alcune cause si radicano nelle condizioni di progressivo degrado sociale ed economico in cui versano ampi strati della popolazione soprattutto in Sicilia …”.
Osserva ancora che “… un abitat sociale caratterizzato dal regredire progressivo della cultura della legalità e della solidarietà sociale …… costituisce certamente un humus fertile per lo sviluppo della criminalità mafiosa …”.
Dopo aver denunciato i ripetuti tentativi del legislatore di stravolgere parti essenziali della Costituzione, respinti in sede di referendaria, rileva come tale tentativo “… prosegua di fatto per vie oblique mediante l’approvazione di leggi ordinarie che nel loro susseguirsi nel tempo hanno in buona misura svuotato di reali contenuti diritti sociali costituzionali fondamentali quali quelli del lavoro garantiti dagli articoli 4, 35 e 36 (…). Una decostituzionalizzazione strisciante che funge da lasciapassare per politiche economiche che hanno determinato una crescita vertiginosa nel nostro paese delle disuguaglianze sociali e con essa dell’ingiustizia sociale ……
Ogni giorno di più viene tradito il solenne impegno della Repubblica, sancito dall’art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E il tradimento di questa promessa determina la disaffezione di larghe componenti popolari non solo nei confronti della politica ma anche nei confronti dello Stato (…). Le sfide che ci attendono vanno ben al di là di assicurare la produttività della cosiddetta azienda giustizia. La posta in gioco è ben più alta. E’ la tenuta stessa dello Stato democratico, è il senso stesso che vogliamo dare al nostro ruolo di operatori di giustizia, è il senso stesso del nostro essere comunità e non solo una somma aritmetica di individui consegnati ciascuno alla propria solitudine…”.
La Corte Costituzionale e le sue prerogative
Questa vicenda deve anche indurci ad una riflessione critica sul ruolo esorbitante dalle sue attribuzioni assunte dalla Corte Costituzionale nelle sentenze di questi ultimi anni nel disciplinarne gli effetti. Le più significative di questa inedita funzione della Corte sono le sentenze che dichiarano la incostituzionalità del c.d. «blocco» della contrattazione nel pubblico impiego, e del c.d. «porcellum».
Nella prima gli effetti della pronuncia sono stabiliti «ex nunc» nella seconda addirittura differiti nel tempo.
Alcune garbate e perplesse considerazioni le ha espresse Zagrebelski: con la necessità di garantire «continuità» al Parlamento, anche se costituito con legge elettorale incostituzionale, si possono avere assemblee elettive anche per più legislature con lo stesso vizio di formazione!
Più diretta chiara ed efficace la critica di Puggiotto: le sentenze di incostituzionalità solo «pro futuro» sono «un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale».
Come insegna la psicanalisi la «rimozione è sempre il sintomo di un problema».
E qui il problema rimane ed è assai rilevante: riguarda l’essenza dello Stato costituzionale di diritto e le funzioni dei singoli organi che lo compongono.
E’ vero che “… è possibile, in astratto, modulare le decisioni anche sotto il profilo temporale, nei casi particolarissimi ed eccezionali in cui ciò sia imposto da un corretto bilanciamento tra principi costituzionali. Ciò che fa problema – ed è serio – è invece di spingere tale modulazione diacronica fino alla pretesa di attribuire alla pronuncia di illegittimità costituzionale effetti solo ex nunc, scardinando quella pregiudizialità costituzionale prescritta dall’art. 1, l. Cost. n. 1/1948 …”.
Tale norma esige che la questione di costituzionalità sia rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio.
E’ poi assurdo che la sentenza di incostituzionalità non abbia effetto nel giudizio «a quo»: per cui la domanda avanzata in quel giudizio, pur fondata, è respinta!
Se la sentenza con effetto «ex nunc» esorbita dalle prerogative della Corte, quella con «effetti differiti» nel tempo è aberrante.
E’ questione che ci riguarda come giuristi che si battono per il rigoroso rispetto delle funzioni e attribuzioni degli Organi dello Stato Costituzionale di diritto, ma anche per le questioni specifiche, come quello della costituzionalità delle «tutele crescenti».
Ed infatti «continuità», ovvero «compatibilità con i conti pubblici», così come «competitività», «sostenibilità», «produttività», «flessibilità», non sono più concetti neutri ma parole con le quali si è dato sostanza alle politiche economiche neo-liberiste di drastico ridimensionamento dello stato sociale e di eliminazione dei diritti dei prestatori di lavoro: esattamente come è avvenuto nei licenziamenti arbitrari con le tutele crescenti.
Art. 18, ovvero la gigantesca opera di disinformazione dei mass media e del ceto politico: la lezione di Goebbels è ancora viva
Joseph Goebbels, ministro della propaganda hitleriana, affermava che la politica delle notizie è un’arma di guerra: serve a fare la guerra non a diffondere informazioni. Spiegava ancora che ripetere ossessivamente una menzogna la trasforma in verità.
In questi anni c’è stata la guerra all’art. 18 ed ecco la sua rappresentazione come un “tabù” che annulla la libertà di licenziare i fanulloni, impone rigidità, sconsiglia gli investimenti in Italia e quindi genera disoccupazione, soprattutto giovanile, crisi economica e miseria.
I professionisti della disinformazione hanno fatto tesoro della lezione impartita dal ministro nazista.
L’affermazione ripetuta ossessivamente dai mass – media, secondo cui l’art. 18 è un limite intollerabile per la libertà di impresa, è grottesca: è come dire che il divieto di stupro per donne e bambini nega la libertà sessuale; il divieto di diffamazione colpisce la libertà di pensiero, il divieto di correre contromano in autostrada impedisce la libertà di circolazione….
Quasi tutti coloro che discutono dell’art. 18 non richiamano mai il tenore letterale della norma, esattamente come (quasi tutti) i giornalisti e conduttori televisivi non ne illustrano mai il suo reale contenuto, esattamente come mai attuano un contraddittorio effettivo con i giuslavoristi che conoscono la materia.
Insomma l’estremismo neoliberista cancella i diritti costituzionali del lavoro accompagnandosi con il fascismo mediatico. Tutti i telegiornali, che oggi propagandano l’operato del governo sono uguali ai cinegiornali dell’Istituto Luce degli anni trenta.
Una gigantesca ipocrisia ha accompagnato l’assalto finale all’art. 18, indicandolo come ostacolo alla maggiore occupazione, soprattutto per i giovani: l’assioma secondo cui con più licenziamenti arbitrari (senza art. 18) – per quelli legittimi, ripetesi, il datore non ha niente da temere – si avrà più occupazione e meno precarietà, è chiaramente falso: anche la legge c.d. “Biagi” è stata approvata con questi fini e gli esiti disastrosi sono ora sotto gli occhi di tutti.
Gli slogan ossessivamente ripetuti in questi mesi: l’art. 18 non è “tabù intoccabile”; ovvero bisogna “riformare” contro il “conservatorismo”, appaiono privi di senso. La vita, la salute, la libertà, la sicurezza, la dignità, il diritto al lavoro e ad una esistenza libera e dignitosa sono “tabù intoccabili”?.



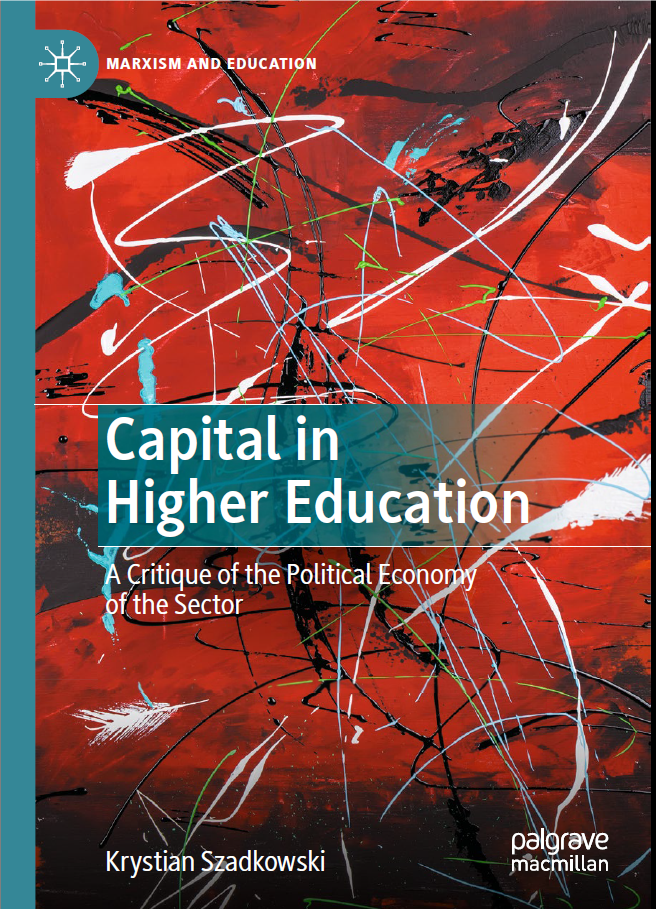




[…] Pier Luigi Panici, “Le tutele crescenti alla prova della Corte Costituzionale”, effimera… […]
Se il salvatore della “patria” ( leggi PD) dovesse essere “Bonaccini” ci sarebbe proprio da ridere…..basta pensare alle contraddizioni che esistono fra le “grida” ufficiali del PD, in materia di tutela del territorio, e la demenziale Legge Urbanistica voluta e fatta approvare da Bonaccini. Solo un “uomo di paglia”, nelle mani della speculazione edilizia più retriva, poteva immaginare di escludere le opere infrastrutturali dalle limitazioni del 3% relative al consumo di suolo. In questo modo il “bellimbusto renziano” inaugura una stagione di devastazione del nostro contesto ambientale con la realizzazione di autostrade “a man bassa”, di cui l”orrendo “passante di mezzo” è solo il primo, scellerato esempio. Se questo è il “pontiere” suggerirei ai collaudatori dei ponti di verificare con la massima attenzione se nel conglomerato c”è anche il cemento