Culture giuridiche e repressione politica nell’Italia contemporanea
È persino banale osservare che da tempo gli attentati e le stragi di supposta matrice fondamentalista attivano una retorica istituzionale, composta da un esiguo repertorio di concetti e immagini, incentrata, come sempre nella storia delle relazioni tra “occidente” e “oriente”, sulla nozione di civiltà e sul primato della “nostra cultura”. Certo, anche questa retorica ha fatto grandi passi avanti rispetto a qualche anno fa (così che il pensiero corre all’ex Primo Ministro Berlusconi, impegnato, all’indomani dell’11 Settembre, a dipingere il mondo musulmano come arretrato di circa 1.400 anni rispetto all’Europa) e appare oggi molto attenta a includere il dialogo tra gli strumenti da perseguire, oppure a evitare rigide generalizzazioni.
Restano tuttavia chiari i presupposti di questo pensiero, gli stessi da sempre: le civiltà europea e nordamericana sono le più avanzate rispetto ai temi delle libertà e dei diritti e costituiscono pertanto la “stella polare” del cammino dell’umanità verso la civilizzazione. In questa prospettiva i paesi dell’“oriente” vicino e lontano (dalle coste del Nord Africa alla Cina, dovendo impiegare una geografia peculiare; forse una “psico-geografia”) risultano coerentemente caratterizzati da una cultura giuridica retriva, capricciosa, disumana. Sono altresì guidate dalla vendetta, dalla esemplarità della pena (basti pensare ai raccapriccianti resoconti sulle impiccagioni di massa in Iran, per citare il primo caso che sovviene alla memoria) o da odi etnici. Senza contare i “progetti di civiltà” come quelli dello Stato Islamico, spie di una tentazione disumana e di una volontà di morte che, dato il numero di adepti, non dev’essere poi così minoritaria in società come quelle musulmane.
Il presupposto e, insieme, la morale pubblica che ricaviamo da questo modo di narrare gruppi sociali, sistemi giuridici o storie nazionali ruota dunque attorno alla rappresentazione della differenza. Semplificando al massimo, ciò che il Presidente Mattarella, il Primo Ministro Renzi o gli attori di turno in un dato momento storico ci dicono è che “da noi queste cose non accadono”, che “ci siamo lasciati la barbarie alle spalle molti secoli or sono”, che “la nostra Costituzione è la più bella del mondo e garantisce tutti” o che “noi non ci limitiamo a punire, ma riabilitiamo” e via dicendo con una serie di enunciazioni valide forse su un piano formale e assai superficiale, limitato ai principi fondamentali di un atto come la carta costituzionale, utili a sviluppare narrazioni e sentimenti pubblici incentrati sull’orgoglio nazionalista (o, forse, persino “etnico”) e l’appartenenza a una “civiltà”, oltre che su visioni della storia lineari, deterministiche e manichee, che, in barba ai discorsi sulla fine delle ideologie e il relativismo, distinguono ancora chiaramente il bene dal male (identificando il bene con noi stessi, naturalmente). Storielle per bambini, potremmo dire; una sorta di catechesi di Stato, volta a formare il cittadino ideale: quello che aiuta la nazione producendo, che non interroga mai l’ordine nelle sue fondamenta, che si comporta rettamente, che prende per buone le parole dell’Istituzione, anche quando sono poco chiare o esprimono delle mezze verità (certo del fatto che vi sia un buon motivo per questo).
Un quadro à la De Amicis e fondamentalmente ottocentesco, dunque? Per buona parte sì, nella misura in cui nazione, civilizzazione e superiorità morale sono tre principi chiave dei processi di formazione dello Stato moderno. Tuttavia asserire che il quadro delle relazioni tra Stato e società interne ed esterne è fondamentalmente ottocentesco, è anche un modo di dire che è la realtà delle relazioni di potere a essere molto meno avanzato di quanto non si sostenga – per lo meno dal punto di vista dei principi pratici, e non delle “tecnologie”.
La realtà giuridica è un perfetto esempio di quanto andiamo notando. Se per esempio l’arretratezza penale e morale dell’Iran è data dalla funzione esemplare delle impiccagioni pubbliche – una funzione condivisa peraltro dal supplizio tutto europeo di cui ci parla Foucault nelle prime pagine di Sorvegliare e punire –, la nostra modernità non è data né dall’esistenza dei processi e di un codice, né dalla qualità dell’istituto della pena; ma dall’occultamento della sofferenza e dalla sua privatizzazione.
Escludendo a fatica dal ragionamento la gogna mediatica e i suoi rituali visivi, fatti di corpi appena arrestati, accompagnati da poderosi agenti dentro automobili e di primi piani di volti perplessi rinchiusi dentro quelle stesse vetture, oppure di foto segnaletiche riprodotte sui quotidiani di provincia (al punto che l’assenza di immagini e nomi suscita l’ira dei cittadini-voyeur, i quali, nell’apposito spazio dei commenti in fondo alle pagine web, gridano: “vogliamo le facce, vogliamo i nomi!”) – qualcosa che, di per sé, suggerisce che l’esposizione del reo si è fatta solo virtuale, ma continua come sempre a esservi – la differenza tra il nostro sistema giuridico e quello delle “civiltà arretrate” consiste innanzitutto nel fatto che i nostri detenuti soffrono per lo più dentro celle sovraffollate e invisibili. Soffrono con l’anima e le privazioni, per quanto queste ultime possano essere parzialmente mitigate dalla disponibilità di denaro. Ma anche il corpo ha la sua parte, se è vero che tra il 2000 e la prima metà dei 2016 i morti nelle carceri italiane sono stati 2.541.
Come dire, partendo dal punto di vista che per tutto lo scorso decennio e per parte di quello attuale la popolazione carceraria italiana è stata attestata attorno alle 60.000 unità, che circa il 4% dei detenuti viene mandato in prigione per morirvi. Certo, per restare alla nostra surreale comparazione, è enorme la differenza con l’Iran, ove, secondo le fonti disponibili, circa 1.900 sarebbero le esecuzioni condotte dal 2013. Ma la differenza fondamentale, è che i detenuti iraniani erano stati condannati a morte, mentre i nostri sono stati di fatto lasciati morire dopo essere stati presi in consegna dallo Stato per periodi definiti. Ed è peraltro notorio che i “suicidi” in carcere – una categoria molto meno lineare e pacifica di quanto si possa pensare – che contribuiscono per una parte rilevante al novero delle morti in regime di detenzione, ha riguardato per gran parte del tempo soprattutto i cosiddetti “nuovi giunti”: i pivelli (al punto che di recente sono state introdotte alcune importanti innovazioni nell’organizzazione carceraria, al fine di limitare il rischio di suicidio in questo gruppo).
Ma, si sa, morire fisicamente non è il solo modo di morire. Non a caso gli “irriducibili” del brigatismo chiamavano “braccetti della morte” le sezioni a regime ristretto previste per loro (una organizzazione carceraria antesignana di quella prevista dal 41 bis per i mafiosi). Tuttavia sarebbe riduttivo concentrarsi sui regimi speciali di detenzione, senza spendere qualche parola sulle pratiche del quotidiano. Le stesse che hanno visto come protagonisti di morti sospette – senza colpevoli e, si vorrebbe insinuare, autoinflitte o casuali – Gabriele Aldrovandi o Stefano Cucchi. Senza contare naturalmente le molte vittime senza nome e senza fama incappate in fermi e modalità di arresto caratterizzate quantomeno dal sospetto di un eccesso di forza. Vittime, presumibilmente, di un complesso di elementi ideologici e materiali che fanno parte integrante della cultura di ampi strati delle forze dell’ordine in Italia e non solo: innanzitutto le nuove tecniche di arresto e incapacitazione dei fermati, ereditate dall’esercito e transitate nei corpi di polizia europei (si guardi a proposito l’interessantissimo libro di Mathieu Rigouste, La domination policière, 2012). E, sempre a proposito di transizioni da un corpo armato all’altro, la provenienza militare di molte delle nuove leve delle forze dell’ordine, in ragione delle riserve di posti assegnati agli ex soldati. Conta anche una certa visione del mondo, delle razze, dei comportamenti e delle identità desiderabili propria del mondo degli armati e di una precisa cultura politica (uno studio di Caforio e Nuciari del 2011 mostrava che il 23,4% degli appartenenti alle forze armate si definisce di estrema destra, e il 39,6% di destra). Senza dimenticare il ruolo di certi sindacati di polizia, determinanti nel contribuire all’evoluzione delle carriere dei ranghi inferiori, ma anche molto solerti a tutelare i propri iscritti quando si ritrovano nell’occhio del ciclone per motivi di servizio. Tuttavia bisognerebbe considerare anche la dipendenza dei vertici delle polizie dalla politica, e la perfetta corrispondenza tra le visioni di molti operatori della sicurezza, dei politici e dei media popolari in materia di “tolleranza zero” e lotta alle “inciviltà” (così che, dal punto di vista della sanzione e della gravità percepita, imbrattamento e furto vengono per esempio pressoché equiparati in certe condizioni. In barba, verrebbe da dire, a Beccaria e al suo principio di proporzionalità della pena, così centrale per la dottrina giuridica europea moderna). Senza dimenticare, naturalmente, l’importanza dei meccanismi di valutazione delle forze di polizia, fondati sugli “obiettivi” e gli indicatori statistici relativi ad arresti, fermi e denunce: quella che possiamo chiamare la neoliberalizzazione dell’ordine pubblico. Intrecciata con quanto sin qui detto, ma con specificità proprie, è la questione della repressione politica. Anche qui, evidentemente, concorrono elementi in parte coincidenti con quelli elencati sopra. Elementi ideologici complessivi, legati a quella che, con Della Porta e Reiter, potremmo chiamare una “polizia del sovrano” (si veda Polizia e protesta, 2003): cioè l’idea, propria dei vertici dello Stato e degli operatori dell’ordine pubblico, per cui la polizia sia innanzitutto al servizio degli interessi costituiti e dell’ordine vigente. La qual cosa, unita a visioni e culture professionali e politiche specifiche, significa che la repressione – specie se ai danni dei “professionisti della protesta” (molto meno nel caso di lavoratori licenziati o “persone veramente bisognose”) – sia una sorta di invito a nozze per molti funzionari e agenti di polizia. Centri sociali e “zecche”, insomma, costituiscono un bersaglio naturale e gradito delle forze di polizia. Tuttavia esiste anche un livello superiore – che coinvolge altre agenzie, come per esempio la magistratura più agé, ma anche quella più giovane e ligia – che immagina una continuità culturale e d’intenti tra vecchi e nuovi movimenti: tra maoisti e Movimento No Tav, tra Brigate rosse e centri sociali, oppure tra “Rosso” ed “Effimera”. Non è facile in questi casi distinguere la buona fede dall’opportunismo a fini mediatici, di carriera o politici. Non è del resto un mistero che nei ranghi della magistratura vi siano cariatidi che abbiano costruito la propria carriera e credibilità facendo per qualche tempo la guerra ai terroristi veri e, poi, gradualmente, man mano che quella fauna pregiata si faceva più rada, a semplici cittadini determinati a portare in piazza le proprie visioni relative al territorio, al lavoro e alla vita. Magistrati prigionieri, potremmo dire, di quella “sindrome degli anni settanta” che ammanta il discorso pubblico egemone e funziona da alibi strumentale per etichettare e sedare le forme di espressione del malcontento sociale . Ugualmente vi sono stati magistrati di minor fama che hanno inseguito il proprio quarto d’ora di celebrità inventando e inseguendo novelli pseudo-eversori, nell’impossibilità, magari, di perseguire il nuovo Toto Riina. Una via traversa per ottenere un qualche tipo di visibilità, presumibilmente. Ma sia come sia, non è estraneo a questo processo il fatto che movimenti eversivi e criminalità organizzata siano stati spesso accostati tra loro, a partire dall’impiego di figure simboliche come Carlo Alberto Dalla Chiesa, ugualmente adatte per dare la caccia tanto ai sovversivi quanto ai mafiosi. Passando naturalmente per l’impiego reale o presunto di appartenenti a cosche camorriste per liberare Ciro Cirillo sequestrato dalle Brigate Rosse, le esternazioni del Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta a proposito delle relazioni tra movimento No-Muos e mafia o l’analogo accostamento che la questura di Palermo fa tra Luca Casarini e la criminalità organizzata. Vista dall’alto e dall’interno delle istituzioni, quella della repressione politica è insomma una storia complessa, spesso caratterizzata dall’impiego ciclico di repertori di azione e definizione della situazione. Ma anche da una visione ideologica della funzione inquirente, propensa a personalizzare le attività di indagine e quelle processuali. Un agire, inoltre, politicamente “realista” e, pertanto, disponibile a partecipare all’instaurazione di stati di eccezione, avvallando di volta in volta leggi di indubbia costituzionalità, riattivando norme dormienti del Codice Rocco, accostando la criminalità organizzata all’eversione politica e quest’ultima alle lotte territoriali; il tutto in nome degli interessi che si danno per primari in differenti fasi storiche (come, per esempio, lo sviluppo delle reti commerciali del Paese in quella attuale). A ogni modo, ci troviamo dinanzi a una visione del mondo e dell’ordine che, gradualmente, finisce con lo straripare, inglobando non solo i sovversivi vecchi e nuovi, ma tutti: i ricercatori universitari così come i semplici cittadini che scendono in piazza a reclamare diritti; i quali hanno oggi discrete possibilità di essere denunciati e rinviati a giudizio, malgrado l’esistenza di prove che li scagionino o evidenti segni di un’impossibilità fisica a commettere reati di piazza. Senza contare la consapevolezza degli operatori di polizia presenti in campo circa l’innocuità di molti di coloro che cadono nella loro rete e, dunque, la propensione che molti inquirenti mostrano in certe circostanze a “costruire il reato”. In conclusione, e tornando circolarmente alle notazioni iniziali, potremmo dire che vivere morendo e morire per liberarsi è stata frequentemente la scelta innanzi a cui la civiltà giuridica italiana, così celebrata dai Presidenti Mattarella e Renzi, ha saputo porre alcuni autori di reato reali o immaginari. Senza contare il disinvolto impiego tattico della penalità per soffocare istanze legittime, legate alla riproduzione di classe o all’uso dei territori; oppure le persecuzioni giudiziarie, le guerre agli indesiderati, il sovraffollamento carcerario, le migliaia di morti in carcere, la disseminazione sistematica di menzogne ai danni di gruppi e individui e le vendette consumate da inquirenti con un qualche conto da regolare. Tutto questo è, storicamente e oggettivamente, parte integrante della vita quotidiana delle persone e delle istituzioni in questo Paese. Sarebbe perciò bello, la prossima volta che sentiranno il bisogno di attingere al repertorio della catechesi civile, che qualcuno chiedesse ai suddetti Presidenti se ritengono che anche queste storie dimenticate facciano parte della cultura a cui amano riferirsi e se la loro eventuale consustanzialità alla storia degli ordinamenti giudiziari li faccia sentire nonostante tutto superiori. E, magari, se non ritengano di dovere pescare da qualche altro repertorio che i loro collaboratori non faticheranno certamente a rintracciare, liberandoci così dall’orticaria e anche un po’ dalla menzogna. NOTE [1] Può essere utile osservare che esistono periodici dibattiti sulla opportunità di mantenere l’istituto del 41 bis, in ragione sia della sua disumanità che degli usi probabilmente eccessivi che ne sono stati fatti in taluni casi. Tra le riflessioni, i casi e le iniziative più recenti, si vedano: http://www.ildubbio.news/stories/carcere/28285_linferno_del_41_bis__di_casa_a_laquila/; http://www.inventati.org/apm/index.php?step=pagineal41; https://trecappelli.wordpress.com/2015/07/02/al-mio-amico-fernando-che-non-leggera-mai-il-42-parallelo-di-dos-passos/; http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/11/04/news/luigi-manconi-violazioni-dei-diritti-con-41-bis-1.237317.







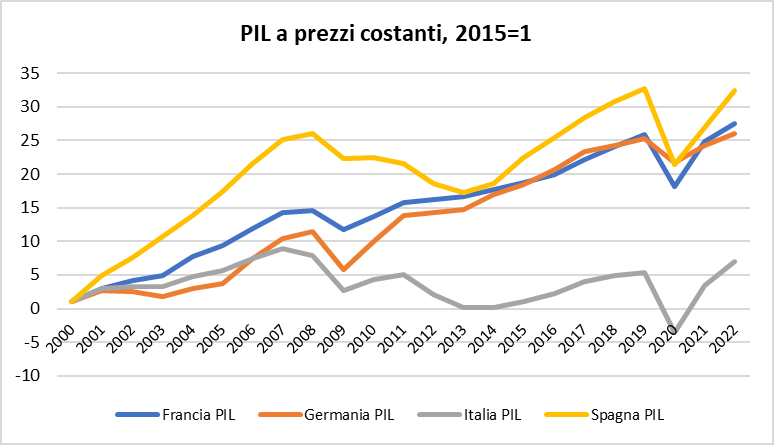
Scrivi un commento