Già nella scorsa intervista avevamo parlato del prepotente ritorno della guerra come possibile strumento di risoluzione capitalistica della crisi. Nel seminario a Milano su crisi e composizione di classe hai ipotizzato l’intensificarsi di uno scenario di guerra diffusa, legato innanzitutto all’esplosione della bolla del petrolio e al crollo del suo prezzo, dovuti a una rivolta dell’Opec contro i nuovi produttori. Hai anche messo in discussione l’ipotesi di un’alleanza tra Arabia Saudita e Stati Uniti in chiave anti-russa. Boaventura de Sousa Santos parla invece di una “nuova guerra fredda”, tra capitalismo neoliberale e capitalismo socialdemocratico, incarnato nei Brics. L’azione contro Charlie Hebdo delle scorse settimane, pur con le sue forti specificità, può essere inserita in questo quadro. Come si configura quindi lo scacchiere di una geopolitica imperiale su cui spirano forti i venti di guerra?
Al seminario di Milano ho cercato di ragionare attorno a questo scenario di guerra diffusa, prendendo lo spunto dal dimezzamento del prezzo del petrolio, che è la conseguenza di una scelta ben precisa da parte dell’Arabia Saudita in particolare. La scelta consiste nel forzare il prezzo del petrolio non diminuendo la produzione, mettendo in difficoltà paesi come Iran, Nigeria e Venezuela che hanno bisogno per funzionare economicamente di un prezzo del petrolio superiore ai 100-120 dollari al barile (per quanto un’economia fondata sul petrolio e sulla monocultura sia tutta da criticare). Dall’altra parte, questa decisione dell’Arabia Saudita – e quindi dell’Opec nel suo insieme – non può non avere effetti destabilizzanti per tutta la produzione del petrolio e del gas attraverso la tecnica della fratturazione. A partire da qui, mi sono chiesto quali fossero le implicazioni geopolitiche, oltre che economiche, di questa strategia da parte dell’Arabia Saudita. Gira l’ipotesi di un asse tra Arabia Saudita e Stati Uniti per fare la festa alla Russia: non ci ho mai veramente creduto e continuo a non crederci. Infatti, il primo aspetto è che il petrolio a questo livello di prezzo sta indubbiamente mettendo in forte crisi le corporation che sono nate negli ultimi dieci anni intorno al fracking, anche le compagnie più grandi, che per il momento hanno bloccato tutti i piani di investimento e stanno riducendo i costi con forti licenziamenti. Non passa giorno che non si senta parlare di riduzione del personale, che peraltro è abbastanza qualificato e ben pagato negli Stati Uniti e non solo, anche in Canada per esempio. È un effetto che non va sottovalutato. Non penso oggi che questa esplosione della bolla petrolifera possa portare a effetti di contagio sul piano dei mercati finanziari, c’è una bella differenza tra la crisi dei subprime e la crisi del settore petrolifero. Penso però che questa operazione dell’Arabia Saudita abbia come primo obiettivo quello di ritornare a dominare il mercato facendo saltare i competitor spuntati negli ultimi dieci anni e che hanno portato gli Stati Uniti all’autosufficienza dal punto di vista del petrolio. Il secondo aspetto per il quale non credo all’asse tra Stati Uniti e Arabia Saudita è l’Iran. Proprio in conseguenza delle politiche di riavvicinamento con gli Stati Uniti, l’Iran – se dovessero passare gli accordi sul nucleare – può diventare un soggetto decisivo in Medio Oriente, cosa che non è assolutamente vista positivamente dall’Arabia Saudita, figuriamoci dagli israeliani, che non a caso vogliono ridiscuterne con gli americani.
Certo, si potrebbe dire che l’operazione sta comportando seri problemi all’economia russa, come si è visto immediatamente con il crollo del rublo e il fallimento di banche importanti, anche a seguito delle misure di boicottaggio da parte dell’Occidente nei confronti della Russia per la sua politica in Ucraina. Io però continuo a pensare che sia più un effetto secondario e collaterale, per quanto possa funzionare per il rafforzamento degli Stati Uniti; ma se così fosse, se l’intenzione era di mettere in ginocchio l’economia russa, non mi sembra una mossa intelligente dal punto di vista geopolitico, e non sarebbe la prima volta per le politiche estere americane degli ultimi anni. Se si pensa che la svalutazione del rublo è stata a più riprese difesa o contenuta grazie agli interventi della banca popolare cinese e della banca centrale indiana, si capisce che uno degli effetti non desiderati, una sorta di eterogenesi dei fini, potrebbe essere proprio il consolidamento del polo Russia, Cina e India.
Partendo da queste considerazioni ho cercato di capire gli effetti di questo cambiamento delle politiche dei prezzi del petrolio. Ho anche detto che lo scenario che a breve si stava probabilmente delineando è di forte tensione, per il fatto che l’Arabia Saudita sta dietro al terrorismo islamico. Ricordiamoci ovviamente che il terrorismo islamico è stato foraggiato anche dagli Stati Uniti, comunque l’Arabia Saudita non ha mai declinato il suo aiuto. Con questo non voglio dire che ci sia un rapporto di causa-effetto tra questa evoluzione geopolitica in corso e i fatti di Parigi, che – come tanti hanno avuto modo di spiegare – rimandano a delle logiche interne alla stessa Francia. Sta di fatto che le cose vanno in quella direzione.
Possono quindi essere inquadrati nel contesto di guerra diffusa che hai descritto?
Esattamente. Io sono il primo a sostenere che questa forma di terrorismo è figlia del degrado delle banlieue, di una situazione senza futuro e disperata per tanti giovani. Continuo a pensare, in termini molto marxisti, che ci sia un rapporto di causa-effetto tra la crisi endemica sociale ed economica delle periferie metropolitane e i comportamenti di insubordinazione. Certo che il fattore religioso è un bel problema, anche da analizzare, però mi sembra che esso rientri in questi ultimi anni di attacco da parte dell’Occidente, in primo luogo da parte degli Stati Uniti, con l’invasione dell’Iraq e dell’Afghanistan. Poi quando si viene a sapere che uno degli attentatori di Parigi si è convertito all’islam dopo aver visto le immagini di Abu Ghraib, ciò la dice lunga sul clima di guerra diffusa. È ovviamente inscritta dentro la crisi economica e finanziaria che sta giocando un ruolo molto pesante nel determinare le premesse di questo tipo di derive terroristiche.
In questo quadro geopolitico si inserisce la questione di un’eurozona che, lungi dall’aver risolto qualcuno dei suoi problemi strutturali, fa i conti con la realtà della deflazione. Si innestano qui due recenti elementi da analizzare. Da un lato le politiche monetarie di quantitative easing annunciate dalla Bce; dall’altro le elezioni in Grecia, con la vittoria di Syriza, di cui bisogna valutare le possibili conseguenze. A inizio gennaio lo “Spiegel”, citando fonti governative, sosteneva che la Germania potrebbe avallare un’uscita dall’euro della Grecia; ciò perché, si dice, non si teme più l’effetto contagio. E se invece fosse il passaggio verso il processo di frammentazione dell’eurozona da te già ipotizzato alcuni anni fa, oltre che ovviamente strumento di pressione contro l’affermazione di Syriza?
La svolta monetaria del quantitative easing, già prevista da tempo e scontata per i mercati, ha sorpreso per la quantità del denaro. I 60 miliardi mensili hanno superato le previsioni, credo che siano stati il frutto di un compromesso tra Draghi e la Bundesbank per aumentarne la quantità; però, secondo i desiderata dei tedeschi, si attribuisce l’80% dei rischi alle banche centrali dei paesi membri dell’eurozona. Se un paese come l’Italia o la Spagna dovesse fallire, la sua banca centrale dovrebbe assumersi l’80% dell’onere del default. Ciò prefigura uno scenario di frammentazione dell’Europa, nel senso che vengono meno le politiche di mutualizzazione dei rischi della stessa unione bancaria che andava in questa direzione. Bisogna quindi intendere il quantitative easing europeo come un tentativo piuttosto disperato di bloccare la spirale deflazionistica e di uscire da una situazione di recessione che si sta protraendo da troppo tempo per la stessa Germania; tuttavia, questa clausola dell’80% di assunzione del rischio dei paesi membri è pesante, perché vanifica la possibilità di agire di concerto in Europa. Come prevedibile, i mercati hanno reagito bene soprattutto per i paesi del sud, ma non in termini straordinari: si pensi che sono diminuiti i rendimenti dei bund, i buoni del tesoro tedeschi, mentre sarebbe dovuto succedere il contrario, cioè un’uscita dei buoni del tesoro per andare sui mercati finanziari e sui titoli azionari, come è accaduto quasi sempre negli Stati Uniti ogni volta che c’è stata un’ingente iniezione di liquidità.
Su questo sfondo, per quanto riguarda la Grecia, i comportamenti in queste settimane di paesi come la Germania e la Francia, oppure di Juncker, sono una forma di terrorismo, sicuramente di ingerenza per determinare l’esito di una votazione che vedeva già Syriza in vantaggio. Il fatto di aver insinuato che un’uscita della Grecia potrebbe non avere conseguenze negative o effetti di contagio la dice lunga sulla determinazione della Troika e non solo di agire pesantemente sulla vittoria di Syriza. Io credo che picchieranno duro, non possono dargliela vinta, anche se da quello che vediamo e dalle dichiarazioni di Tsipras c’è una disponibilità a negoziare, certo in termini avanzati, di dimezzamento del debito, di rilancio di politiche di welfare, di investimenti pubblici. Le posizioni di Syriza sono quelle di una socialdemocrazia avanzata, non mi sembra che ci sia nessuna intenzione di fare più di quello che tutti logicamente pensano sia necessario fare, cioè ridurre il peso del debito sovrano e ridare un po’ di ossigeno al paese, all’economia e alla società, per uscire da una situazione di catastrofe umana.
Non è un caso che molti economisti non particolarmente radicali, in Grecia e non solo, abbiano espresso posizioni di sostegno al programma di Syriza…
Sullo stesso “Financial Times” ho letto vari articoli di un giornalista che interviene sull’eurozona in cui si sostiene che partiti come Syriza e Podemos sono la speranza per l’Europa e per l’euro, siamo a questo punto. La vittoria di Syriza avrà probabilmente degli effetti di svalutazione dell’euro. Nella prospettiva sia del quantitative easing di Draghi sia della vittoria di Syriza, la banca nazionale svizzera ha abbandonato la parità tra euro e franco, perché già aveva dovuto inondare il mondo di franchi in questi ultimi mesi, figuriamoci in caso di un’ulteriore svalutazione dell’euro, avrebbe dovuto stampare franchi in quantità insostenibili per un’economia così piccola. Anche le misure di quantitative easing sono infatti finalizzate a un indebolimento dell’euro per favorire una ripresa delle esportazioni.
Quello che mi sembra si possa dire è che questa politica monetaria in versione europea – che peraltro è stata praticata negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Giappone – anche per quanto riguarda l’entità, dimostra che siamo in una situazione molto più grave di quella che ci viene raccontata. Io credo che la crisi sia non solo molto avanzata, ma anche molto più grave di quanto si dice, perché altrimenti non si riesce a capire come ci si sia potuti mettere d’accordo su questi 60 miliardi mensili. Però, bisogna anche rendersi conto, guardando alle esperienze fatte negli altri paesi che ho prima citato, che le politiche monetarie non convenzionali come il quantitative easing hanno contribuito poco alla crescita del Pil. Secondo dei calcoli fatti da economisti mondiali, negli Stati Uniti il contributo del quantitative easing alla crescita del Pil è intorno allo 0,26%.
Nel terzo trimestre del 2014 si è registrato un aumento del 5% del Pil americano, notizia salutata con un certo entusiasmo dai mercati e da chi preannuncia un imminente uscita dalla crisi. Si inizia a parlare di una ripresa dei consumi, legata a una ripresa dell’indebitamento. Cosa significa secondo te questo dato, ripresa strutturale o drogata?
Bisogna ricordare che l’economia americana cresce normalmente più di quella europea per questioni anche demografiche e per il contributo dell’immigrazione all’aumento delle infrastrutture e delle case. Poi è cresciuta grazie a un forte aumento del debito pubblico, in assoluto il più grande del mondo, il 106% del Pil. C’è stato un forte aumento del debito degli studenti ed è tornato l’indebitamento ipotecario. Chiamiamolo keynesismo finanziario o in altro modo, comunque quelle sono le condizioni che hanno permesso una crescita che si può considerare drogata ma innegabile attraverso il debito pubblico e privato. Non c’è stato quell’abbattimento della spesa pubblica e sociale che la destra ha sempre auspicato, ma non c’è stato nemmeno un miglioramento delle prestazioni sociali, pur senza il taglio comportato dalle misure di austerità in Europa.
Va detta un’altra cosa per capire come potrebbe funzionare in Europa il quantitative easing: è diminuita sì la disoccupazione, ma perché è diminuita la partecipazione della forza lavoro al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione è crollato al 58%, fino a pochi anni fa era ancora al 66%: questo vuol dire che è diminuita la base statistica sulla quale si calcola il tasso di disoccupazione. Se c’è crescita, c’è però anche crescita di una povertà relativa e assoluta, è un aspetto di quella che Obama ha chiamato uscita dalla crisi. L’altra faccia di questa cosiddetta uscita dalla crescita americana attraverso politiche monetarie e finanziarie espansive è l’aumento delle diseguaglianze. Le politiche di quantitative easing rafforzano le attività di tipo finanziario e borsistico, però non hanno effetti di sgocciolamento, cioè questa ricchezza non sgocciola nella società. Sono impressionanti i dati su come è cresciuta la diseguaglianza in questi anni. Dunque, non è solo con le politiche monetarie che si possono rilanciare l’economia, i consumi, la domanda, i salari. Se invece ci si affida esclusivamente a politiche monetarie, quand’anche siano molto espansive, bisogna aspettarsi un forte aumento delle diseguaglianze, perché questa liquidità alimenta un circolo virtuoso sul piano finanziario, che però non si collega con la cosiddetta economia reale.
Quello che descrivi a proposito degli Stati Uniti potrebbe quindi essere l’effetto in Europa delle politiche annunciate dalla Bce?
Io penso di sì. Sono combattuto, perché da una parte credo che sia meglio che ci siano politiche di quantitative easing rispetto a un monetarismo alla tedesca, come c’è stato in questi anni. Non basta più un Draghi che dice di fare “whatever it takes”: ha funzionato per due anni, ma la dimensione linguistica della politica monetaria si è scontrata con i limiti del reale. Il reale è fatto di deflazione, di bassi salari, di povertà, di disoccupazione. Dall’altra parte, però, sono estremamente scettico sulla possibilità di uscire dalla crisi con queste politiche e di imprimere una crescita tale da farne beneficiare la popolazione. Vedo il rischio di un forte aumento delle diseguaglianze, che già sono a livelli stratosferici, e dunque la possibilità di un acuirsi del conflitto sociale. In Italia queste cose sono percepibili, per quanto il problema sia di capire quale conflitto. C’è pure da dire che le politiche di quantitative easing sono un tentativo politico, oltre che monetario, di contenere non solo la deflazione ma anche la crescita dell’estrema destra in Europa, che naturalmente cavalca disagio e malcontento. Lo può fare perché è in una posizione che la sinistra non riesce ad assumere, di rottura di tutto ciò che è Europa, euro, politiche della Bce. L’estrema destra ha buon gioco perché ha questa posizione radicale. Io sono convinto che la spaccatura dell’euro potrebbe essere disastrosa. L’ho vista in passato come possibile, in un certo momento addirittura probabile, poi non a caso alla fine del 2011 Draghi ha deciso di dettare i famosi mille miliardi, e da lì in poi l’euro era riuscito a stare a galla. Eravamo di nuovo arrivati a una situazione simile, si è perciò deciso per una svolta di grande portata. Certo è che se non si applicano delle politiche di redistribuzione del reddito – e io sono convinto che il reddito di cittadinanza sia fondamentale, perché non riesco a vedere come si possa redistribuire il reddito attraverso il rilancio di un’occupazione che sia degna di questo nome –, se in qualche modo non si rilancia un welfare post-liberista, incentrato su forme autogestite, è chiaro che la destra è destinata ad avanzare, non può essere contenuta. Se poi ci si mettono anche i terroristi islamici, il problema è ancora più grosso. Per questo considero la Grecia il paese da cui può rinascere un’ipotesi di Europa diversa, dovremo quindi prepararci a sostenere questa svolta, avviando anche delle politiche di mobilitazione, agitazione, rivendicazione e coordinamento delle lotte che permettano a questo primo momento di rottura della fatale e diabolica politica di stabilità di avere un futuro.
Un nodo che abbiamo iniziato ad affrontare nella scorsa intervista è quello dell’organizzazione. Tu hai parlato anche dello scenario bellico come occasione per pratiche e rivendicazioni transnazionali, in un quadro in cui – come già sottolineavi – l’ulteriore aumento delle diseguaglianze sociali porterà probabilmente alla crescita di forme di conflitto che possono assumere direzioni molto differenti od opposte. Come si possono immaginare delle ipotesi in avanti da questo punto di vista?
Attorno ai fatti di Parigi, tenendo conto di questa configurazione geopolitica di guerra diffusa, mi è sembrato di intravedere delle cose che possono aprire degli spiragli dal basso. L’islamismo estremo ci interpella per esempio sulle questioni del welfare, della povertà, della periferia. Bisogna quindi affrontare un’idea di comune contro le politiche di repressione legate all’austerità e allo smantellamento del welfare state. L’idea di un comune della differenza è particolarmente attuale, perché ci costringe a pensare a come possiamo ridefinire dei percorsi di condivisione nella costruzione del comune. Come si fa a praticare un reddito di cittadinanza? Non dimentichiamo che l’Isis paga un reddito di cittadinanza di 400 dollari ai suoi affiliati. Queste cose mi impressionano, perché in termini materialistici ne vedo la potenza.
Molte organizzazioni islamiche hanno costruito la propria forza e il proprio radicamento innanzitutto sulla questione del welfare…
Esatto, questa è una lunga storia, mentre da noi è avvenuto tutto il contrario. Sta a noi individuare nel concreto, dove viviamo, queste forme di costruzione e pratica di un comune fatto di differenze molteplici, che però permetta di riconquistare degli spazi di vita, qui non possiamo fare altro. C’è molta orizzontalità in tutto questo, la verticalità la vedo nell’attivare politiche di coordinamento su scala europea, però questa volta con la forza di una vittoria anche se solo di tipo elettorale, che permetta allo stesso tempo a questo nuovo scenario istituzionale di tradursi in forme di mobilitazione e costruzione di politiche del comune. In questo vedo degli spiragli di luce, in uno scenario terribile e che, proprio per questo, ci deve costringere a individuare gli elementi che ne sono all’origine. Non si tratta di fare un discorso banale di causa-effetto, ma questa crisi del welfare, voluta e programmata dalle politiche neoliberali e dell’austerità, deve essere colta come occasione per sperimentare dei processi di condivisione dal basso che diano concretezza alla parola d’ordine che da tanto tempo cerchiamo di diffondere del reddito di cittadinanza. Ma come e dove lo costruiamo? Perché non riproporre dentro l’espansionismo monetario l’idea di una redistribuzione verso il basso di questa ricchezza? Nei prossimi mesi avremo di nuovo a che fare con una forte critica della finanziarizzazione, proprio come altra faccia dell’espansione monetaria. Proviamo allora a trasformare il concetto stesso di liquidità in moneta del comune, diamogli quindi contenuti a partire dal rilancio di criteri di uguaglianza. Non c’è uscita dalla crisi senza redistribuzione della ricchezza, è impossibile.
I fatti di Parigi ci rimandano anche a un rischio concreto all’interno della composizione sociale, ovvero a una spaccatura – per semplificare in modo brutale e semplicistico – tra un ceto medio bianco che si ricompone attorno ai valori della République e le periferie che si ricompongono attorno a un conflitto che veste apparentemente i panni della religione. Se, come dicevi tu all’inizio, leggiamo le biografie di chi ha compiuto l’azione a Charlie Hebdo o di chi parte dalle periferie di Londra o Parigi per andare a combattere con l’Isis, ci troviamo proletari delle banlieue, rapper e giovani impoveriti delle metropoli che dovrebbero essere tra i soggetti di riferimento della costruzione di un tessuto di lotte. Tutto ciò ci parla innanzitutto delle nostre mancanze e delle nostre incapacità…
Certo. Lì la religione è un dispositivo di ricomposizione, ed è proprio un dispositivo di ricomposizione quello che noi dobbiamo reinventare. Il processo è indubbiamente andato molto in avanti, quindi non sarà un pranzo di gala. Io immagino che le lotte inevitabilmente ci saranno in questa bolla di ipocrisia che i ceti politici dominanti continuano a gonfiare con la retorica dell’essere fuori dalla crisi, questo non è per niente vero e non lo sarà per anni. In queste lotte, che saranno spurie ed eterogenee, ci sarà una fortissima tensione sul piano della progettualità e delle forme di organizzazione. Sarà un percorso molto duro, che dobbiamo in qualche modo prevedere, anticipare e affrontare con coraggio. Come si fa a trovare un linguaggio comune tra una molteplicità di soggetti che, pur avendo determinati bisogni, hanno però referenti e percorsi biografici così frastagliati, tra quello che è stato licenziato da un’impresa o da una fabbrica e quello che è cresciuto di assistenza? Forse la più grande sfida che ci troviamo di fronte è quella di coniugare odio e pace, o la pace come una forma di odio, che sia il terreno sul quale possiamo parlarci e pensare assieme, per quanto con immaginari, vissuti e ferite sul nostro corpo così diverse.
Il testo fa parte dei materiali dell’ebook “La crisi messa a valore” (a cura di Commonware, Effimera e UniPop), in uscita a breve, che raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Milano il 29 e 30 novembre scorso.

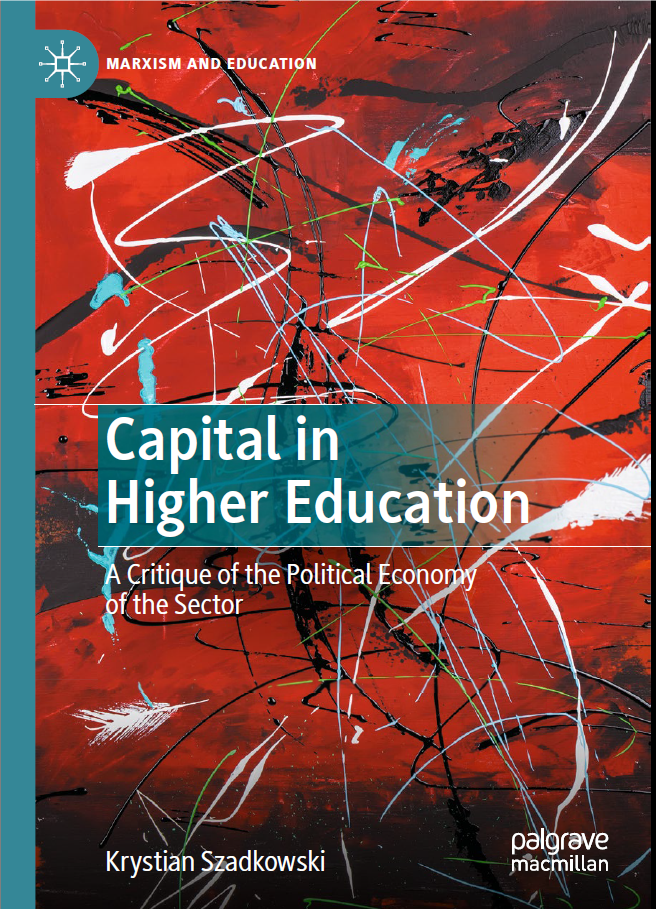





Scrivi un commento