In Italia, il sistema pensionistico pubblico è strutturato, seppur solo formalmente, secondo il criterio della ripartizione.
Ciò significa che i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l’attività lavorativa. Per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve.
È evidente che in un sistema così organizzato, il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi) deve essere in equilibrio con l’ammontare delle uscite (le pensioni pagate).
In Italia, da un lato, il progressivo aumento della vita media della popolazione (fatto di per sé positivo, a meno che non si voglia ripristinare un “Monte Taigeto” di spartana memoria o una “rupe Tarpea” di latina memoria) ha fatto sì che si debbano pagare le pensioni per un tempo più lungo, dall’altro, il rallentamento della crescita economica ha frenato le entrate contributive.
Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme tutte orientate a riportare in equilibrio contabile la spesa pensionistica:
- È cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato anche alla dinamica dei salari reali (cioè al netto dell’aumento dei prezzi al consumo) ma soltanto all’andamento dell’inflazione.
- Sono stati ritoccati i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all’età anagrafica sia all’anzianità contributiva.
- Sono state poste le basi per la creazione di un sistema di fondi pensione complementari, per permettere ai lavoratori (più abbienti) di ottenere una pensione complessiva più adeguata ai loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversificare i rischi di esposizione del complessivo sistema pensionistico a shock di varia natura.
- E, last but not least, si è definite un percorso per il passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo contributivo, ovvero basato sul principio che il livello della pensione che si riceverà dipenderà dall’ammontare dei contributi versati nella carriera lavorativa e in base dell’aspettativa di vita.
- A tal fine si è progressivamente aumentata l’età pensionabile portandola oggi a 65 anni sia per uomini che per donne, con 40 anni di contributi
Nonostante le strumentali preoccupazioni e gli allarmi dell’Ocse, le riforme effettuate garantiscono la sostenibilità economica dell’istituto previdenziale, soprattutto quando il regime contributivo andrà a regime e l’età pensionabile si alzerà sino ad oltre 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne.
Non altrettanto si può dire per quanto riguarda la sostenibilità sociale.
Al riguardo è necessario fare alcune osservazioni :
- La possibilità che un sistema previdenziale contributivo possa garantire un livello di pensione in grado di garantire una vita relativamente dignitosa e sicura dipende dalla regolarità di versamento dei retributivi adeguati, ovvero alla possibilità di disporre un lavoro stabile con un buon reddito
- Attualmente il grado di copertura delle pensioni rispetto agli ultimi stipendi (che si collocava intorno all’80-85% nel sistema a pura ripartizione) è costantemente diminuito sino al 65-70% dell’ultima retribuzione ed è destinato a diminuire ancora man mano che il sistema contributivo entrerà a regime e interesserà una platea di futuri pensionati più ampia.
- Diventa così sempre più necessario ricorrere al cd secondo pilastro, quello dei fondi pensioni privati, favorendo in tal modo il processo di finanziarizzazione (leggi privatizzazione) delle pensioni (e quindi dei redditi da lavoro, visto che le pensioni sono salario differito). Tale possibilità è tuttavia più ad appannaggio di chi può godere redditi più elevati a meno di tagli spontanei e pesanti al proprio tenore di vita (risparmio forzoso). Il risultato è quindi una crescita della polarizzazione dei redditi tra gli stessi pensionati oltre che a livello più sistemico.
Tali dinamiche sono ancor più accentuate da un contesto lavorativo in cui la condizione precaria diventa dominante. In particolare, soprattutto a seguito dell’introduzione del Jobs Act, finalizzato a “istituzionalizzare” la precarietà come condizione “tipica” del rapporto del lavoro, siamo in presenza di una trappola della precarietà.
Questo concetto è già presente nella letteratura economica e sociologica, in particolare nelle attività di ricerca anglosassone, tuttavia con significati differenti.
Una prima definizione descrive la trappola della precarietà come una sorta di circolo vizioso, che porta gli individui a non essere più in grado di uscire dalla condizioni di precarietà a causa dei costi troppo elevati per trovare un lavoro stabile. Fuoriuscire dalla condizione di precarietà richiede infatti di sopportare notevoli costi, simili a quelli che nella teoria d’impresa sono chiamati costi di transazione. Se per quest’ultima, tali costi dipendono dal grado di incertezza (che può favorire pratiche di free riding o di moral hazard, e quindi la ricerca di una soluzione individualistica) e dal coordinamento dell’attività di produzione, per il lavoratore precario si tratta dei costi necessari per compilare le domande di lavoro, la ricerca di un nuovo posto di lavoro, una volta che il contratto precedente non è stato rinnovato o per attivare processi di formazione e apprendimento o per mantenere una certa struttura di welfare, soprattutto in un contesto dove la logica del workfare è dominante. Se tali costi di transizione dalla precarietà alla stabilità risultano eccessivi e non sostenibili, ecco che allora la condizione di precarietà può risultare permanente. Da questo punto di vista, la trappola della precarietà deriva dal fatto che il/la lavoratore/trice precario/a si assume tutti i rischi della propria condizione lavorativa individuale .
Un’altra definizione più ampia, ma collegata, ha a che fare con il fatto che la trappola della precarietà, proprio perché interna a una condizione sistemica di elevata incertezza e rischiosità, è il risultato della mancanza di un’adeguata politica di welfare e di sicurezza sociale. In alcuni recenti ricerche, a partire dalla constatazione che il lavoro precario e flessibile è più diffuso nei servizi avanzati e nelle cd. industrie creative, si sostiene che politiche economiche mirate per questi settori potrebbero essere utili per rivitalizzare l’economia e consentire il superamento della precarietà. Gli strumenti politici esistenti sono per lo più scoordinati ma possono essere suddivisi in quattro categorie: “istruzione e formazione”, “incentivi fiscali e creditizi”, “sostegno alle imprese” e “politiche di sicurezza sociale”, con una maggiore enfasi sulle primi tre. Sfuggire alla trappola della precarietà – esistenza senza sicurezza – tipica di molto lavoro cognitivo, richiede una riformulazione del concetto di flex-security, più adeguata a quelle che sono le esigenze e i vincoli delle industrie cognitive-relazionali e più in generale del terziario avanzato immateriale.
In queste due interpretazioni, la trappola della precarietà può essere evitata se si persegue una politica economica adeguata. Ma se la precarietà è un fenomeno strutturale e generalizzato, ciò non è sufficiente. Ne consegue che potrebbe essere eliminata solo se le dinamiche del mercato del lavoro cambiano drasticamente: la trappola della precarietà rischia di essere fisiologica, soprattutto nel breve termine. È costantemente “alimentata” dalle peculiarità della attività lavorativa esistente, basata sullo sfruttamento delle facoltà di vita e delle soggettività degli esseri umani.
La nostra opinione è che la trappola della precarietà è il risultato dell’esistenza di un nuovo tipo di esercito di riserva industriale. La definizione tradizionale di esercito industriale di riserva si basa sull’idea che la presenza della disoccupazione agisce come una pressione nei confronti degli occupati, riducendo il loro potere contrattuale. È noto il famoso saggio di Kalecki sulle origini politiche della disoccupazione, in cui l’economista polacco sostiene come in un sistema di relazioni industriali è più conveniente per la classe padronale rinunciare alla ottimizzazione del profitto (che porterebbe alla piena occupazione) e creare artificialmente un bacino di disoccupazione, in grado di ridurre il potere contrattuale dei sindacati. Questa tesi ha una sua validità se la distinzione tra tempo di lavoro e non-lavoro (cioè fra occupati e disoccupati) è chiara e precisa, come è stato durante il periodo fordista. Ma oggi, nell’era del capitalismo bio-cognitivo, questa distinzione tende a svanire e la modalità di controllo del lavoro tende sempre più ad essere basato sul ricatto del reddito e sulla individualizzazione dello stesso rapporto di lavoro. Sono questi i fattori che rendono la condizione di precarietà generalizzata e strutturale, oltre che esistenziale. Ed è proprio questa condizione di precarietà, percepita individualmente in un modo diverso, che nutre e definisce il nuovo esercito industriale di riserva: un esercito industriale di riserva che non è più al di fuori del mercato del lavoro ma al suo interno.
Ne consegue che ci sono buone ragioni politiche, a dispetto di qualsiasi dichiarazione pubblica e ufficiale, per mantenere una certa quantità di precarietà come nel periodo fordista non era “conveniente” raggiungere una situazione di piena occupazione (parzialmente raggiunta solo con l’attuazione di politiche pubbliche). La trappola della precarietà svolge oggi lo stesso ruolo svolto nel secolo scorso dalla trappola della disoccupazione: con una differenza, che rende l’attuale situazione ancora peggiore. Infatti, oggi, la precarietà si aggiunge alla disoccupazione con una dinamica anti-ciclica. In una fase di ripresa economica, come è stato nel prima metà dello scorso decennio, prima della grande crisi economico-finanziaria del 2007, i disoccupati tendono a diminuire ingrossando le fila dei precari, mentre in una fase di recessione, come quella degli ultimi anni, avviene l’opposto: i lavoratori e soprattutto le lavoratrici precarie sono le prime che diventano disoccupati, entrando nel limbo degli scoraggiati o dei Neet. In tal modo, continua comunque ad operare il dispositiva biopolitico di sussunzione della forza lavoro, accompagnato dalla crisi dei sindacati tradizionali e dallo smantellamento dello stato sociale.
In questo contesto, un sistema previdenziale esclusivamente contributivo, se è economicamente sostenibile, non lo è socialmente. Vengono infatti a mancare le condizioni sufficienti per garantire un reddito pensionistico dignitoso. La condizione precaria, infatti, a seguito di intermittenza di lavoro e bassa remunerazione, non consente, nella maggior parte dei casi, di garantire un pagamento di contributi all’altezza di una pensione dignitosa.
Nel 2015, alcuni dati al riguardo cominciano a essere noti.
Le prime pensioni erogate sulla base di una carriera lavorativa caratterizzata da contratti di lavoro parasubordinati (collaborazioni varie) pagano un assegno mensile di 175 euro, ben al di sotto della soglia di povertà relativa. Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, riportando i risultati di una recente ricerca Inps, ha fatto notare che un giovane di circa 30 anni di oggi, ipotizzando parte della sua carriera lavorativa in condizione di precarietà (e quindi intermittenza di contributi e di reddito), dovrebbe lavorare sino a una età superiore ai 70 anni per poter sperare di ottenere una pensione di 600 euro mensili.
Il rischio di povertà si è trasferito dagli anziani ai giovani. Il 15% delle persone tra i 18 e i 25 anni in Italia sono già povere, conferma il rapporto dell’Ocse . E la situazione di chi è giovane oggi rischia di essere ancora più difficile in futuro. La pensione di chi è nato nel 1980 – secondo la simulazione Inps – sarà del 25% inferiore a quella che percepisce chi è nato nel 1945 e oggi ha 70 anni, tenendo conto anche del fatto che l’assegno sarà percepito per molto meno tempo.
In altre parole, l’equilibrio dei conti previdenziali di oggi si scaricherà sulla sostenibilità sociale di domani. La trappola della precarietà, oggi sempre più diffusa, si tradurrà in povertà futura.
A fronte di questa situazione che alimenta una futura bomba sociale dopo il 2030, è necessario e imprescindibile porre rimedio ora.
È per questo che alcuni economisti – tra il quale il sottoscritto – ritengono necessario che in Italia venga messa nell’agenda politica in tempi brevi una proposta di reddito minimo di base, con le seguenti caratteristiche:
- individualità dell’erogazione monetaria
- criterio della residenza per definire i potenziali beneficiari
- finanziamento a carico della fiscalità generale e non dei contributi sociali
- massimo livello di incondizionalità possibile
- livello di reddito stabilito in termini relativi e non assoluti (come minimo non inferiore alla soglia di povertà relativa e in linea con il valore mediano della distribuzione del reddito)
- integrazione di reddito inizialmente destinato a chi si colloca al di sotto della soglia di povertà relativa
In tale direzione si muove anche la proposta di Boeri di garantire un reddito minimo a chi si colloca nell’età superiore ai 55 anni (troppo giovane per accedere a una pensione, troppo anziano per essere ricollocato nel mercato del lavoro). Purtroppo tale proposta (che dovrebbe estendersi all’universo dei lavoratori e, soprattutto, delle lavoratrici –sottoposte al doppio carico di lavoro, quello capitalistico e quello domestico di cura) dovrebbe essere finanziata dagli stessi contributi previdenziali, alimentando così un circolo vizioso.
È ora di rendersi conto – come ben evidenzia la trappola della precarietà –che le condizioni attuali del mercato del lavoro non sono in grado di garantire un reddito dignitoso. Per di più, la tendenza in atto – come ben ci mostra il piano Garanzia Giovani e le sperimentazioni legate all’evento Expo 2015 (al cui riguardo, è stato siglato il 23 luglio del 2013 il primo contratto sindacale che permette il ricorso al lavoro gratuito) – favorisce forme di prestazioni lavorative non pagate.
Se non vogliamo trovarci nel 2040 in una condizione sociale preoccupante, con un numero degli anziani indigenti (i giovani di oggi) espolosivo, è necessario muoversi ora. Altrimenti saranno dolori.
* Università di Pavia, Effimera Network, Bin Italia


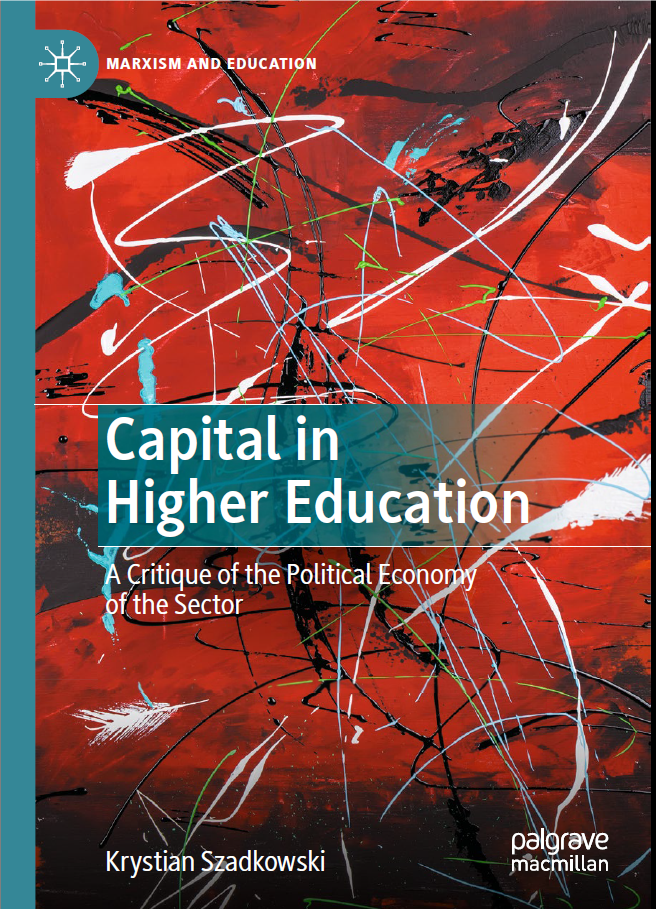





Da far imparare a memoria ed obbligatoriamente a tutti i nuovi aspiranti politici nonché naturalmente a tutti i nostri attuali governanti…compresi i vari sottosegretari alla Zanetti …