Edgar Morin, intellettuale europeo di fama mondiale, autore di opere tradotte in oltre 20 lingue diverse in 42 paesi, di cui oltre 100 edite in italiano, è nato a Parigi l’8 luglio 1921. Morin è il suo nome di battaglia da partigiano, che a guerra finita il figlio dalla diaspora degli ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna dell’Inquisizione Edgar David Nahoum ha assunto ufficialmente nel cognome. Per celebrare il suo secolo di vita e di incessante impegno civile, e in particolare il legame speciale che egli ha da sempre con il nostro paese, ‘patria desiderata’ fin dal dopoguerra, 100 diverse voci italiane si sono raccolte in un omaggio corale, che per la cura di Mauro Ceruti si è tradotto nelle 444 pagine del volume Cento Edgar Morin. 100 firme italiane per i 100 anni dell’umanista planetario (Mimesis, 2021). Condividiamo uno degli scritti, di Peppino Ortoleva.
****
Uno degli aspetti più importanti del pensiero di Edgar Morin, che appare troppo spesso sottovalutato, è l’avere accettato in piena coerenza e in tutte le sue conseguenze la sfida della democrazia: cosa che molti intellettuali dell’ultimo secolo non hanno saputo fare, presi tra le sirene delle ideologie totalitarie e il rinchiudersi nei confini professionali di un ceto ristretto o in quelli mentali delle discipline. La riflessione di Morin sulla cultura di massa è stata ed è parte di quella che possiamo chiamare un’antropologia dei secoli democratici, che ha per perno e per tema centrale un vastissimo processo storico in corso, “l’accesso delle masse all’individualità” di cui parla Lo spirito del tempo. In questa antropologia, l’osservatore ha per Morin una precisa (e democratica fino in fondo) collocazione: deve prima di tutto riconoscersi lui stesso membro di quelle stesse masse. L’intellettuale così definito non è “amico del popolo” per adesione ideologica, ma è parte del popolo: perché tale lo ha reso la storia, e perché la democratizzazione della cultura, al di là dei tanti inganni che può indubbiamente portare con sé, è un processo epocale, irrefrenabile e anche irrinunciabile. Per una simile figura di studioso, è non solo lecito ma normale amare le canzoni, i film, le storie della cultura di massa: non per rinuncia a un atteggiamento critico, ma, al contrario, perché quel suo lasciarsi penetrare emotivo oltre che analitico rappresenta uno strumento anche conoscitivo essenziale.
Proprio questa idea di intellettuale, e questo spirito radicalmente democratico, furono il vero bersaglio dell’attacco violento contro Morin che nel 1963 lanciarono Pierre Bourdieu e il suo allora collaboratore Jean-Claude Passeron: insofferenti verso il concetto stesso di una cultura popolare che travalica le differenze economiche, ma forse più sottilmente ostili a un’altra scelta, quella che nello stesso spirito aveva portato Morin a ripensare criticamente la sua passata appartenenza comunista. L’articolo, Sociologues des mythologies et mythologies des sociologues, apparve sulla “rivista di Sartre”, Les temps modernes, che rappresentava il riferimento principale dell’idea di “impegno” al tempo egemonica. E la proposta formulata dai due autori (in questi espliciti termini) di espellere Morin e i “sociologi del mito” dalla comunità scientifica aveva un tono letteralmente stalinista, quasi nascesse dal bisogno di emetter comunque una scomunica contro qualcuno che, dall’ideologia, dal comunismo, dall’“impegno” nel senso sartriano, si era escluso per sua scelta.
È in Autocritique, apparso nel 1959 tra Les Stars e L’Esprit du temps e più volte ripubblicato, che Morin racconta il suo rapporto con il comunismo, lo attraversa (ha scritto l’autore nella nuova prefazione del 2012) appunto “come un’esperienza antropologica”. Il libro non va visto come un testo autobiografico separabile in quanto tale dalle ricerche sociologiche o epistemologiche. Al contrario, è uno dei testi fondanti di tutto il percorso intellettuale di Morin, parte integrante di quella stessa antropologia dei secoli democratici che stava perseguendo con altre opere. Il titolo non è solo né tanto un gioco di parole. Il libro infatti conduce una critica sistematica e riflessiva del sé comunista, e attraversa tutti i diversi strati di quel sé: l’etica apparentemente rigorosa del noi contro gli altri e insieme le piccole e grandi viltà della vita quotidiana dell’organizzazione, e i tanti compromessi e non detti che furono alla base della duratura egemonia comunista sugli intellettuali “impegnati”; il senso comune determinista che portava a “credere” in una Storia assimilata a una divinità e insieme la flessibilità personale e ideale che veniva richiesta per seguire gli andirivieni di una linea a cui si dovevano dimostrazioni di fede ancor più fanatiche.
È lungo questo itinerario che Morin prende le distanze da quel “razionalismo che non riesce a riconoscere il ruolo immenso che nel mondo hanno i deliri”, per aprirsi all’intreccio di moderno e arcaico, di tecnica e magia, che è una delle maggiori novità introdotte dal libro sul cinema del 1956. Ed è parte dello stesso itinerario la scoperta della complessità dell’essere umano, la possibilità che in una stessa persona possano convivere sotto l’apparente monolitica coerenza “il comunista privato, scettico, chiacchierone, ironico, e quello ufficiale rigido, pronto alla scomunica, wagneriano”. La critica del sé comunista condotta da Morin in Autocritica permette di stare dentro il flusso del cambiamento storico senza idealizzarlo e senza ridurlo a formule, di distinguere un uso truffaldino della dialettica, che anestetizza la logica stessa e permette di sostenere di volta in volta una tesi e quella contraria, da un uso diverso e fecondo: per cui “c’è una verità dell’errore e un errore della verità” e la ricerca non si deve mai accontentare di se stessa. È sempre la critica del sé comunista a dimostrare che una volta “rifiutata la legge di Hegel per cui la storia mondiale sarebbe il tribunale supremo”, il ruolo di giudice ricade sulla propria coscienza.
Se la riflessione sul totalitarismo che si legge in Autocritica è molto diversa da quelle che si trovano in tanti altri testi da Gide a Silone, è anche perché non è centrata tanto sull’oppressività di quel sistema quanto sul fatto che il comunismo è una tra le credenze possibili per l’umanità del nostro tempo, e va sottoposto a un ripensamento (“a partire da sé”) simile a quello che tocca a tante altre credenze, e sogni. La critica del sé comunista condotta in Autocritica non segna quindi solo la fine di un’esperienza, ma anche un inizio: di quella riflessione instancabile sulle potenzialità e sui limiti della democrazia (anche nel campo delle idee, dei miti, delle narrazioni, dei sogni), di cui Morin è tuttora, con Tocqueville, Dewey e pochissimi altri, uno dei più preziosi maestri.







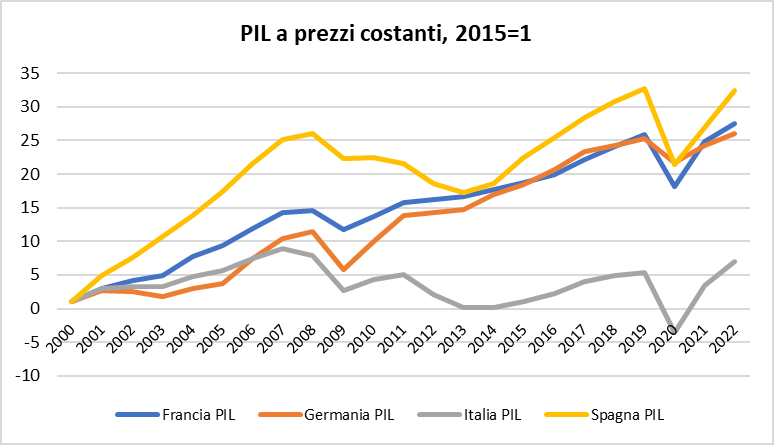
Scrivi un commento