Prima del 1968, la percentuale di giovani maschi iscritti all’università era circa il 7% dei loro pari età. Le donne solo il 2,4%. Oggi, la percentuale maschile è al 32,7% mentre la quota femminile ha superato dal 1990 quella maschile attestandosi a oltre il 44% (dati 2014). Il numero degli studenti è cresciuto dai 450.000 del 1968 (comunque il doppio di quelli del iscritti a fine anni ’50) ai circa 2 milioni di oggi (Fonte Istat).
Prima del 1968, i docenti in ruolo erano poco più di 2.000, mentre oggi, al 2015, sono tra ordinari, associati e ricercatori, 50.354, di cui 12.879 ordinari, 20.043 associati e 17. 433 ricercatori (http://statistica.miur.it/scripts/personalediruolo/vdocenti0.asp).
È insomma evidente che l’università prima del ’68 era un’università d’elite, piccola, chiusa, corporativa, estremamente selettiva per censo e classe di appartenenza. Non a caso solo chi proveniva dal liceo poteva accedervi. La “casta” dei docenti (di casta infatti si deve parlare) godeva, per la stragrande maggioranza, di elevati privilegi e poteri, in un sistema di cooptazione degli ingressi ben preciso e salvaguardato.
Si racconta, ad esempio, che, prima del fascismo (fino al periodo tra le due guerre mondiali), i docenti di alcune università, una volta nominati, ottenessero, contemporaneamente alla cattedra, la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno, magari situato sulle colline. Il termine di “barone” acquisiva così un significato anche “materiale”.
Dopo la liberalizzazione degli accessi universitari, il mondo dell’università cambia pelle e comincia a essere attraversato da fermenti e da trasformazioni sociali, in positivo come in negativo, sino a diventare oggi, in piena economia della conoscenza e dell’informazione, l’esempio più paradigmatico dei nuovi modelli di governance e di controllo del mercato del lavoro tout court e del processo di valorizzazione capitalistica che ne consegue. Se esiste un settore in cui le teorie del New Public Management – un mix di aziendalizzazione privata, distorsione meritocratica, autocontrollo e finanziamento pubblico – vengono applicate, questo è proprio quello dell’università e della ricerca. In questo trentennale processo di snaturamento dell’istituto universitario come istituzione del sapere, tuttavia, mai completamente viene meno la figura del Barone e mai è venuto meno il metodo della cooptazione per entrarne a far parte.
Oggi la categoria dei docenti ordinari (ci limitiamo a questi, perché rappresentano il gradino più alto della gerarchia, dal momento che i professori associati sono ancora in fase di “cooptazione”) non può più essere considerata un tutt’uno omogeneo ma piuttosto un insieme assai differenziato, sulla base della soggettività, degli interessi e della struttura di potere esistente.
A grandi linee, possiamo individuare tre principali sotto-categorie.
Iniziamo con gli ordinari che usano la cattedra in funzione della libera professione, solitamente svolta all’esterno dell’università. Potendosi fregiare del titolo di “prof.” prima di quello di avvocato, medico, commercialista, consulente, ecc, riescono a emettere parcelle più salate vendendo i loro offici. Sono, nella maggior parte dei casi, del tutto “impolitici” (ovvero acritici rispetto alla cultura dominante): il loro principale interesse è che lo status corporativo dell’università non si modifichi.
Possiamo poi considerare quegli ordinari che si limitano a svolgere le lezioni e un minimo di attività di ricerca ma con pubblicazioni non più rilevanti (in quanto già arrivati). Essi partecipano all’attività di gestione dell’università ma con incarichi spesso anonimi e poco importanti, con un approccio più autoreferenziale che altro, con minor o maggiore soddisfazione personale. Di solito non hanno voluto o non sono riusciti a entrare nella cerchia di quei docenti che rivestono ambiti di potere.
Infine, abbiamo gli ordinari che gestiscono, indirizzano e definiscono in modo diretto il potere accademico. Sono costoro quelli che potremmo definire i “baroni” dell’università e sui quali vale la pena spendere qualche parola in più. Dopo un periodo in cui tale figura in seguito all’allargamento e all’incremento di complessità del mondo universitario era leggermente declinata, nell’ultimo decennio, in seguito, prima alle riforme universitarie – in primis l’autonomia universitaria, che ha consentito lo spezzettamento del potere centrale in tanti poteri locali -, poi in seguito ai tagli all’università (che hanno ridotto la torta e non hanno consentito a tutti i commensali di continuare a banchettare), la figura del “barone” è ritornata in auge. Affermare che i baroni oggi nell’università italiana non esistono è una fesseria così come lo è altrettanto affermare che tutti gli ordinari sono baroni.
Ma come funziona oggi la struttura gerarchica nelle università italiane? E come operano i baroni per perpetuare la gerarchia accademica dominante?
Potremmo cominciare con il constatare che sono baroni quegli ordinari che hanno le seguenti caratteristiche:
- hanno incarichi, in quanto membri dei Senato Accademico, come portavoce delle singole discipline, in materia di distribuzione delle risorse relativamente alle assunzioni di ricercatore, promozioni di carriera, concorsi;
- fanno parte, o le gestiscono direttamente, delle commissioni che si occupano della didattica e della struttura dei corsi
- definiscono la distribuzione dei fondi della ricerca.
Per meglio comprendere, immaginiamo un qualunque dipartimento universitario e il suo organo di governo, il Consiglio di Dipartimento, oggi il luogo dove, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico, si prendono le decisioni effettive in materia di reclutamento e di indirizzo di ricerca. La riforma Gelmini aveva abolito le facoltà (e di conseguenza il Consiglio di Facoltà di ateneo) con la scusa di rendere più snello il processo decisionale, una volta avviata l’autonomia universitaria. L’effetto (voluto) era ed è di far dipendere dal bilanci di Ateneo votati dal Senato Accademico anche le scelte di indirizzo della didattica e, soprattutto, della ricerca. A tal fine, per favorire il processo di aziendalizzazione della ricerca, era stato concesso alle università di potersi trasformare in fondazioni di diritto privato, divenendo enti mono commerciali e subentrando nella proprietà dei beni mobili e immobili delle università, aprendo così alla privatizzazione degli atenei.
L’attività del Dipartimento è suddiviso in Commissioni. Di solito, tra queste, le commissioni che contano sono quattro: Commissione Ricerca (che distribuisce i Fondi FAR e affini, di cui il 20% è a pioggia e il restante su criteri di valutazione meritocratica), Commissione Valutazione (che decide tali criteri e qui la retorica meritocratica lascia spazio a pesanti condizionamenti sulla metodologia e i contenuti delle pubblicazioni), Commissione Didattica (che decide la struttura dei corsi e la distribuzione dei crediti), Commissione Reclutamento (che decide quando e come fare i concorsi e a seconda dei punti disponibili, quale tipologia di prof chiamare per nomina o per concorso – ricercatori di tipo A e di tipo B, associati e ordinari).
Non sempre quest’ultima commissione è presente. In alcuni casi, è lo stesso Consiglio di Dipartimento a prendersi l’onere di bandire concorsi o a fare chiamate nominative, ma nella modalità denominata “a partecipazione ristretta”, dove, cioè, solo gli ordinari possono partecipare (se si tratta di bandire un posto per ordinario), allargata eventualmente agli associati (se invece si chiama un associato). La modalità della cooptazione a questo punto è ancor più palese.
I membri di queste commissioni non vengono eletti ma vengono nominati dal Consiglio di Dipartimento con modalità classiche di “cooptazione”, ovvero sono i membri stessi della commissione che designano i propri successori, come in un club privato. Il Consiglio di Dipartimento si limita a ratificare le nomine proposte. Per legge, ca va sans dire, all’interno di queste commissioni sono rappresentati non in modo paritetico le diverse componenti dell’università, studenti, ricercatori e professori, due per categoria. Visto il grado di dipendenza di queste figure da quella più importante – l’ordinario -, è facile capire come la loro presenza sia puramente “rituale”. Inoltre, nonostante gli ordinari siano meno numerosi degli associati, la loro presenza è comunque maggiore, al punto che uno stesso ordinario può essere presente in più commissioni, acquisendo in tal modo un accumulo di potere assai marcato.
La struttura piramidale dell’università è così ben definita. Le modalità delle chiamate e dei concorsi avviene con modalità che oggi cercano, a differenza del passato, di rispettare un certo formalismo (ad esempio, evitare concorsi in cui si presenta un solo candidato) ma che di fatto hanno nella maggioranza dei casi un esito tendenzialmente predefinito.
A queste tre categorie, occorre aggiungerne una quarta. Quella di coloro, prevalentemente associati, che cercano di portare avanti un discorso critico nella disciplina di afferenza. In alcune specializzazioni, decenni fa esistevano “scuole”, ovvero impostazioni di metodo e pensiero, fra loro alternative, che costituivano cordate al proprio interno per garantire la continuità della propria “scuola”. Oggi, la pluralità del pensiero, cioè la possibilità di ottenere rispetto e visibilità anche per le “scuole eterodosse”, in quasi tutte le discipline è morta. Un tempo le posizioni eretiche venivano comunque almeno un poco rispettate, anche se già all’epoca non agevolavano sicuramente la carriera accademica. Oggi, di fatto, non sono consentite. Ne consegue che molti “eretici” delle università italiane, siano essi giovani ricercatori precari o docenti strutturati – che vogliono testardamente e coerentemente sviluppare un pensiero critico – o vanno all’estero (le mete più gettonate sono Parigi e Berlino), o si debbono accontentare di ruoli marginali, dentro l’accademia, e di pubblicare su riviste considerate non accademiche o – bestemmia – “non consone all’oggetto della specializzazione”, perché magari un poco interdisciplinari.
Non sarà un caso che molti di questi associati, pur avendo l’abilitazione a ordinario, non trovano posto in Italia. E non sarà un caso che il pensiero italiano più ricco e innovativo (più assimilabile al Critical Italian Thought che all’Italian Thought tout court) sia sempre stato quello “underground”, non accademico, più noto all’estero che in patria.
Dentro le contraddizioni di questo contesto si spiegano anche gli scontri accesi fra le diverse componenti della struttura complessiva, in ogni caso funzionali all’odierna messa a valore generale della vita e del sapere. La battaglia per la libertà di ricerca coincide allora, ancora una volta, anche con quella per la riappropriazione del “comune” e con la richiesta di un reddito di base incondizionato.
Immagine in apertura: Albero genealogico dei Sanseverino baroni di Càlvera e Duchi di San Donato, a partire da Venceslao Sanseverino, Duca di Amalfi e di Venosa, Conte di Tricarico e Chiaromonte (1355-1403) ASNapoli, Real Camera di S. Chiara, Pretensori di cadetti (serie XXXV), vol. 52, inc. 70. “Supplica di don Orazio Sanseverino dei baroni di Càlvera”, tav. genealogica.







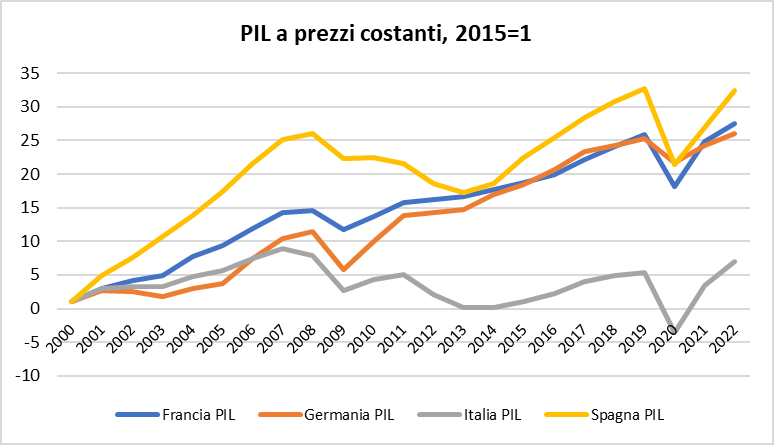
Scrivi un commento